La parola che cancella il confine
Gianpiero Mattanza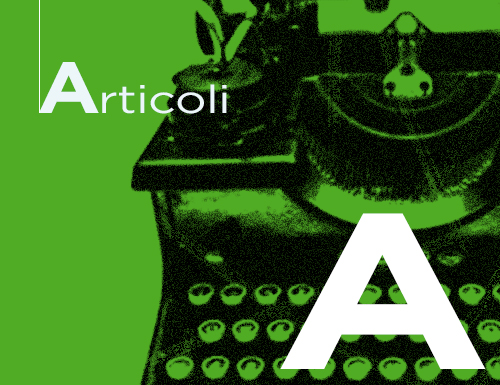
Il Novecento è un pozzo ribollente di stili letterari. Alcuni progressisti, altri conservatori, altri disimpegnati: punti di vista diversi sull’unico grande paesaggio della realtà. Tante sfaccettature di un unico diamante, con approcci e risultati diversi. Tutti rappresentano un limite, un confine oltre il quale incontrare qualcosa di diverso e quasi sempre sconosciuto. Scrivere significa entrare in una dimensione ulteriore. Cosa fa, lo scrittore? Accetta la logorante sfida di portare sulle spalle un’impresa intellettuale in una direzione ignota. Lo scrittore autentico dice cose che nessun altro ha ancora detto o propone qualcosa che è già stato affermato, ma secondo paradigmi inediti. Quando l’Autore diventa (nel freddo di una tenda nel bosco, allo scoppiettìo di un fuoco, oppure davanti al borghese caminetto) un veicolo per qualcosa che viene dall’Altrove, ecco che si dice: «Ce la posso fare; voglio superare il confine». Di fatto, la scrittura è una bellissima ordalìa in cui viene decisa dall’Alto la dignità del giudicato che, umile e docile, si prostra. Superata la prova, ulteriore confine, chi rimane in piedi può iniziare il pericoloso viaggio verso l’ignoto regno del segno scritto.
Tornando al Novecento, confine anch’esso, si può dire sia stato l’unico periodo nella storia a innalzare un totem al relativo, all’arbitrario: un nuovo culto portatore di rovina o, più spesso, delle velleità di ego ipertrofici. Alcuni autori hanno cavalcato l’onda del tutto è possibile. Altri hanno tentato di reagire, andando alla ricerca di una forma estinta, perduta. Altri ancora, semplicemente, sono usciti dalla corrente, dal fiume, per asciugarsi al calore – non scottante: la luce dell’incertezza – di una realtà totalmente reinterpretata. Questi ultimi hanno accettato la sfida posta dalla letteratura, vista come più che vita, senza però scendere a compromessi con le richieste contenutistiche del momento, con mode passeggere. Hanno risposto alla chiamata vergando testi secondo modalità espressive distanti da ogni già visto: sono gli autori del realismo magico, che anche da noi ha avuto una sua rappresentanza, per quanto non radicata come in altri luoghi, per vari motivi (l’Italia non è l’America Latina, con il suo ingenuo vitalismo primordiale). Per fare realismo magico bisogna essere sia immersi sia isolati dalla realtà di tutti i giorni, percepire la differenza profonda tra le cose: una foresta lussureggiante, una vetta, un deserto micidiale. Oppure, e forse più a ragione, vedere tutto questo proprio attraverso la banalità quotidiana, nello squallido gelo di una periferia industriale o sull’asfalto sporco di un quartiere poco raccomandabile. Gli scribi del realismo magico (che spesso non sanno di appartenere a questa élite) giocano a rubamazzetto con la realtà, descrivendone i tratti e le caratteristiche grazie a una lente crepata o, comunque, deformante, accettando in ogni caso il risultato: la realtà si riesce comunque a scorgere, ma l’immagine è irrimediabilmente disturbata, diversa. Spesso lo scriba strappa una vittoria di Pirro, che lo lascia esausto: le immagini descritte sono soverchianti.
Dino Buzzati è in questo ambito il nome tricolore supremo, che torna più di altri alla memoria anche del lettore meno esperto. Uno scrittore, a dire il vero, in parte snobbato dalla critica di casa nostra, che inizialmente lo ha visto come un Kafka dei poveri, degli italioti copioni e testoni, privo dell’originalità che un vero autore dovrebbe dimostrare. Quanto si sono sbagliati! Spesso esterofili e tristemente severi nei confronti dei loro conterranei, definendo Buzzati mediocre alcuni critici “nostrani” si sono presi un abbaglio clamoroso (in questo caso, l’idea di “nostrano” rimanda più al dominio gastronomico di salami ciondolanti da assi rustiche e di capponi regalati ai detentori del potere intellettuale che alla cittadella in cui si difende in modo severo ma appassionato la peculiarità italiana).
Lasciandoci alle spalle le volgarità degli scribacchini della critica passata, presente e futura, ci chiediamo: di chi è quel quadro? Una tela dai colori atipici, dai contorni netti eppure diafani. Sembra che l’ombra abbia un ruolo preciso all’interno della cornice. Quasi non ci sono figure umane: è qualcosa d’indefinito, eppure chiaro… Quel quadro è, neanche a farlo apposta, di Buzzati: una figura enorme – fuori dalla norma – nel panorama artistico italiano. A partire dagli strumenti del mestiere: si ritiene più pittore che autore di testi, benché la scrittura sia di fatto il suo mestiere. È cronista del «Corriere della Sera». Gli piace la cronaca nera, dicono quelli che lo conoscono: e lui non l’ha mai negato. Tutti, però, si ricordano di lui per romanzi e racconti. È vero: chi non collega automaticamente il suo nome a Il deserto dei Tartari o a Il colombre?
Molti lo ricordano come un autore d’altura. In effetti, la sua scrittura ha a che fare con gli spazi aperti (le cime, il deserto, l’oceano), con i confini. Ha bisogno di respirare e guarda l’immensità del cielo sopra le vette e le onde. Perché? Non che Buzzati voglia proporre una nuova epica ai suoi lettori, non ha pretese di questo genere. Vuole più che altro raccontare l’aspetto stravagante e onirico che risiede nella realtà, una sfumatura che si capisce meglio se lo sfondo è teatralmente occupato dalla natura o se il teatro artificiale entro cui agisce l’uomo è reinterpretato attraverso le regole della natura stessa. Un aspetto magico di cui non si riesce a percepire il confine, perché il confine è continuamente superato, colorato con tonalità diverse e anormali. Se un esercito impegnato su più fronti di battaglia è destinato a soccombere in fretta, non è così per l’arte di Buzzati. Multiformi gli scenari, plurimi gli effetti cromatici che affiorano dalla sua opera: in tutti i casi, le creazioni dell’autore stanno ben salde, non scivolano mai nella banalità. E questo è straordinario.
Il bellunese gioca, come già accennato, con il confine: si ritira, con quell’espressione seria che è sua caratteristica somatica, di qua o di là rispetto a una linea, vera o immaginaria. Molte sono le forme che l’idea di confine ha assunto nella sua opera. In primis è bene parlare brevemente delle radici dell’autore. Il padre aveva remote origini ungheresi, la madre era veneziana, lontana erede di quella Repubblica che tanto fece grande, a posteriori, l’Italia. Belluno ha inoltre subito la forte presenza (sperimentata nella concretezza dell’invasione) dell’elemento austriaco: fatto che la rende storicamente città di confine, per quanto oggi sia ben al sicuro aldiquà della frontiera. Probabilmente Buzzati ha percepito la questione etnica ancora “aperta” legata a quel luogo. Uno scrittore, del resto, si chiede quasi sempre da dove viene – forse un po’ meno dove va. Si è diviso tra Belluno e Milano, luogo della maturità, del venire ai ferri corti con il ruolo sociale e i doveri – quella Milano da cui, comunque, si può vedere il Monte Rosa e nella quale è facile volare con lo spirito oltre le guglie in direzione del primordiale utero roccioso della montagna.
Belluno è il luogo atavico per eccellenza, il punto di partenza per un’ascesa, prima spirituale e solo successivamente materiale. L’autore, costretto a vivere a Milano, vi porta una serie d’immagini strettamente legate al luogo d’origine. La fascinazione fiabesca, boschiva e oltreumana offerta dal luogo natale gli dona la possibilità di modificare la realtà cittadina con l’arma del sogno. E questa particolare dimensione si fonde con un altro confine: quello tra orizzontale e verticale, cittadino e rupestre. «Quando ero a Milano, sognavo di arrampicare tutte le notti», dirà in svariate interviste. La sua normalità è ciò che per gli altri esce dalla norma. Il verticale in luogo dell’orizzontale, l’erto al posto del pianeggiante.
Nelle pagine di Buzzati troviamo anche molteplici riferimenti al simbolo del deserto, immenso e quasi ineffabile nella sua silenziosa potenza: è la frontiera atta a orizzontare l’esistenza stessa, che è ma potrebbe non essere. Un deserto, tra l’altro, che è una condizione della coscienza più che una realtà topografica. E che potrebbe designare il discrimine che separa la civiltà dall’assenza di civiltà, il luogo abitato dalla sterminata distesa priva di acqua – e, quindi, di vita. Buzzati sembra volerci dire che la differenza tra queste due realtà è fittizia: il deserto potrebbe invadere le strade della città, rendendo a-civilizzato ciò che prima era toccato dalla mano in apparenza creatrice dell’uomo.
Come non parlare della guerra, citando Buzzati? Nella sua opera è un vero e proprio topos, anche se per lui la Seconda guerra mondiale fu più che altro una questione d’onore, che cercò di vivere fino in fondo aderendo – come molti personaggi della cultura italiana “riabilitati” dall’establishment culturale – alla Repubblica Sociale Italiana. Prima, però, fu inviato di guerra in Africa (ecco, ancora, il deserto) per il «Corriere». La guerra non è un tempo del prima e del poi, quanto – come nella più alta interpretazione tradizionale – qualcosa che dev’essere affrontato impersonalmente, perché “va fatto ciò che dev’essere fatto”. Senza sentimentalismi, fanatismi o eroismi posticci. Alla Buzzati, insomma: uomo inconsciamente ben consapevole del proprio Dharma.
Uno dei suoi racconti più celebri è Il colombre, che narra vicende di mare. Un ragazzino, poi uomo, scappa per tutta la vita da un’enorme e spaventosa creatura abissale, che lo sta seguendo per un motivo ben preciso. Solo nel pieno della vecchiaia, al termine della sua esistenza, decide di affrontare il “fedele” mostro, scoprendo che le proprie convinzioni a riguardo si sono rivelate tragicamente sbagliate. Il confine qui divide la profondità abissale della mente (l’oceano oscuro e freddo) in cui vive l’ambiguità (il mostro marino) da sconfiggere o dalla quale scappare e la placida sicurezza borghese data dalla lontananza dal pericolo e dall’avventura (la terraferma). Il mare è per Buzzati l’altro oltre per eccellenza, che, per sua natura, porta dentro di sé il maggior numero d’incognite. Se la montagna può essere vista come un simbolo virile legato al Sole e alla forza dell’uomo, il mare è il simbolo femminile per eccellenza: oscuro, gelido e mutevole, sottoposto all’influsso della Luna. Un simbolo che può accelerare l’oblio attraverso un’immersione totale. Se della montagna si può vedere la cima, dell’oceano è molto difficile scorgere il fondo. Persino le navi da guerra, che Buzzati imparò a conoscere bene, possono ben poco contro la spaventosa profondità dell’elemento entro cui si muovono.
Come già ricordato, Buzzati fu, a suo dire, soprattutto pittore. Non è forse quello costituito dalla tela un altro confine? Tra realtà reale e realtà figurata, tra mondo e finzione. Un realista magico come lui deve averci senz’altro pensato: qual è la vera realtà? Quella che vedo con i miei occhi o quella che ho dipinto? È una domanda che ogni intelletto acuto si pone guardando un quadro – ad esempio, rinascimentale. Si chiede: il protagonista del quadro, così realistico, mi sta forse guardando in questo momento? Qual è la realtà? Quella che sto vivendo ora ammirandolo o quella che nel quadro è, da secoli, sempre uguale? La risposta non è scontata, e Buzzati lo sa bene.
Sapeva anche di dover strisciare silenzioso tra una moltitudine di detrattori i quali, oltre a livellarlo a Kafka – un gigante, ma davvero distante dal Nostro –, criticavano la sua scelta di utilizzare mezzi espressivi e generi all’epoca eterodossi rispetto al canone formale: ci riferiamo, in particolar modo, a fumetto e fantascienza. Mezzo espressivo e genere che, fra l’altro, sono stati ampiamente sdoganati da anni! Il punto è che in Buzzati non c’era frontiera tra “cultura” e “non cultura”: qualunque vicenda narrasse – anche cronaca nera e sport – era culturalmente degna di nota. Era un re Mida della parola scritta: ciò di cui parlava poteva sempre diventare letteratura. Dicevano sapesse trasformare semplici fatti di cronaca in racconti fantastici e poetici…
La frontiera ampiamente superata dall’autore, infine, è quella tra l’ottusità di chi vuole credere solo a ciò che vede e la sensibilità di chi è certo che esista qualcosa di ben più forte e vero del dato sensibile: è, di nuovo, la differenza tra chi crea e chi ripete, copiando le banalità di qualcun altro.
Il confine, in Buzzati, esiste ma non può essere pienamente compreso: è uno e molteplice, ma è indefinibile, perché l’abilità suprema dell’autore risiede nel cancellare le tracce che porterebbero ad analizzarlo con precisione. Per lui, raccontare la realtà significa inglobare nella narrazione ciò che è apparentemente incompatibile, altro. Vuol dire, in ultima istanza, usare le parole del sogno per raccontare una realtà che di davvero reale ha ben poco.






































