In principio fu il futuro: «Il disco di fiamma»
Piervittorio Formichetti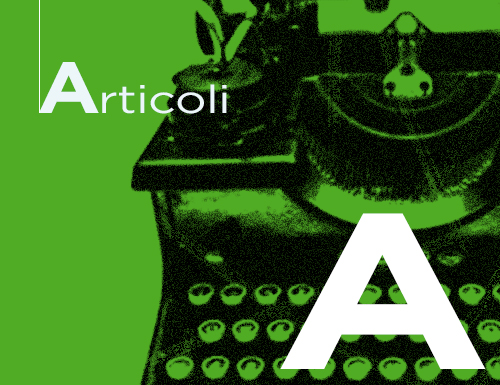
Il nome di Philip K. Dick, una delle massime firme della letteratura di fantascienza, è certamente noto anche a chi – come lo scrivente – aveva soltanto sfogliato qualche sua opera edita nella nota collana “Urania”, dai racconti impaginati a due colonne. Conoscendolo meglio, può risultare un autore “bipolare”, insieme banale e geniale: dialoghi prosaici (nei quali, però, appare talvolta, improvvisa, la frase incisiva) e particolari di pura circostanza (come obbedendo a un tic narrativo, sovente i personaggi si versano liquori o si accendono sigarette) s’intrecciano, anche in modo satirico e surreale, a temi sociali drammatici e ad elementi futuribili e fantascientifici che sottendono concezioni del rapporto tra l’uomo, la tecnologia e lo spazio-tempo ai limiti dell’immaginazione umana. Ciò emerge anche dalle pagine del suo primo romanzo breve, Solar Lottery, del 1955, tradotto in italiano nel 1958 col titolo Il disco di fiamma[1]. Ambientato nell’anno 2203, esso presenta un mondo distopico, talvolta anticipatore di ambigue possibilità politico-tecnologiche che si stanno testando concretamente proprio ai giorni nostri. Dick non le descrive mai in modo completo; vi accenna quasi accidentalmente, lasciando che il lettore le scopra, ne sia sorpreso, a volte scioccato.
La Terra del 2203 è parte di un sistema interplanetario – nove pianeti governati da un Direttorato e organizzati in una federazione –, cosa che implica l’avvenuta colonizzazione umana del sistema solare, il quale ha subìto profondi mutamenti geopolitici: esiste, ad esempio, un Impero Indonesiano con capitale Batavia (nome di Giacarta, sull’isola di Giava, fino al 1945) dove il protagonista, il biochimico Ted Bentley, giunge dalla Francia per farsi assumere da una multinazionale meno corrotta di quella della famiglia Hill. La sua avversione per la disonestà sconcerta il terrestre medio del 2203: «Lo guardavano come se fosse stato un imbonitore. […] Nessuno si era mai lamentato di essere un servo classificato alle dipendenze degli Hill. […] Forse non era sufficientemente realista, o si trattava di una forma di anacronismo che l’educazione ricevuta da bambino non era stata capace di cancellare completamente». Dunque, nel 2203 l’educazione è finalizzata ad atrofizzare nelle persone il valore etico delle azioni, a vantaggio del solo profitto individuale: è chiaramente un’iperbole dell’utilitarismo che caratterizza gran parte della società occidentale postmoderna, già sviluppata negli USA mentre Dick esordiva e, pochi decenni più tardi, approdata anche in Europa, dove peraltro stimolò le critiche (talvolta profetiche) di due pensatori ideologicamente opposti per alcuni versi, affini per altri: Julius Evola e Pier Paolo Pasolini.
Nel 2203, le automobili come la Chevrolet del 1982 e le «antiquate» lampade al neon sono «relitti del secolo precedente», segnato da una «Guerra Finale» cui si allude soltanto. La popolazione terrestre ha attraversato una crisi globale la cui descrizione risulta, purtroppo, attualissima: «La disintegrazione del potere sociale ed economico era stata lenta, graduale e profonda. Era scesa tanto in profondità che la gente aveva perso la fiducia persino nelle leggi della natura. Nessuno sapeva che cosa lo aspettava, nessuno poteva contare su niente. Le predizioni statistiche si erano fatte popolari. La gente non aveva che una speranza: avere fortuna». L’umanità è divisa in due macro-classi sociali: i “classificati”, ossia gli integrati nel sistema dominante, totalmente incapaci di discuterne i princìpi, e i “non classificati”, soprattutto lavoratori manuali, considerati dai primi un ceto inferiore. Entrambe le classi dimostrano le proprie competenze e il proprio status sociale mediante tessere “di identificazione” e “di capacità”, versioni future della carta d’identità e del curriculum vitae, assegnate dal governo a ogni individuo al momento della nascita e sovente oggetto di compravendita illegale. Il cinismo classista intrecciato alla legislazione e alla burocrazia è tale che un datore-padrone può uccidere un suo dipendente “non classificato” senza che ciò sia illegale, mentre per eliminare un “classificato” vige l’obbligo di ottenere un consenso scritto dalla vittima stessa.
I “classificati” hanno in parte perduto la memoria delle proprie origini e la cognizione della natura: è considerato strano che un “classificato” possa credere nelle leggi naturali; si pensa che le proteine non siano elementi presenti nella carne di manzo e nei legumi, ma alghe nate nei mari mediorientali decenni prima; si discute se i datteri siano frutti spontanei nati su Venere, oppure se siano terrestri, ma creati artificialmente. Uno scenario molto simile, insieme umoristico e drammatico, è stato immaginato in Italia da Silvano Ambrogi nel suo romanzo breve Il ritorno degli alberi perduti (1991). Destinato, in particolare, agli adolescenti, non sfigurerebbe nella narrativa fantascientifica tout court e andrebbe riscoperto in questo senso.
In modo allarmante, peraltro, non mancano casi analoghi nella cronaca: a metà degli anni Novanta, una parte dei bambini tedeschi credeva che esistessero davvero mucche viola, come la mascotte di una famosa marca di cioccolata[2]; nel 2017, qualche milione di statunitensi ignorava che un hamburger è composto di carne, e pensava che il latte al cioccolato derivasse da mucche color cacao[3].
Ma proseguiamo nella descrizione di questo mondo futuro. Accanto ai periodici cartacei, nel 2203 esistono “giornali automatici”, quotidiani sonori che girano tra la gente annunciando con voce stridula le notizie: una surreale “evoluzione” degli “strilloni” caratteristici della prima metà del Novecento. Il talento artistico è dimostrato dalla sua applicazione agli annunci politici e pubblicitari nella televisione tridimensionale, che proietta immagini in 3D nelle case degli spettatori, i quali cambiano canale passando la mano davanti allo schermo: qui Dick sembra quasi aver previsto gli attuali touch-screen e le più recenti proiezioni olografiche.
Il Direttorato di governo, un organismo planetario politico-militare di controllo totale, monitora le menti di tutti mediante una polizia formata da uomini ereditariamente telepatici, col compito di intercettare il pensiero (cosa possibile se non vi è un’eccessiva distanza fisica tra intercettato e intercettatore) e identificare gli individui, esaminando documenti sia “classici” sia fanta-futuri: i certificati di nascita e “di psicoanalisi”, la “dichiarazione di fedeltà”, le impronte digitali e i marchi tatuati sull’avambraccio dei “non classificati”; un’idea, quest’ultima, che Dick potrebbe avere elaborato ricordando sia il numero tatuato sulle braccia degli häftling, i prigionieri dei lager nazionalsocialisti, sia il marchio della Bestia anticristica sulla mano di «grandi e piccoli, ricchi e poveri, senza il quale nessuno poteva comprare né vendere», di cui parla il tredicesimo capitolo dell’Apocalisse.
Qua e là, gli “impiegati robot” di marca McMillan svolgono diversi servizi: esaminano le tessere “di identificazione” e “di capacità” nell’azienda di Batavia in cui Bentley si candida; ricoprono funzioni di cameriere, guardarobiere o maggiordomo; sono controllori su un aereo intercontinentale e assistenti di laboratorio, facchini all’aeroporto, tassisti e infermieri, persino sorveglianti armati di fucile nel palazzo sede del Direttorato. È inquietante osservare come alcuni di questi settori siano quasi gli stessi in cui oggi si sperimentano le possibilità dell’“intelligenza artificiale” e degli androidi (ad esempio, le “commesse robot” impiegate in alcuni centri commerciali a Pechino di cui ha parlato il TG1 il 27 giugno 2021). Ma il tema è molto antico, se si pensa al mito greco delle giovani assistenti d’oro create dal dio Efesto (Omero, Iliade, canto XVIII) e ai Golem della tradizione cabalistica ebraica, insieme alle leggende che ne derivano[4].
Analogamente, le anomalie naturali con cui si apre il romanzo (le cornacchie bianche, la caduta di pietre sferiche su Marte, la nascita di un vitello bicefalo) e il fatto che la società le interpreti come presagi di eventi molto importanti possono trarre spunto da fatti strani più o meno attendibili registrati dall’antichità fino al secolo del Barocco (ma anche oltre, se si pensa ai numerosi casi raccolti da Charles H. Fort nel suo Libro dei Dannati)[5]: alcuni autori, da Giulio Ossequente (IV secolo)[6] al celebre medico del Cinquecento Ambroise Paré, «stabilirono relazioni tra nascite mostruose ed eventi politici»[7]. Per esempio, nel 1516 a Tettnang, in Germania, videro la luce due gemelli, ognuno con tre gambe e una prominenza sferica sul ventre, ritratti in un’incisione da Hans Burgkmair[8]; appena un anno più tardi, a Wittenberg, Martin Lutero accese la miccia del Protestantesimo.
Tutto ciò può indicare (come nota, ad esempio, Paolo Riberi)[9] che Philip K. Dick risulta un autore originale nel suo genere perché tra le sue fonti, più che i temi “classici” della fantascienza – come la massiccia presenza di extraterrestri, le guerre interplanetarie e il conflitto tra esseri umani e macchine senzienti –, si trovano numerosi testi e temi risalenti a un passato anche lontano, tra cui alcuni riferimenti ai Vangeli gnostici e all’esoterismo asiatico e occidentale; Emmanuel Carrère, nella biografia dickiana intitolata Io sono vivo e voi siete morti (1993), ricorda che lo scrittore americano consultava regolarmente l’I Ching, l’antico Libro dei Mutamenti del Taoismo cinese, anche per stabilire lo sviluppo della trama dei propri racconti.
Ma l’aspetto più pazzesco della società globale del 2203 immaginata da Dick è il metodo di avvicendamento politico al vertice. Esso dipende da una vera e propria lotteria che prevede l’estrazione casuale – a Ginevra, nella storicamente neutrale Svizzera – del nome del massimo detentore del potere politico-militare mondiale. Solo l’urna girevole, metafora della Sorte («rota volubilis» è detta nella celebre canzone medievale O Fortuna, dei Carmina Burana), decide chi sarà il Quiz-master, il Padrone del Gioco: così, almeno in teoria, ci si «protegge dagli incompetenti, dagli sciocchi e dai pazzi. Siamo totalmente al sicuro: niente despoti e niente idioti». Davanti a un busto di plastica del Quiz-master in carica, in ogni azienda del mondo, ciascun neoassunto recita un giuramento di fedeltà, come un vassallo nei confronti del dominus feudale o un mafioso di fronte al proprio capo. Il Quiz-master uscente, da parte sua, convoca sistematicamente la Convenzione di Sfida per far assassinare il nuovo Quiz-master, tramite un killer scelto a maggioranza dalla popolazione e annunciato pubblicamente in televisione. Per moltissimi tra i “classificati”, nei quali è stato abolito ogni senso etico, questo micidiale gioco geopolitico è un evento mediatico emozionante.
Nel nostro caso, al Quiz-master uscente Reese Verrick succede Leon Cartwright, seguace del vecchio scienziato-filosofo John Preston, sugli studi del quale egli progetta lo sbarco umano sul pianeta Sol, detto Disco di Fiamma, situato oltre l’universo conosciuto e quasi totalmente ignoto. L’auspicio di Preston si concretizza in un’astronave pilotata da «un negro enorme», il capitano Groves (omonimo del generale statunitense Leslie Groves, che disegnò la base del Pentagono e autorizzò l’uso della bomba atomica contro il Giappone nel 1945), con a bordo un campione di lavoratori e studiosi “non classificati” di varie nazionalità, pionieri dell’esplorazione del Disco di Fiamma destinati a costituirvi una nuova colonia umana.
Ma Verrick non si lascia spodestare; la Convenzione di Sfida stabilisce quindi chi dovrà uccidere Cartwright: sarà Keith Pellig, uno strano uomo d’aspetto debole ed esangue «come un mollusco appena uscito dalla conchiglia». In realtà, Pellig non è che un umanoide artificiale nel quale, tramite un macchinario sofisticato, Verrick e il suo complice Herbert Moore trasferiranno, ciascuna per pochissimi minuti, le menti di ventiquattro uomini intelligenti (compresi Moore e, contro la sua volontà, Bentley), affinché uccida Cartwright, sfuggendo alla polizia telepatica: «Ogni mente ha una strategia completa, sviluppata. Ma nessuno sa quale sarà la mente che la sostituirà, né quando. Così i telepatici non sapranno mai cosa sta per fare il corpo di Pellig».
Riusciranno nei loro intenti, così diversi, Verrick e Cartwright? Naturalmente non sveliamo il finale de Il disco di fiamma. Invitiamo a leggere questo romanzo, breve ma intenso e incisivo, in cui Ted Bentley, a un certo punto, pone una questione tutt’altro che superata o anacronistica: «Che si deve fare, in una società corrotta? Bisogna forse obbedire alle leggi, pur sapendo che sono ingiuste?».
- Cfr. Philip K. Dick, Il disco di fiamma, tr. di Laura Grimaldi, Mondadori, Milano 1958, ristampa nella collana “Urania”, 11 gennaio 1970. Tutte le citazioni del racconto sono tratte da questa edizione.
- Cfr. «Il Giornalino», 19 luglio 1995.
- Cfr. Oltre 16 milioni di statunitensi pensano che il latte al cioccolato venga da mucche marroni, in www.tpi.it/esteri, 16 giugno 2017.
- Cfr., ad esempio, Matteo Assistiti, La robotica nei miti dell’antica Grecia, in www.homologos.net/, 2018-2019; Gianni Pilo, Sebastiano Fusco, Il simbolismo kabbalistico del Golem, in Gustav Meyrink, Il Golem, Newton & Compton, Roma 1994.
- Cfr., ad esempio, Louis Pauwels, Jacques Bergier, Il mattino dei maghi, tr. di Pietro Lazzaro, Mondadori, Milano 1971, p. 165 ss.; Mike Dash, Al di là dei confini, tr. di Lidia Perria, Corbaccio, Milano 1999.
- Cfr. Giulio Ossequente, Prodigi [Prodigiorum Liber], a cura di Paolo Mastandrea e Giacomo Gusso, Mondadori, Milano 2005.
- Rudolf Wittkower, Allegoria e migrazione dei simboli, tr. di Marcello Ciccuto, Einaudi, Torino 1987, pp. 113-116 (anche per altri casi di “mostri come presagi”).
- Cfr. Jurgis Baltrušajtis, Il Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, tr. di Fulvio Zuliani e Francesco Bovoli, Adelphi, Milano 1993, p. 83.
- Cfr. Il risveglio di Neo. L’esoterismo di Matrix, presentazione dell’omonimo libro sul canale Youtube di “AXIS Mundi”, 4 maggio 2022.






































