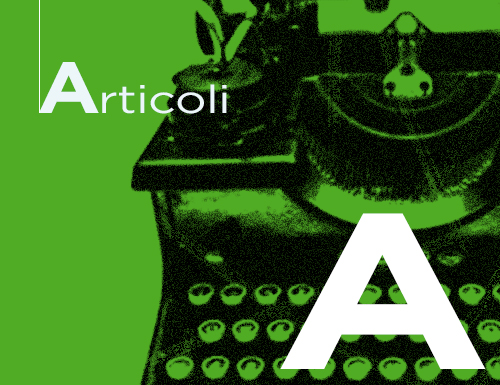
Coralità e contemporaneità, queste le linee guida di un’opera che arriva al cuore della questione verdoniana, dopo che lo stesso autor-attore – con Grande, grosso e… Verdone (2008) – ha chiuso i conti con le strutture a episodi di titoli imperniati sul mattatore unico (o quasi), su situazioni al limite dell’astrazione, su topoi indelebili della propria vis tragicomica.
Coralità, dunque, a beneficio di un andamento drammaturgico a più voci dove il protagonista – padre Carlo, di cui Verdone veste l’abito sacerdotale – diviene co-protagonista, giustapponendosi a figure che dallo sfondo avanzano verso la ribalta, condividendo con lui il proscenio. Sulla scia di Compagni di scuola (1988), Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992) e Ma che colpa abbiamo noi (2003) – non a caso titoli cui l’artista, che definisce il proprio cinema corale quello «che mi è venuto meglio», è particolarmente legato – Verdone costruisce situazioni di gruppo (l’acme è la “cena dei cretini” a casa Mascolo, con escalation di comicità da situation comedy in un continuo sistema di campi-controcampi scompaginato dalla detonazione dei proiettili) e interscambi funzionali (i ribaltamenti morali che investono prima la moldava Olga – da “badante acchiappasoldi” a “donna innamorata” – quindi sua figlia Lara, da “sexy ingannatrice” a “madre coraggio”), distribuendo le responsabilità narrative sulle spalle di caratteri connotati con tratto deciso e interpretati con timbro marcato, caricaturale, da Anna Bonaiuto, Marco Giallini e Laura Chiatti.
Contemporaneità, quindi, seguendo il doppio binario dell’aggiornamento tecnologico (dopo la dipendenza da telefoni cellulari di Il mio miglior nemico [2006] e la schiavitù da telecamere e selfie di Grande, grosso e… Verdone, qui è la chat erotica a fungere da detonatore degli equivoci sull’identità di Lara) e dell’affresco socio-antropologico. «Il quadro è questo: una emigrata moldava – leggi: una grandissima paracula – si sta mangiando tutto il nostro patrimonio. Tutto chiaro? Papà, l’hai visto, è uscito di testa. Ha i capelli color pannocchia, sembra un clown»: Bea, in veste di voce narrante a beneficio dello spettatore, riassume la situazione al fratello Carlo di ritorno dalle missioni in Africa. Immigrazione, circonvenzione di anziani a opera di donne più giovani dell’Est Europa senza remore e con tanto bisogno di soldi, velleità affettivo-sessual-dinamiche dei suddetti anziani: il campionario dei luoghi comuni – ma se sono comuni, un motivo ci deve essere – è incarnato dalla leader carismatica della famiglia Mascolo. Famiglia che, per inciso, è a dir poco disfunzionale e si presenta al pubblico come compendio vivente delle storture – per dirla con Zygmunt Baumann – dell’odierna società liquida. Eccoli, i loro del titolo: il pater familias, in piena follia da terza giovinezza, ha i capelli arancio («Ti sei fatto il parrucchino color mandarino»), sfumacchia le canne e sfida le coronarie a colpi di Viagra e samba con la procace Olga («Ma questa è ’na badante!»); la nipote inizia incarnando la deteriore sottocultura “emo” («Dorme?», chiede Carlo; «Soffre», risponde Bea) e finisce seguendo la carnevalesca moda manga; il fratello single, cocainomane spudorato, è uno speculatore finanziario; la sorella è un’isterica psicanalista divorziata («Maurizio vive in Umbria con una svedese di trent’anni», e la liquidità evolve allo stato gassoso), dedita al recupero crediti familiare, priva di qualunque consapevolezza affettiva («Il ruolo della stronza, dell’intollerante, qualcuno se lo deve prendere, no? Va bene, me lo prendo io») e marchiata dall’immancabile, rinnegato passato sessantottino («Eccola, l’amica del popolo, che appena le toccano le sue cose rimanderebbe tutte a casa con un foglio di via»).
E alla fine arriva Lara (e Lara), a incarnare il pregiudizio come disvalore su cui poggia l’intero film: bellissima, disinibita in chat, leggera nel quotidiano (l’ubriacatura in discoteca) eppure profonda come nessun altro in questa accozzaglia di animali sociali. Lara si adatta, vive di espedienti, raccatta quel che trova, ma sopporta qualunque peso e (pre)giudizio per poter permettere, un giorno, al figlio Michael (il cui padre, ça va sans dire, è scappato a gambe levate) una vita insieme, decorosa e piena.
Infine ecco Carlo (Io, Verdone): il Gallo cedrone (1998) che toglieva il velo alle passanti arabe per rimorchiarle ora è un padre missionario, che in Africa salva vite e all’Africa vorrebbe tornare («A me manca tanto l’Africa. Ma mooolto, me manca!») dopo aver assaporato i (dis)piaceri della società (in)civile. Carlo si muove sul crinale tra realismo sociale e comicità, riflettendo (sul)le criticità di un’immigrazione e un’accoglienza scriteriate (alla fine, per togliere dai marciapiedi le tre amiche nere, tornerà con loro al Paese d’origine), regalando perle di umorismo imploso (la mobilità facciale di Verdone, qui, supera le sfide di ogni close up) e soffrendo in momenti di rara malinconia, durante i quali fanno capolino in sottofondo World Citizen. I Won’t Be Disappointed (David Sylvian, Ryuichi Sakamoto) e una colonna sonora soffusa, rara, episodica, altrimenti assente in controtendenza con l’attitudine verdoniana. Carlo è il mezzo di contrasto attraverso cui leggere la contemporaneità in cui è immerso e, al contempo, è un uomo in crisi. In crisi di fede, di vocazione, come ribadisce durante una riunione in curia. «Forse è questo, l’esercizio spirituale che ti serve», suggerisce padre Giulio, per il quale la bontà delle fettuccine non ha controvalore spirituale. Però ha ragione: Carlo ritrova la fede proprio a contatto con un mondo di cui non fa (più) parte. Che aiuta, in ottemperanza al proprio ruolo e nonostante goffi capitomboli, ma dal quale fugge a missione compiuta.
Io […] e Lara, inizialmente acquasanta e diavolo (il saggio montaggio alternato del prologo depista a dovere, con lui che torna pacatamente dall’Africa e lei che si spoglia, irresistibile, di fronte alla webcam), sono persone in perenne ricerca e, come spesso (non sempre) accade nel cinema verdoniano, chi cerca, alla fine, trova. L’epilogo armonico, con consolatoria riunione del nucleo familiare finalmente bonificato e intento a festeggiare il Natale – video-chattando con Carlo, in una redenzione estesa anche al medium – non fa che ribadire l’importanza degli affetti, delle fondamenta di questa nostra società liquida. E la didascalia conclusiva («Dedicato a mio padre Mario», scomparso il 26 giugno 2009) chiude un cerchio che, da cinematografico, si allarga per diventare privato e autobiografico.
CAST & CREDITS
Regia: Carlo Verdone; soggetto: Francesca Marciano, Pasquale Plastino, Carlo Verdone; sceneggiatura: Carlo Verdone, Francesca Marciano, Pasquale Plastino; fotografia: Danilo Desideri; scenografia: Luigi Marchione; costumi: Tatiana Romanoff; montaggio: Claudio Di Mauro; musiche: Fabio Liberatori; interpreti: Carlo Verdone (padre Carlo Mascolo), Laura Chiatti (Lara Vasilescu), Anna Bonaiuto (Beatrice Mascolo), Marco Giallini (Luigi Mascolo), Angela Finocchiaro (dottoressa Elisa Draghi), Sergio Fiorentini (Alberto Mascolo), Olga Balan (Olga Vasilescu), Marco Guadagno (padre Giulio); produzione: Laura Fattori, Jim Shamoon, Mario Zvan per Blue Sky Films, Warner Bros.; origine: Italia, 2010; durata: 112’; home video: dvd Warner Bros., Blu-ray Warner Bros.; colonna sonora: Warner Bros.






































