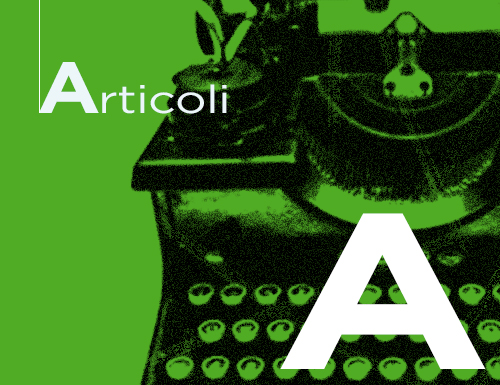
Negli abissi siderali, ai confini dello spazio esterno, un ascoltatore distratto proveniente da chissà quale mondo alieno attivò la sua ricetrasmittente e udì questo messaggio, ampiamente distorto dallo spazio-tempo: «La folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori, siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima della Coppa del Mondo. La situazione è invariata: Italia uno, Cecoslovacchia uno. Reti di Puč al 26° della ripresa, pareggio di Orsi al 36°… Bzzz! Puč che vediamo zoppicare leggermente, Puč che non arriva sul pallone… Bzzz! Palla a Meazza, ecco Meazza scattare! Supera la metà campo… Scatta la nostra ala… Palla a Schiavio… Bzzz! Schiavio entra in area, è solo… tiro, rete!». A questo punto, non sapremo mai se il misterioso ascoltatore spaziale spense il ricevitore o continuò ad ascoltare la radiocronaca della finale di Coppa del Mondo che si disputò a Roma il 10 giugno del 1934, di fronte a cinquantacinquemila spettatori entusiasti (per la cronaca siderale, la partita terminò con la vittoria dell’Italia per due a uno). Ma noi terrestri, a differenza dell’ignaro astronauta alieno, conosciamo molti dettagli di quell’evento straordinario. A esempio, quel giorno la radiocronaca (allora la TV non c’era) diffusa dall’EIAR, la nuovissima ed efficiente rete radiofonica voluta dal regime fascista, progenitrice della RAI, era affidata ad un giovane cronista palermitano, Nicolò Carosio, l’inventore della famosa formula «Quasi gol!».
Vi sembra un remake in salsa italica e un po’ autarchica del film Contact, quello con Jodie Foster del 1997? No, certo che no. Il fatto è che il calcio, o meglio il pallone, come lo si chiama da sempre nei bar, nelle sale d’attesa delle stazioni, all’edicola o dal barbiere (straordinario esempio di salotto anti-intellettuale in via d’estinzione), è da più d’un secolo lo sport nazionale del Belpaese. Già, perché l’Italia ha un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, trasmigratori e, verrebbe quasi da dire, di calciatori.
Il calcio come fenomeno di massa e assieme emblema d’un patriottismo vissuto sull’onda emotiva e travolgente della vittoria sportiva? E perché no? Dopotutto, noi italiani siamo sempre pronti a infervorarci per la squadra del cuore, cantando a squarciagola l’inno nazionale allorquando i nostri beniamini s’apprestano a difendere i colori nazionali. Fin qua nulla di strano, direte, niente di cui non si sia discusso a più riprese e con i più diversi accenti – ora polemici, ora di commiserazione, di critica, di benevola complicità. E in effetti, se si guarda al fenomeno calcio in maniera superficiale, parrebbe esagerato conferirgli una valenza culturale e – diremmo – antropologica di grande rilievo. Eppure le cose stanno proprio così. Questo sport ha valenze assai più profonde di quanto si possa immaginare. Vi è insito uno spirito di gruppo, un senso d’appartenenza di grande intensità. L’uno come parte d’un tutto, d’una comunità, d’un clan tribale capace di generare una straordinaria forza di coesione. È come se uno spirito d’identità s’impadronisse del cuore e della mente dei tifosi, cementando una sorta di alleanza in vista delle future vittorie sui campi di gioco.
Una specie di moltiplicatore di Patrie, insomma, di comunità dal retaggio guerresco. Un luogo ideale intriso di passione, in cui ognuno è libero di trovare il suo casato d’appassionato misticismo sportivo. Eh sì, perché sul quadrato di gioco si celebra, è bene dirlo, un rito ancestrale, un rito basato su uno scontro. Certo, si tratta d’una lotta simbolica regolata da precise regole, in cui il fair play dovrebbe farla da padrone (anche se purtroppo non sempre è così…). Una bandiera, cento vessilli, cori, urla, inni… Un orgasmo di passioni incentrate sull’esaltazione quasi mitica della forza e del coraggio del campione, moderna personificazione dell’eroe classico. E l’Italia dei “mille campanili” ritorna a signoreggiare sugli spalti, in area di rigore, zona inviolabile e sacra in cui si decidono i destini dello scudetto.
Certo, il calcio serve a unire o a dividere, talora cagionando lotte che di sportivo hanno ben poco. Si può anche dire che è un fenomeno pop di portata planetaria, con un’estetica, un linguaggio e una poesia particolari. Eppure, in fin dei conti, rimane un mistero fatto di cuoio colla forma di sfera, che rimbalza, vola e… finisce in rete. Una cosa che meraviglia ed è difficile comprendere in termini razionali. Come spiegare allora la sua magia? È qualcosa d’innato l’amore per il dribbling, il passaggio o il traversone? Chissà. Forse aveva ragione Borges quando diceva: «Ogni volta che un bambino prende a calci una palla ricomincia la storia del calcio».
Dopo tutto non ci dovrebbe meravigliare, come s’immagina nell’apertura di questa introduzione, il fatto che un giorno, magari tra un secolo, in una regione sperduta dell’universo qualcuno possa ricevere un’antica trasmissione radio dalla Terra. Un messaggio che non parla di guerre, d’inquinamento, effetto serra o globalizzazione selvaggia. Magari quel qualcuno non lo capirà, la strana forma di linguaggio gli sembrerà astrusa e misteriosa. Non riconoscerà la voce di Carosio mentre grida la sua frase fatidica: «Quasi gol!».
Ed eccoci giunti al momento che tutti stavate aspettando, quello della narrativa. In effetti, l’angolo del racconto (niente male come titolo, vero?) è oramai un appuntamento immancabile su «Antarès». Anche in questa occasione abbiamo lanciato la nostra sfida a diversi autori di provato talento. Ma, prima di proseguire, vale forse la pena soffermarsi ancora un poco sul tema scelto. Ora, noi di «Antarès» siamo piuttosto noti per l’originalità degli argomenti affrontati, per le proposte ardite, insolite e, perché no, intriganti. Ma questa del calcio! È un tema difficile, un’autentica sfida in punta di penna. Sicuro, di pallone ce ne intendiamo, noi italiani. Lo si sa bene; di football siamo tutti tecnici ed esperti… Ma se vi dicono di scrivere di calcio cosa rispondete? No, non stiamo neanche parlando di cronaca sportiva (che poi non è neanche tanto facile farne una…) ma di narrativa. Inventarsi una storia sul pallone.
Due autori hanno deciso di raccogliere la nostra sfida: Giorgio Ballario e Donato Altomare. Superga è il titolo evocativo scelto da Altomare per il suo allucinato e magnifico racconto, che rievoca una tragedia mai dimenticata dello sport. Una narrazione in chiave surreale che si prefigura come un tributo fantastico e tragico alla memoria del Grande Torino. I Fantasmi di Tilcara è invece il racconto che ci regala la penna arguta e dal timbro epico di Giorgio Ballario. Un riuscito mix narrativo giocato su due piani – sportivo e storico – che s’intersecano. Ambientato sui picchi andini, dove due compagini agguerritissime si giocano (è il caso di dirlo) il proprio destino, I fantasmi di Tilcara è un fedele affresco, e assieme un appassionato ricordo nostalgico della grande utopia argentina.






































