Un deficit linguistico
Adriano Monti-Buzzetti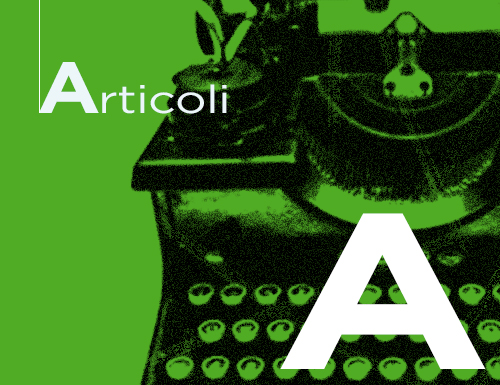
Antonio Filleni arrivò in paese che l’estate già declinava. La corriera semivuota lo lasciò sul piazzale deserto e ripartì sgarbatamente in sgommata, descrivendo un ampio semicerchio che alzò una nuvola di foglie e polvere. L’uomo fece un sospiro e si avviò con le due borse di cuoio verso il centro del piccolo borgo montano, sospinto da una fredda brezza che s’incuneava nei vicoli, spazzando le pietre annerite da fumi secolari. Come molti viaggiatori per necessità, anche Antonio Filleni era mosso da una segreta e tenace speranza; anelava infatti a ritrovare la salute, compromessa in modo particolarissimo e inspiegabile da una rara infermità che lo aveva colpito mesi prima. Il problema si era annunciato discretamente, quasi in sordina: prima con una manciata di vocaboli dimenticati qua e là, poi con qualche pausa di troppo durante le sue lezioni universitarie, che i sorrisetti maliziosi e spietati degli studenti non avevano mancato di sottolineare. Piccoli cedimenti che aveva trattato da principio con noncuranza, addebitandoli alla cronica spossatezza di ferie troppo a lungo rimandate e alla tirannide di un lavoro in cui da anni si spendeva senza risparmio.
Da un giorno all’altro, però, la malattia era esplosa in tutta la sua gravità: intere frasi dei suoi discorsi venivano sostituite da altre affatto inappropriate al contesto in cui le esprimeva. All’eloquio forbito che l’aveva reso celebre in ateneo si sovrapponevano, con frequenza crescente, le rozze espressioni dialettali ascoltate da bambino durante le vacanze estive dai nonni, gente semplice ed illetterata come tutti gli abitanti del remoto villaggio in cui avevano trascorso la loro intera esistenza.
Ma il cambiamento più significativo non riguardava la forma, quanto piuttosto il contenuto di ciò che l’austero professore andava dicendo. Accadeva che, mentre il suo cervello elaborava un giudizio sull’epistemologia genetica di Piaget, dalla bocca gli uscissero – con un fluire inconcepibile per lui, che del vernacolo della terra d’origine conosceva solo poche parole – indicazioni su come far coagulare il caglio del latte vaccino, o sul legno migliore per intagliare un mestolo da cucina.
Da una settimana all’altra, poi, l’inconveniente si era venuto aggravando in modo ancor più sconcertante. Le rustiche espressioni perdevano terreno nei suoi discorsi per essere rimpiazzate a loro volta da un mutismo testardo, oppure, sempre più spesso, da suoni inarticolati che sembravano imitare goffamente rumori quali lo stormire delle fronde, il soffio del vento o il gorgogliare dell’acqua.
In preda alla disperazione, il malcapitato docente decise di prendersi un anno sabbatico, dedicando tutto il proprio tempo alla ricerca di una cura. Sfruttando la propria rete di conoscenze, contattò i migliori specialisti: psicologi, neurologi, foniatri e quant’altro di meglio e di costoso la moderna medicina potesse mettergli a disposizione, senza però venire a capo di nulla. Dopo ogni consulto, il luminare di turno allargava le braccia, oppure, per sbarazzarsi dello scomodo paziente, gli prescriveva terapie dai nomi roboanti che in cuor suo Filleni già sapeva inefficaci.
Uno solo in questa schiera di elette intelligenze si mostrò sufficientemente interessato al suo dramma da spingersi ad abbozzare un’ipotesi di cura, per quanto bizzarra ed azzardata. Si trattava del dottor X, che a quel tempo nella città di Y aveva acquisito una certa notorietà per aver risolto due o tre casi clinici particolarmente complessi.
Quando un pomeriggio si presentò da lui, Antonio Filleni, l’elegante scapolone di mezza età un tempo coccolato nei salotti più mondani, era ormai irriconoscibile: la barba incolta e i capelli arruffati gli conferivano una pietosa aria da clochard, il cappotto stazzonato gli cadeva goffamente sul corpo smunto, quasi fosse un vecchio tappeto. Le pupille arrossate ardevano di una speranza inespressa, mentre il luminare sfogliava senza dire una parola il faldone di referti e analisi che il nuovo paziente gli aveva portato.
Esasperato da quel silenzio intollerabile Filleni cercò di parlare.
«Allora? Cosa posso fare?» provò a chiedergli, ma ciò che il dottore udì fu: «Ẑentoẑeste de ẑeulemarẑe». Ovvero, «cento ceste di cipolle marce», uno scioglilingua appreso sulle ginocchia del padre di suo padre e inventato da uomini ormai morti. Filleni impallidì e tacque. Oltre la sagoma degli occhiali da presbite calati sul naso aquilino, due occhietti acuti e freddi lo fissarono. Finalmente il dottore si degnò di parlargli.
«Un caso davvero singolare, direi praticamente unico» fu la sentenza. «A tutta prima l’avrei classificato come una particolarissima forma afasica: il costrutto verbale è spesso alterato e c’è un grave deficit nell’elaborazione dei messaggi linguistici. Nell’afasia di Broca sono presenti casi rari e complessi, per non dire misteriosi, in cui il paziente perde la sua abituale inflessione assumendo un accento straniero che prima della malattia non gli era affatto familiare. Ma qui si va oltre. Ci troviamo di fronte ad una patologia a due stadi, in cui l’italiano corrente viene prima sostituito da arcaismi etnici sedimentati a livello subcorticale, dopodiché questi vengono rimpiazzati da forme ancora più basiche di espressività primordiale, del tutto simili a suoni e rumori…»
Filleni lo interruppe. Quasi urlando per la disperazione, ripeté la domanda per lui fondamentale, che ancora una volta risuonò come: «Ẑen-to-ẑes-te-de-ẑeu-le-ma-rẑe!».
Il dottore sembrò comprendere il senso della sua richiesta, e andò dritto al punto.
«Premesso che ci troviamo nel regno dell’assoluta sperimentazione, la terapia che mi sentirei di consigliarle è una sola: tornare nei luoghi che la sua patologia sembra evocare e risiedervi per qualche tempo, tentando un approccio psicolinguistico regressivo che riattivi la memoria semantica…»
Il luminare parlò ancora, ma Filleni non lo ascoltò più; per la prima volta dopo mesi non gli pioveva addosso l’ennesima ricetta medica con farmaci dai nomi astrusi o richieste di analisi bizzarre, ma un consiglio semplice e concreto che riaccese in lui un barlume d’inconfessabile fiducia. Pagò la visita, tornò a casa, riempì un paio di valigie e il mattino successivo era già in viaggio verso le sue montagne.
S’installò alla meglio nella casetta in pietra dei nonni, ormai semidiroccata, e nei giorni successivi cercò di familiarizzare con gli abitanti del paese, pochi e tutti variamente anziani. Tra quei volti rugosi ne riconobbe uno che lo intenerì: era Leonello, il garzone che a lungo aveva accompagnato suo nonno sugli alpeggi, per aiutarlo nella pastorizia. Spesso da ragazzino aveva visto quei due allontanarsi verso le cime in estate; qualche volta era riuscito anche ad andare con loro, e quando certe pendenze troppo aspre fiaccavano la sua resistenza infantile, le spalle aitanti di quel giovanotto erano sempre pronte ad accoglierlo.
A lungo le comari avevano insinuato fosse un altro figlio di suo nonno, nato fuori dal matrimonio, ma a riprova di ciò c’era solo la grande sintonia che legava i due ed il tempo che passavano insieme su in quota. Era di parecchi anni più grande di suo padre, ricordò Antonio; ma lui era mancato ai suoi cari già da molto tempo, mentre quel vecchio robusto se ne stava lì come una quercia piantata sull’uscio di casa, intento a riparare un basto con tale concentrazione che il destino del mondo ed il suo intero significato sembravano dipendere da quell’attività.
L’uomo alzò gli occhi, e l’altro sentì risalirgli in gola la paura mordace della malattia, quel morbo sconveniente che lo rendeva incomprensibile ed oggetto di scherno.
«Cosa gli dico?» si chiese.
Ma l’altro lo anticipò, aprendo la grossa mano in un gesto di saluto con la confidenza informale di chi si è congedato il giorno prima.
Filleni prese coraggio e provò a parlare: con sua grande sorpresa, ciò che disse aveva un senso. Indipendente dalla sua volontà, la voce che gli sgorgava dal profondo modulava in dialetto parole di rammarico: chiedeva scusa per il ritardo, per essere arrivato lì solo al tempo della desmontegada, quando a fine stagione si abbandonano i pascoli e le mandrie vengono ricondotte in paese. Leonello sorrise e gli porse una sacca con dentro pane e formaggio. Quindi, con un cenno, lo invitò a seguirlo.
Andarono e tornarono dagli alpeggi, ancora ed ancora.
I giorni divennero mesi, o almeno così sembrava ad Antonio Filleni. Seguì Leonello per casolari e malghe, lo aiutò a badare alle vacche nella stalla e a preparare il burro nella casera, raccolse erbe aromatiche e preparò il foraggio delle bestie col maggengo, lo sfalcio agostano e il terzuolo.
Tornò la primavera, quindi l’estate. Una vera e propria conversazione tra loro era ormai cosa rara: preferivano restarsene in silenzio e lasciare che fossero le montagne a riempire tutto, anche quello che volevano dirsi l’un l’altro.
Passò ancora altro tempo, finché un giorno che Antonio se ne tornava solo dai pascoli, Leonello non si trovò da nessuna parte. Provò a cercarlo a casa sua, che mai gli era apparsa così diruta e in rovina; bussò ed entrò nella cucina al piano terra, lo chiamò fischiando tra cumuli di pietre ed assi divelte, ma lui non rispose. Allora si recò all’unico bar del paese e chiese di lui ad un capannello di anziani che indugiava pigramente attorno ad una partita di briscola.
Gli lanciarono un’occhiataccia: Leonello se n’era andato al Creatore vent’anni prima. Così almeno gli dissero alcuni, mentre altri giurarono che un tale Leonello, a memoria loro, in quei luoghi non fosse mai esistito.
Se ne andò quasi barcollando, sopraffatto dalla tristezza e dalla confusione. Fu allora che sentì la voce, mentre arrancava senza meta nella parte più vecchia del villaggio, tra le mura superstiti di vecchi abituri frequentati solo dai corvi. Quella voce era simile a gocce d’acqua – la rara e quasi impercettibile tonalità che associava a Leonello, ma forse anche a tutto ciò che avesse mai contato per lui. La seguì, verso le ultime case e poi fuori dall’abitato, lungo il sentiero che attraverso un fitto bosco di conifere s’inerpicava in alto.
L’Om Selvadegh che lo attendeva, con i verdi capelli arruffati e la barba coperta di muschio, non lo sorprese più della vista del larice a cui l’irsuta creatura delle leggende alpine se ne stava appoggiata. Gli sorrise con un’infinita saggezza sovrumana, mettendo in mostra denti bianchi come fiocchi di neve, e Antonio comprese allora il senso di quei brindisi davanti al fuoco con cui da bambino aveva visto rudi uomini delle montagne da tempo defunti augurare a quell’essere la buona salute, onorandolo come un amico prezioso ed assente.
Poi l’essere tornò a parlargli nella lingua che Antonio, e solo lui, aveva udito come uno scroscio di pioggia invisibile giù in paese: l’antico idioma che viveva nascosto in eterno dietro ed oltre il dialetto locale, ormai superfluo come la vuota crisalide di un insetto.
Ne ebbe la prova un istante dopo, quando cercò di dire «Bòn dì, Leonello» e dalla sua bocca uscì un suono garrulo, simile al cinguettio di un pettirosso. L’Om Selvadegh rispose con un suono inesprimibile, che non era dei viventi ma della Montagna di cui era un’emanazione, ed Antonio capì perfettamente cosa stesse dicendo. La sua malattia era ormai incurabile, e lui era finalmente guarito.
L’essere voltò le spalle lanose e lui, senza esitazione, lo seguì verso le cime lontane, ammantate di rosse nubi crepuscolari.
«Il tramonto è solo un’alba al contrario» rifletté mentre s’incamminava. Fu l’ultimo pensiero di Antonio Filleni che un cervello umano avrebbe potuto comprendere.






































