Testimonianze su Dino Buzzati
Luca Siniscalco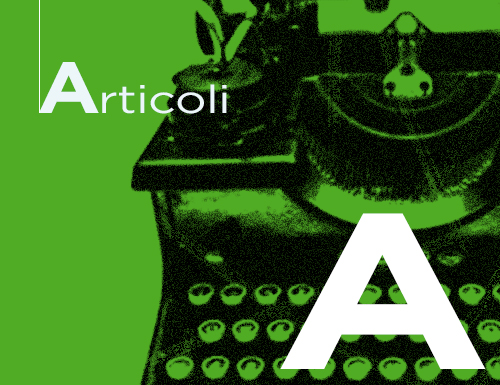
Studiare un autore – così, almeno, insegna l’ermeneutica filosofica, oltreché la viva curiosità tipica degli avventurieri dello spirito – significa anche studiarne gli effetti (e le interpretazioni). Proponiamo dunque una selezione di alcuni scritti d’intellettuali che sull’opera di Buzzati – e sulla sua persona – si sono interrogati a fondo. Le riflessioni di Sergio Antonelli, Emilio Radius, Riccardo Bacchelli, Giuliano Gramigna, Franco Di Bella e Indro Montanelli sono tratte dal volume di ricordi Il mistero in Dino Buzzati (a cura di Romano Battaglia, Rusconi, Milano 1980). Il testo di Jorge Luis Borges, da noi tradotto, è invece la prefazione alla collana da lui diretta, con la collaborazione di María Kodama, Biblioteca personal. Il nono volume della collana, introdotto dal presente testo, fu proprio El desierto de los tártaros (Hyspamérica, Buenos Aires 1985). La stima di Borges era peraltro contraccambiata da Buzzati, che, pur non apprezzando gli aspetti più “cervellotici”, intellettualistici e labirintici della sua prosa, ne amava le intuizioni letterarie. In particolare, L’Aleph: «Lì ci sono vari racconti straordinari. Proprio molto belli» ebbe a commentare intervistato da Yves Panafieu.
Luca Siniscalco
1. Sergio Antonelli: «Lo specchio dell’onirico»
Buzzati si impose in pieno realismo, verso la prima metà degli anni Quaranta, e segnò una svolta nell’ambito della letteratura italiana. La sua narrativa, lontana dal tempo e dallo spazio tradizionalmente concepiti, ha un carattere prettamente allegorico, pervaso di fantastico, quel “fantastico” buzzatiano che permette di vedere le cose e analizzarle attraverso lo specchio dell’onirico, del fiabesco e del sogno. L’opera di Buzzati rimane completamente estranea a qualsiasi corrente e stile letterari. Non riusciamo a trovare nessun autore che ricalchi i suoi caratteri.
2. Emilio Radius: «La vita, che cos’è?»
Dino aveva un carattere molto complesso: da una parte semplicissimo come quello di un bambino, dall’altra cupo e taciturno come uno che nasconde qualcosa dentro.
Infatti, non faceva mai pesare agli altri tutti i suoi dolori, le sue pene, le sue ansie, i suoi dispiaceri. Si teneva tutto per sé.
Aveva una visione dolorosa della vita, eppure con gli amici era allegro e gioviale, come se quello spettro che aveva dentro non esistesse.
Aveva molta paura della solitudine, perché rimanere solo significava per lui rimanere solo con i suoi dolori, con i suoi incubi.
Io sono stato suo amico per cinquant’anni e di Buzzati conosco molte cose segrete, ma non il suo mistero.
Era un uomo che poteva essere sereno, felice. Apparteneva a una famiglia molto perbene, benestante, e non aveva avuto un’infanzia difficile. Non so proprio da cosa nascesse la sua ansia.
Aveva avuto una madre dolcissima, che lui adorava, aveva due fratelli molto intelligenti e comprensivi. Non so proprio da dove venisse quella fatica di vivere, quel peso della vita, quella paura della solitudine.
Forse la sua angoscia dipendeva dal vuoto religioso, dalla mancanza di fede che cercava e non riusciva a trovare. Si chiedeva: «La vita, che cos’è?». Aveva più paura della vita che della morte. E infatti è morto con molta dignità, con molta serenità. Diceva: «È tutta la vita che scrivo sulla morte e posso permettermi di averne paura». Se n’è andato in punta di piedi.
3. Riccardo Bacchelli: «Buzzati e il mare»
Nessuno, dopo la morte, ha ricordato una cosa curiosa di Dino Buzzati. Hanno parlato dello scrittore, del pittore, dell’uomo appassionato alla montagna: non mi pare si sia parlato di Buzzati e il mare.
Il mare compare nella sua vita in un momento terribile: quello della guerra. Nell’ultimo conflitto mondiale Dino Buzzati fece il corrispondente di guerra a bordo di un’unità della nostra marina ed i suoi resoconti furono talmente precisi e documentati da farlo apparire come un uomo che per tutta la vita aveva vissuto in mare e che del mare conosceva tutti i segreti.
Leggendo le sue corrispondenze, mi sembrava di essere lì davanti al nemico, fra il correre dei marinai, il fuoco dei cannoni e l’innalzarsi delle onde.
4. Giuliano Gramigna: «Realtà della fiaba»
Quando nel 1972 Buzzati morì, la letteratura italiana era già smorzata, anche quella della neoavanguardia sessantottesca.
Ha senza dubbio lasciato molte strade aperte e percorribili, ma, fino ad ora, non battute da altri. Per usare un’espressione “colorita”, diremo che Buzzati è stato un “anomalo” nella nostra letteratura, la quale, da sempre, privilegia una ricerca creativa critica, sia strutturale che formale. Buzzati fu invece uno spontaneo e considerava l’immediatezza con un certo sospetto. La sua è una letteratura da post-romantico impulsivo, fatta di due attimi essenziali: l’ingenuità, l’immediatezza condiscendente ai luoghi comuni della sua epoca; la complessità e l’intricata immaginazione dello stile.
Inoltre, il suo essere vagamente cattolico lo rendeva inquieto e nel suo racconto Il cane che vide Dio vi è una parabola della religiosità: strana, onirica, fiabesca. La fiaba era una delle sue grandi passioni; l’instabilità della realtà apparente lo eccitava, gli suggeriva immagini di sogno come porte aperte e richiuse. Buzzati non ha letterariamente influenzato nulla che sia venuto dopo di lui.
Ci rimane una realtà addomesticata dalla sua narrativa: la morte, l’amore, i dubbi, le debolezze; tutto è ridotto al fiabesco per lenire quanto vi è di più straziante nell’esistenza. Affabulazione dell’angoscia, esorcizzazione del male: nel fiabesco, nell’onirico consistono la sua originalità e la sua grandezza. Porre la realtà in sogno è un meraviglioso compromesso per meglio tollerare ciò che è un vero tormento.
Oltre il sogno c’è l’ignoto: un muro invalicabile, senza tempo e senza spazio, su cui Buzzati ha lasciato il dubbio.
5. Franco Di Bella: «Milano by night»
Ho “usato” Dino Buzzati (oppure, più precisamente, l’ho “usufruito”, come era solito suggerire il vecchio amministratore del «Corriere» Giuseppe Colli, sempre preoccupato che i dipendenti dell’azienda non lavorassero abbastanza), ho usato, dunque, Dino Buzzati come cronista per circa dieci anni, dal ’62 fino a poche settimane prima della sua morte.
Buzzati veniva dalla cronaca, non dimentichiamo che fu proprio nel grande monacale stanzone dei cronisti al primo piano di via Solferino che creò il favoloso mondo del Deserto dei Tartari, scrivendovi poi quelle mirabili pagine nei vuoti del servizio di notte.
Al principio degli anni Sessanta era al culmine della sua fama, le sue opere venivano già tradotte nelle lingue di mezzo mondo. Più che un vezzo, quel voler tornare a fare il cronista, dietro le mie insistenze ripetute, fu forse per lui un ringraziamento al destino per la buona sorte professionale che quello stesso destino gli aveva elargito. Come cronista fu esemplare: aveva, oltre tutto, la dote dell’umiltà, che oggi, purtroppo, manca alla stragrande maggioranza dei giornalisti.
Una sera gli chiesi di trascorrere cinque ore come osservatore del viaggio nella Milano by night che l’Autostradale organizzava a quel tempo per i turisti. Tornò l’indomani, elettrizzato e divertito: «Non immagini» disse, «la magnifica notte che ho trascorso, con quaranta giapponesi. Ho visto cose che non pensavo ci fossero a Milano». Scrisse un pezzo delizioso.
Pochi giorni dopo lo inviai in una casa della casbah di Porta Genova, dove avevano scoperto in un armadio il cadavere di una donna strangolata. Gli altri cronisti di “nera” impiegati nel servizio mi riferirono più tardi che aveva scritto l’articolo in piedi sulle scale, poggiato al muro, umilmente in coda insieme agli altri curiosi del palazzo, vergando parola per parola sul suo quadernetto. Tornò al giornale, ricopiò l’articolo. «Mi pareva di essere Edgar Allan Poe» mi disse l’indomani. «Sapessi come mi piacciono queste cose, non immagini neppure.»
Coi pompieri, coll’uomo di notte della volante, cogli addetti dell’obitorio, coi segugi della squadra omicidi, con le ronde della buon costume, con i vigili urbani, Dino Buzzati continuò fedelmente a registrare la vita più o meno segreta della Milano di quegli anni ruggenti.
L’ultimo servizio fu quello per la rivolta di S. Vittore. I detenuti asserragliati nel vecchio carcere avrebbero dovuto essere snidati alle sei del mattino dalle forze di polizia e dai carabinieri, dopo una notte drammatica in cui avevano persino impiegato l’olio bollente per bloccare gli assedianti. Svegliai Buzzati alle tre di notte, pregandolo di scendere, che di lì a poco sarebbe passata una macchina a prenderlo. Andò a S. Vittore alle quattro e mezza del mattino, modesto e puntuale come sempre, e scrisse un articolo memorabile. La prima parte era dedicata al risveglio della città, con note così acute, dolorose e penetranti che parevano contenere il presagio della sua fine vicina.
6. Indro Montanelli: «La voce del silenzio»
Buzzati venne a Cortina, e per alcuni giorni non mi telefonò, com’era solito fare appena arrivato. Andai a cercarlo io, e quando lo vidi compresi il motivo di quella renitenza. Sapevo che da un pezzo non stava bene, che doveva prendere gli antibiotici per tenere a freno la febbre, che non mangiava quasi niente. Ma non immaginavo di trovarlo in quello stato, pelle e ossa, appoggiato a un bastone. Mi scrutava nell’ansia di cogliere sul mio volto un’espressione di sgomento, che spero di essere riuscito a mascherare. Ma non mi fece domande, né mi consentì di fargliene.
Fu la nostra ultima passeggiata, e non la dimenticherò più. Dino, che tante volte mi aveva lasciato ansimante a mezzo di un’erta per sfrecciar via con il suo passo leggero, ora non riusciva a seguire quello mio. Veniva avanti tastando il terreno, e io dovevo inventare ogni sorta di pretesti per fermarmi ad aspettarlo. Ogni tanto volgeva intorno, inquieti e sospettosi, i suoi piccoli luccicanti occhi da scimmia, e tendeva l’orecchio come a cogliere un fruscio, che lui solo percepiva.
Era il fruscio della morte, come lui l’aveva sempre immaginata e descritta con la penna e col pennello. Tutta la vita Buzzati ha vissuto abbracciato a lei, l’ha chiamata, l’ha invocata, l’ha tentata, l’ha cercata. E ora, eccola, senza un’ombra, un bisbiglio, un presagio, a tallonarlo, a incalzarlo, per nascosti avvolgenti sentieri. E lui lo sentiva, e sentiva che anch’io lo sentivo. Ma non ne parlava, e non mi permetteva di parlarne. […]
Invano, nelle settimane che seguirono, cercai di ribellarmi a quella specie di congiura, chiedendo, investigando, frugando. Invano due volte affrontai di petto lui stesso con un risoluto: «Senti, Dino…». Sotto il mio sguardo, tra l’interrogativo e il proibitivo, mi fermai, e di quella congiura finii per accettare la complicità. Non voleva saperne. Non voleva che qualcuno disturbasse quel suo giuoco a rimpiattino con la morte, che lo atterriva e affascinava. Gli stessi dottori si erano adeguati: ma forse, vede, eventualmente, certo, speriamo, ehm. […]
Era un amico e un collega straordinario, vero, semplice, modesto, incapace di un’invidia e di una meschineria, un giornalista innamorato del proprio mestiere e pronto per esso alle fatiche più umili, di cronista e d’impaginatore, anche quando i più autorevoli giornali stranieri avanzavano la sua candidatura al premio Nobel. Ma irraggiungibile nella sua banchisa di solitudine. Buzzati non vi si rifugiava di proposito, per spregio o diffidenza degli altri. Anzi, non chiedeva di meglio che evadere da quella sua prigione, e spesso ci provava. Ma non ci riusciva. Anche quando si dava o credeva di darsi, anche quando si metteva a nudo e candidamente denunciava, senza sospettare che tali fossero le proprie debolezze o storture, in Buzzati restava sempre qualcosa di inaccessibile e segreto, segreto forse anche a lui, un’ultima spiaggia di impossibile approdo a chiunque. Non si poteva non amarlo. Non si poteva amarlo senza sentirsene come defraudati. […]
Spiegare Buzzati a Buzzati era un’impresa disperata, perché si rifiutava di parlare di se stesso e del proprio lavoro. Glielo impediva l’eleganza, che ha rappresentato la vera etica della sua vita. Buzzati era la negazione dello snobismo. Detestava la cosiddetta “società”, non ha mai preso parte alle sue sagre. Anzi aveva un debole – lui, così fine e delicato – per la volgarità, forse confondendola con la vitalità. Ai salotti preferiva le balere di periferia. […]
Della morte Dino aveva terrore e orrore. Era fedeltà a una sua etica, o per meglio dire a una sua estetica militare da Marcia di Radetzky. Per chissà quali ancestrali richiami (era di Belluno) aveva il culto della caserma e dei suoi rituali. Perfino in un lavoro come quello nostro di giornalisti, casuale ed estemporaneo, portava l’ordine, lo scrupolo, lo zelo, la puntualità dell’ufficiale di picchetto, ma sempre con una cert’aria di noncuranza. Dove lo mettevano stava, fosse pure di guardia al bidone. E così ha voluto stare – sciarpa a tracolla, guanti infilati, sottogola abbassato – nell’ultimo cimento, senza chiedere aiuto, e rifiutando quello che noi gli porgevamo. Per eleganza. […]
Se n’è andato così, alla Buzzati, come alla Buzzati potrebbe anche ritornare. E pure questo troveremmo del tutto naturale, come una delle sue tante magie o l’ultimo giuoco del suo umorismo nero. Perché se un qualcosa c’è al di là di noi, nessuno se l’è guadagnato più di Buzzati, che ha trascorso la vita a captarne i messaggi e a decifrarli per noi. Ora può darsi che sia lui a lanciarcene qualcuno. Ma come faremo ad afferrarlo? Solo grazie a lui l’Ineffabile ci parlava. Ed è proprio questo che con lui ci viene a mancare. Con Buzzati se ne va la voce del silenzio, se ne vanno le fate, le streghe, i maghi, gli gnomi, i presagi, i fantasmi. Se ne va, dalla vita, il Mistero. E che ci resta?
7. Jorge Luis Borges: «Biblioteca personale»
Nel corso del tempo, la nostra memoria va formando una biblioteca spaiata, fatta dei libri, o delle pagine, la cui lettura ci procura gioia e che ci piacerebbe condividere. I testi di questa biblioteca intima non sono necessariamente famosi. La ragione è chiara. I professori, cacciatori di fama, si interessano meno alla bellezza che alle oscillazioni e alle tempistiche della letteratura e alla prolissa analisi dei libri che sono stati scritti per questa stessa analisi e non per il godimento del lettore.
La collana che introduco – e che già intravedo – intende offrire quel godimento. Non sceglierò i titoli in funzione delle mie abitudini letterarie, di una determinata tradizione, di una determinata scuola, di un tal Paese o di una tal epoca. Una volta dissi che altri si vantano dei libri che è stato loro concesso scrivere, mentre io mi vanto di quelli che mi fu concesso leggere. Non so se sono un buono scrittore; credo di essere un eccellente lettore o, in ogni caso, un lettore sensibile e riconoscente. Desidero che questa biblioteca sia così varia come l’insaziabile curiosità che mi ha spinto, e continua a spingermi, all’esplorazione di tanti linguaggi e di tante letterature. So che il romanzo non è meno artificiale dell’allegoria o del teatro, ma includerò romanzi perché anche quelli entrarono nella mia vita. Questa collana di libri eterogenei è, lo ripeto, una biblioteca fatta di scelte.
María Kodama e io abbiamo errato per il globo terracqueo. Siamo giunti in Texas e in Giappone, a Ginevra, a Tebe, e ora, per raccogliere i testi che per noi sono essenziali, percorreremo le gallerie e i palazzi della memoria, come scrisse Sant’Agostino.
Un libro è una cosa fra le cose, un volume perso fra i volumi che popolano l’indifferente universo, fino a che trova il suo lettore, l’uomo destinato ai suoi simboli. Accade quindi quella singolare emozione chiamata bellezza, quello splendido mistero che non viene decifrato né dalla psicologia né dalla retorica. «La rosa è senza perché», disse Angelus Silesius; secoli dopo, Whistler avrebbe dichiarato: «L’arte accade».
Spero solo tu sia il lettore che questo libro attendeva.






































