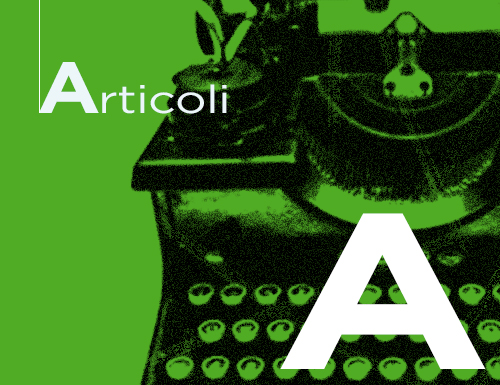
In un vecchio filmato del 1962 Dino Buzzati ci racconta con una voce un po’ cantilenante e nasale, ma profondamente umana, la sua idea di pittura. In tono quasi didascalico, parla agli spettatori di un quadro che ha tratto da uno dei suoi racconti, La ragazza che precipita (1966). Si confida con il mondo, rivelando la sua passione per l’arte e la pittura – la sua forma espressiva preferita – e meditando sul senso stesso dell’esperienza artistica. Più propriamente, con malcelata saggezza ermeneutica riflette sul senso ultimo dell’essere scrittori, pittori, creatori di cose inesistenti eppur vive. Esalta il metodo del fumetto, la fusione tra arte visiva e narrativa, preconizzando certi moderni strumenti narratologici a metà strada tra i due generi. Una ragazza precipita, per l’appunto, da un grattacielo così alto che Buzzati deve dipingerne tre sulla tela; tutti uguali, in rapida successione spaziale e concettuale. È un trittico modernista, una sorta di “architettura del racconto”. Mentre la vede cadere, la gente che si trova nei tre palazzi celebra i riti della quotidianità. La guarda sbalordita, le parla, cerca di trattenerla. Ma lei si rifiuta di arrestare la sua corsa verticale, è decisa a proseguire la discesa vorticosa, la ricerca del mistero insondabile che sta oltre la vita. Giunta in prossimità del suolo, viene scorta da una coppia. Il dialogo è memorabile.
«Alberto hai visto? È passata una…»
«Una… cosa?»
«Una, come dire… una specie di stella, proprio una minuscola stellina.»
Come un cristallo di vita, la ragazza si schianta al suolo, astro morente, luce nella notte.
Ci piace parlare di Dino Buzzati in questa maniera: un po’ per caso, visto che da qualche parte bisogna pur principiare; un po’ per obbligo, poiché la vena misterica e onirica rappresenta una costante nel quadro della sua vita, così come della sua opera.
Pittore dell’impossibile, apollineo costruttore (ma anche, forse, dionisiaco distruttore) di sogni, storie e personaggi perfetti nella loro congenita imperfezione, chi è Dino Buzzati, quale mistero si cela dietro la sua figura d’intellettuale complesso e poliedrico?
Persuasi che, come per ogni cultura o comunità umana, anche in ciascuno di noi, in una sorta d’analogia junghiana, sia presente una forma di mito delle origini, una ragione primigenia del nostro essere chi siamo, ci pare interessante tornare al padre de Il deserto dei Tartari.
Una storia variegata, la sua, contraddistinta da varie fasi. A unirle è, sin da principio, la necessità dell’ascesi, un’esigenza vitale (e vitalistica) dell’uomo ancor prima che dello scrittore, che lo porta a compiere tutta una serie di viaggi iniziatici, come fosse in possesso di una segreta formula ancestrale di passaggio che lo spinga oltre i limiti umani.
Ma Buzzati rimane sempre se stesso, pur cambiando aspetto: scrittore e poeta, pittore e drammaturgo, giornalista… non ammette variazioni, cambiamenti di rotta, sulla necessità del sogno, sull’onnipresenza dell’elemento fantastico. Proprio come Borges, scorge dappertutto la dimensione dell’immaginario, perfino nella cronaca.
Per lui, come per il grande bibliotecario sudamericano, il nucleo dell’intero corpus della letteratura è di natura fantastica. Ma Buzzati va oltre, perviene a conclusioni più radicali. Nella sua visione del mondo non esistono distinzioni nette fra una dimensione e l’altra. Analogamente al microcosmo delle reazioni chimiche o dei fenomeni fisici – o, ancora meglio, alchemici, più connaturati alla dimensione fantastica – prefigura una trasmutazione fra ciò che è reale e il suo contrario. Un dinamismo narrativo ben presente nei suoi racconti e romanzi, che lo conduce, come altri autori neofantastici (Calvino, Landolfi, Bonaviri), alla costruzione d’una mitologia moderna che, naturalmente, affonda le radici in quella classica. Proprio come Landolfi, Buzzati intravede le ombre dell’elemento orfico che si celano nelle pieghe del tempo, tra le fessure della cultura popolare, nelle tradizioni contadine. E, come Bonaviri, sottolinea la misurata potenza del meraviglioso naturalistico, che sembra alludere ad una presenza panica mai sopita.
Tra le molte altre cose, come già detto, Buzzati fu giornalista, tra i maggiori del secolo passato, una penna aguzza e arguta, elegante ed essenziale, immaginosa e ironica, che parlò di sport, letteratura, cronaca e pittura (fu pure critico d’arte). Ma anche nel giornalismo, nell’elemento cronachistico, intravide elementi diversi dalla semplice realtà materiale.
La vita è mistero, ci dice Buzzati, e la realtà rappresenta solo una faccia della medaglia. Forse per questo qualcuno lo ebbe a definire il Kafka italiano, un po’ come accadde per l’altro grande alfiere del fantastico nazionale, il già citato Tommaso Landolfi. E, come Landolfi, Buzzati ci ha fatto sognare, grande anfitrione d’un onirismo favoloso, denso, splendidamente arcano, personificazione della quintessenza bontempelliana della magia popolare (il così detto realismo magico), ultimo anello di una tradizione millenaria che fonde fantastico e reale, senza che sia più possibile distinguere il primo dal secondo.
Un messaggio talmente forte da aver superato anche l’ora del tramonto biologico del suo autore. Se l’uomo Buzzati non è più, la sua magia invincibile non ha perso nulla in potenza; ci parla al di là del tempo, al di sopra d’ogni bruttura umana, oltre le dimensioni del possibile e dell’impossibile. Eppure, dobbiamo ammetterlo: malgrado le analisi, gli studi e le disquisizioni accademiche, Dino Buzzati, come uomo e come scrittore, resta comunque e soprattutto un mistero.
E adesso andiamo a presentare i quattro racconti che costituiscono il nostro omaggio alla sua figura. Con Il Decreto dei Tartari, Francesco Grasso compie una riscrittura del celebre capolavoro buzzatiano, sostituendo a distese desertiche le non meno vuote e desolanti stanze d’una burocrazia miope e insensata; il tutto condito con una buona dose di satira rivolta al presente. E se, d’improvviso, vi capitasse di parlare in modo bizzarro, di non riuscire più a esprimervi in modo intellegibile? È quel che accade al protagonista della storia di Adriano Monti Buzzetti, Un deficit linguistico, che viene spedito tra le sue montagne natie per recuperare la lingua perduta. Ad attenderlo, ancora una volta, è il mistero. Ne Il faro, Gianpiero Mattanza ci racconta una storia intrisa di melanconia, che parla di solitudine e saggezza; la saggezza del mare, che è poi la stessa d’un guardiano-filosofo esiliato dal mondo, che riporta alla mente il protagonista de Il vecchio e il mare. Con un epilogo del tutto inaspettato. E, per chiudere, Arriveranno i Terrestri di Giorgio Betti, affresco fantascientifico dal sapore buzzatiano imbevuto di nostalgia, in cui l’uomo del domani punta gli occhi al cielo da una prospettiva inattesa e paradossale.
Quattro tributi narrativi e letterari per omaggiare, a modo nostro, il genio di Dino Buzzati.






































