Galeano sostiene. Il calcio diventa letteratura
Claudio Tarani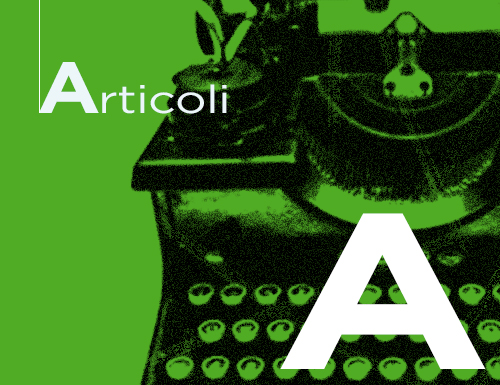
I mondiali 2018 in Russia si sono conclusi da pochi mesi. I riflettori sono ormai spenti su questo evento, che ogni quattro anni tiene con il fiato sospeso miliardi di spettatori nel mondo. Si giustificano spese faraoniche in opere pubbliche, che spesso poi rimangono come totem alla stupidità e all’avidità umane. Soltanto il tempo ci restituirà un responso definitivo sui costi e sull’utilità effettiva delle infrastrutture realizzate in Russia. Tuttavia, a prescindere dalle pur doverose considerazioni economico-finanziarie, per i tifosi e per chi ama il gioco del calcio resta inespressa una domanda: cosa rimane dopo un campionato del mondo? Una sensazione di «malinconia irrimediabile, che tutti sentiamo dopo l’amore, e alla fine della partita». Così aveva risposto Eduardo Galeano (1940-2015), scrittore e saggista uruguayano (o, come preferiscono alcuni appassionati, uruguagio) oltre che raffinato giornalista, una delle voci più autorevoli della cultura latinoamericana. È stato un fine intenditore di arte, storia e politica, oltre che di letteratura, cresciuto in una famiglia dell’alta borghesia cattolica, con antenati che migrarono dall’Europa alla fine del Diciannovesimo secolo. Al giornalista Sebastiano Triulzi rivelò profeticamente: «I miei geni sono italiani, gallesi, castigliani, tedeschi, un miscuglio incredibile: tutto misturado. Io sono la prova viva che in Europa non c’è un destino molto stimolante – e inizia a ridere –, la prova provata che l’Europa non funziona». Lasciò la scuola all’inizio delle superiori: ha sempre sostenuto, orgogliosamente, «in parte per una ragione economica e in parte per il desiderio di libertà». Ha fatto molti lavori, dall’operaio in una fabbrica d’insetticidi a pittore per insegne, da dattilografo a fattorino in una banca: «Fu in quel periodo che appresi che i principali rapinatori di banche sono i banchieri stessi, solo che nessun allarme suona per loro». Ha iniziato precocemente la carriera da giornalista: a soli quattordici anni disegnava vignette politiche per il settimanale socialista «El Sol», firmate con lo pseudonimo Gius, per la difficoltosa pronuncia castigliana del cognome paterno (Hughes). A ventuno è stato direttore della rivista culturale «Marcha», quando vi lavoravano anche Mario Vargas Llosa e Mario Benedetti, e in seguito del magazine «Epoca». Dopo i colpi di stato in Uruguay (1973) e Argentina (1976), perseguitato dai regimi dittatoriali al potere, scelse di vivere esule in Spagna. All’inizio del 1985 tornò a Montevideo, dove visse fino alla morte, dovuta a un tumore ai polmoni.
Non perse mai di vista il piacere, il dovere di raccontare, ricercò sempre la perfezione della scrittura, spesso ottenendola. Come ha notato finemente lo scrittore Marco Ciriello, «ha sempre considerato il lato della gomma per cancellare, sulle matite con le quali scriveva, la parte più importante». Diceva che si diventa scrittori solo «guardando e ascoltando. Per questo abbiamo due occhi, due orecchie e una sola bocca». Era parsimonioso con le parole: «Uso soltanto quelle che possono migliorare il silenzio». Le usò molto bene, intervenendo quando silenzio era sinonimo d’indifferenza, rassegnazione o ignoranza, oppure uno strumento politico utilizzato dai dittatori per facilitare le loro spregevoli attività. Aveva una faccia da attore e una voce suadente, possedeva un’eloquenza fuori dal comune e un tratto aristocratico, oltre a un’acuta sensibilità politica che lo sollecitava nell’impegno contro le ingiustizie.
Ma soprattutto – ciò che più ci interessa qui – ha descritto il calcio in numerosi libri e articoli, evidenziandone tanto il fascino quanto le esasperazioni. Ad esempio, nel 1997 pubblica Splendori e miserie del gioco del calcio, un titolo emblematico, un punto di riferimento della storia e della letteratura di questo sport, celebrato come evento sociale e culturale. Rimprovera anche le sciagurate intese con i potentati economico-finanziari e gli intellettuali che criticano, pieni di pregiudizi ideologici, il gioco e il suo successo popolare. I racconti sono brevi, lo stile unico, sospeso tra finzione e realtà: Galeano infrange i confini tra prosa e poesia, esaltando il primato della parola.
Fin dalle prime pagine, lo scrittore uruguaiano non risparmia critiche al calcio moderno, che reputa ormai quasi totalmente privo di ogni romanticismo, divenuto territorio di caccia per sprezzanti scorrerie politiche e finanziarie. Il pallone rimane sempre al centro, è indubitabile: è il protagonista assoluto. Con il tempo ha avuto il merito (forse demerito?) di sapersi trasformare ed evolvere, anche se intorno ad esso hanno cominciato a gravitare mondi differenti: le televisioni e interessi politici ed economico-finanziari.
Lo scrittore effettua una sintesi perfetta dei vari mondi, schierando in un ideale campo – che è poi la vita – personaggi assai diversi tra loro, da Roberto Baggio a Marilyn Monroe, da Salvador Allende a Pier Paolo Pasolini, da Humphrey Bogart a Benito Mussolini, ed altri ancora, tutti uniti da un filo conduttore che è il pallone. Memorabile l’incipit, dedicato a Maradona: «Giocò, vinse, pisciò, fu sconfitto».
L’eccezionalità del calcio, sostiene ancora Galeano, consiste nell’essere, nonostante tutto, sempre lo stesso da oltre un secolo. Qualche regola è cambiata, certamente, ma le principali sono rimaste immutate. Malgrado ciò, il suo successo non accenna a diminuire, anzi cresce ancora tra le popolazioni notoriamente dedite ad altri sport. I protagonisti di questa «ultima rappresentazione sacra» (espressione pasoliniana) sono sempre gli stessi. Il portiere, ad esempio, condannato all’eterna solitudine e ai rimproveri di compagni e tifosi; è lui il primo (e spesso l’unico) a pagare il conto. Dalla parte opposta del campo, invece, gioca l’attaccante, quasi sempre il mito delle folle: fa sognare i tifosi, segna un mucchio di goal, in pochi anni di vita ottiene denaro, donne e celebrità.
Così come per ogni grande sovrano arriva la fine, così l’idolo calcistico non può sottrarsi alla mediocrità atavica della folla imbufalita. D’altronde, il tifoso non è una creatura razionale. Assiste alla liturgia pagana di ogni partita e in quello scorcio di tempo non è in grado di rispondere delle sue azioni. Divide il mondo in nemici e amici, null’altro. Durante la partita ama solo i colori di una squadra. È l’unico essere umano sicuramente monogamo.
Galeano sostiene poi che il calcio, manifestazione autenticamente popolare, non deve cedere alle ingannevoli adulazioni dei potenti, di chi vuole trasformarlo in macchina per fabbricare denaro, uccidendo la fantasia e l’innocenza. Ecco perché ci avverte di non fidarsi della retorica intorno al pallone, né dei dittatori che vogliono descrivere, con la complicità di un campionato mondiale, la prosperità fasulla del loro Paese. Galeano ricorda la Coppa del mondo nel 1978, nell’Argentina del dittatore Videla, quella dei desaparecidos, delle mamme di Plaza de Mayo: «Durante la cerimonia di inaugurazione nello stadio Monumental di Buenos Aires era in pieno funzionamento la Auschwitz argentina, il centro di tortura e di sterminio della Scuola di meccanica dell’esercito. E alcuni chilometri più in là, gli aerei lanciavano i prigionieri vivi in fondo al mare». È doveroso chiedersi quante altre volte il calcio e lo sport in generale siano stati usati come strumento di potere e propaganda.
Oltre a descrivere alcuni dei protagonisti, Galeano narra i mondiali degli ultimi decenni: dai cileni del 1962 ai sudafricani del 2010 (gli ultimi ricordati nell’edizione italiana più recente). D’altronde, la ciclicità del calcio è uno dei fattori del suo successo, e l’entusiasmo degli appassionati difficilmente diminuirà: ogni quattro anni il mondo si ferma e per un mese assiste a decine di partite.
Galeano ha criticato, anche aspramente, questo mondo, ma è rimasto fermamente devoto alla propria fede: ad esempio, ha aspettato il mondiale 2010 con un entusiasmo prettamente giovanile. È lui stesso a confessarcelo: «Quando è cominciato il Mondiale, sulla porta di casa ho appeso un cartello che recitava: Chiuso per calcio. Quando l’ho tolto, un mese dopo, avevo giocato sessantaquattro partite, con la bottiglia di birra in mano, senza muovermi dalla mia poltrona preferita».
Un vecchio adagio sostiene che a inventare il calcio siano stati gli inglesi, ma gli uruguaiani furono i primi, agli inizi del Novecento, ad avere realmente imparato a giocarci. Non è dato sapere quanto ciò sia vero, ma è certo che fu proprio un uruguaiano come Galeano uno dei più bravi a scriverne: «Come tutti gli uruguagi, avrei voluto essere un calciatore. Giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma soltanto di notte mentre dormivo; durante il giorno ero il peggior scarpone che fosse comparso nei campetti del mio paese». Calciatore mediocre, quindi, ma tifoso appassionato (del Nacional di Montevideo), racconta che faceva «tutto il possibile per riuscire ad odiare i rivali del Penarol». Galeano era l’Uruguay. Un piccolo Stato ammattito per il calcio che, dopo la straordinaria vittoria nei mondiali del ’50, ancora tormenta i ricordi calcistici dei tifosi del Brasile; uno Stato dove, annota, «ci sono villaggi che non hanno una chiesa, ma non ne esiste neanche uno senza un campo di calcio».
Non è stato, però, solo un cantore del pallone, ma uno scrittore fortemente politico, autorevole riferimento per la cultura del continente sudamericano. Nel 1971, a trentun anni, pubblicò Le vene aperte dell’America Latina, un saggio, un’inchiesta e, soprattutto, un’appassionata e argomentata denuncia di cinque secoli di saccheggio delle risorse naturali: dalla Spagna coloniale del Seicento alle multinazionali del Ventesimo secolo. Censurato dalle dittature militari di Uruguay, Argentina e Cile, riscosse comunque un immediato e folgorante successo, tanto che Heinrich Böll, Nobel per la letteratura nel 1972, dichiarò: «Negli ultimi anni ho letto poche cose che mi abbiano commosso così tanto». Nonostante le critiche mosse alla politica imperialista di Washington, fu ben presto tradotto e utilizzato nelle università americane. È stato pubblicato in diciotto lingue e ha avuto oltre cento edizioni, solo in spagnolo.
Quando, nel 2009, durante la Conferenza pan-americana, il venezuelano Chávez ne regalò una copia a Barack Obama, dicendogli che era un’opera indispensabile per comprendere l’America Latina, Galeano non perse occasione per mostrare la sua ironia sottile: «Gli ha regalato un libro in una lingua che non conosce, un gesto generoso però un poco crudele». Un regalo che, in sole ventiquattro ore, fece schizzare le vendite della classifica di Amazon dal 54.925 al secondo posto. Tuttavia, nel 2014, alla Biennale del Libro a Brasilia, parlando delle Vene aperte, Galeano sorprese gli spettatori, accorsi con ben altre aspettative, affermando: «Non mi pento di averlo scritto, ma è certo che quando l’ho scritto non avevo una preparazione economica sufficiente. Ed è ancor più certo che il suo linguaggio, quello d’una sinistra sempre uguale a sé stessa, è ormai d’una insostenibile pesantezza». Il libro ha resistito all’abiura del suo autore e, nonostante la patina del tempo, rimane tuttora di straordinaria attualità.
Galeano è stato un grande scrittore degli spazi dimenticati, dove c’erano omissioni o dimenticanze altrui; occupava quello spazio e, coltivando il culto dell’impegno civile, scriveva e non faceva sconti ad alcuno. Non è un caso che in una delle sue ultime apparizioni in pubblico abbia sostenuto la rivendicazione della Bolivia per l’accesso al mare nei territori conquistati dal Cile durante la Guerra del Pacifico (1879-1883). E non è nemmeno casuale il fatto che, pur essendo stato un convinto sostenitore di Cuba, abbia criticato la deriva repressiva del regime negli anni più recenti: «Sono stato spesso critico con Cuba, ma lo faccio con amore e rispetto. Se in America Latina la metà della gente è povera, è il libero mercato ad aver fallito, ancor prima del socialismo».
Non è stato solo un autore uruguayano, come si legge nelle biografie, ma uno scrittore dell’intera America del Sud, avendo sempre ragionato in termini sovranazionali, traendo le storie dall’intera e composita natura del continente sudamericano. Tormentato dalla memoria, annotò: «Sono uno scrittore ossessionato dal ricordare, in particolare il passato dell’America e soprattutto quello dell’America Latina, terra intima e condannata all’amnesia».
La sua intera opera letteraria esplora gli anfratti sociali e politici del continente latinoamericano, esprime una forte denuncia sociale e mette in discussione la storia, l’eredità dell’oppressione coloniale e lo sfruttamento di un continente dalle dirompenti contraddizioni. In lui il calcio diventa davvero metafora della vita: sentimenti e ribellioni si celano dietro un dribbling, un gol, un gesto tecnico che assurge a celebrazione estetica. Una percezione, questa, condivisa da altri autori: la letteratura latinoamericana, infatti, ha spesso utilizzato il calcio per raccontare il disagio della vita, denunciare le nefandezze di governi e gerarchie militari ciniche e crudeli, facendo emergere, con sarcasmo e malinconia, il turbamento della società. Il calcio, dunque, assurge a simbolo di giustizia, strumento per condannare oppressione e violenza. I grandi scrittori sudamericani si sono impossessati del pallone, con un’abilità letteraria inusitata, traendone un’impareggiabile epica moderna e popolare. Anche Galeano l’ha fatto. In Splendori e miserie, a proposito della felicità, riferisce della teologa tedesca Dorothee Sölle. A una giornalista che le chiese: «Come spiegherebbe a un bambino che cos’è la felicità?», rispose: «Non glielo spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare».






































