Con la rabbia agli occhi. Itinerari psicologici nel cinema criminale italiano
Fabrizio Fogliato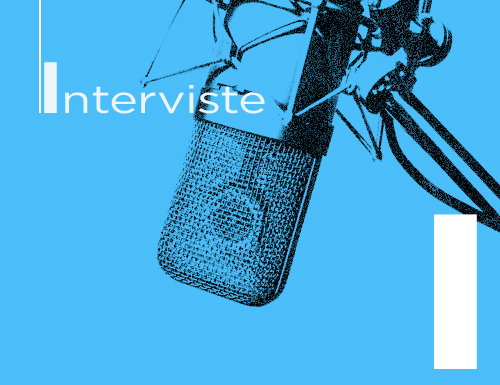
I poliziotteschi degli Anni ’ 70 come puntuale chiave di lettura cinematografica della società italiana. Fabrizio Fogliato, autore di Con la rabbia agli occhi, ha ripercorso la storia delle pellicole più significative
È passato poco più di un decennio e le atmosfere suadenti della dolce vita felliniana sono ormai un
lontano ricordo. Le città italiane diventano terra di conquista di banditi che rapinano e assaltano banche per poi sfrecciare via a folle velocità travolgendo tutto e tutti, perennemente inseguiti da volanti ululanti che corrono sulle strada a sirene spiegate per rapine e assalti alle banche.Tragico teatro di regolamenti di conti con sparatorie infinite e soprattutto con strade bagnate da fiumi di sangue. Milano, Roma, Napoli diventano lo scenario perfetto per la cruda violenza
cinematografica dei cosiddetti “polizieschi all’italiana”: pellicole diventate ormai cult attraverso le quali Fabrizio Fogliato, autore di Con la rabbia agli occhi. Itinerari psicologici nel cinema criminale italiano (Bietti Edizioni 2022), racconta le vicende politiche e storiche del nostro Paese, nonché la psicologia di massa della società italiana. Poliziamoderna lo ha incontrato per ripercorrere insieme alcuni “itinerari” di questa lettura cinematografica della realtà.
Come nasce l’idea di raccontare un pezzo della nostra storia recente attraverso l’analisi
dei film polizieschi?
Ritengo che il cosiddetto “cinema criminale” sia perfettamente in grado di dare visibilità alla storia e di rileggere modelli storici e comportamentali mediante il filtro della rappresentazione cinematografica. In particolare la suggestione dell’immagine filmica fa emergere, nel poliziesco
italiano, una contraddizione di fondo: voler restituire il senso dell’ordine attraverso il
disordine. Una contraddizione, brillantemente affrontata proprio da Poliziamoderrna in alcuni articoli dedicati in passato al cinema “poliziottesco”, da cui emerge quanto fuorviante, pervasiva e pericolosa sia l’immagine del commissario che doma le città violente: viola sistematicamente la
legge che dovrebbe far rispettare, si mette contro i superiori “da scrivania”, si immola accettando
punizioni e trasferimenti perché la sua unica ragione di vita (e di essere) è scendere in strada
e urlare in faccia al cittadino-spettatore «Io sono la legge».
Questo perché si avverte sempre di più nella collettività la percezione di un’insicurezza dilagante. E mai come in questo caso, il cinema di genere risulta davvero efficace nel raccontare il ripiegamento della popolazione italiana che, progressivamente, rivede al ribasso – in termini di fiducia e di affidabilità – il suo rapporto con le istituzioni.
Un “itinerario” del libro è dedicato a Banditi a Milano di Carlo Lizzani che si sofferma sul rapporto tra trasformazioni del tessuto urbano ed evoluzione della criminalità. Quali altri film polizieschi di quel periodo riflettono i cambiamenti socio-economici del nostro Paese?
Nella Milano che precede il “miracolo economico” agisce mimetica la ligéra: criminalità non violenta, tentativo, per gli abitanti dei quartieri popolari, di sfuggire alla miseria che accomuna loro e
i tutori dell’ordine. Con l’avvento del nuovo decennio la ligéra lascia il posto ai “cani sciolti” prima,
alla criminalità organizzata poi. A Milano si spara, si uccide, si rapina, si sfreccia in auto inseguiti
dalla Squadra mobile. La città è attraversata da una rabbia rancorosa e feroce che sfocia in una
serie di conflitti, scontri a fuoco, distruzioni che si propagano senza soluzione di continuità. Il nichilismo produce violenza immotivata, selvaggia, liberatoria. Oltre a Banditi a Milano la pellicola che fa davvero emergere la dimensione psicopatologica della metropoli è Milano odia: la polizia non può sparare (1974) di Umberto Lenzi che si allontana dal poliziesco tradizionale per addentrarsi in territori finora mai esplorati dal genere: il film è la cartella clinica di uno psicotico che proietta la
sua malattia su una città, la quale, priva di anticorpi, è predisposta a lasciarsi contagiare (ecco il senso
del titolo). Uno così non lo arresti, lo ammazzi: perché è ammalato e contagioso. Così il commissario
Walter Grandi getta alle ortiche etica e distintivo («Ti condanno a morte per rapimento, violenza e
strage») e “fredda” Giulio Sacchi tra cumuli di spazzatura.
Nel libro non manca Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: che rapporto c’è tra il romanzo di Carlo Emilio Gadda e la versione del film di Pietro Germi Un maledetto imbroglio? E che tipo di investigatore è Ingravallo, il primo commissario della letteratura italiana?
I titoli di coda di Un maledetto imbroglio sono illuminanti: la scelta di indicare i personaggi
semplicemente con il ruolo sociale o la professione che praticano, è indicativa della volontà di creare
degli archetipi, rappresentare il condominio come lo Stato e i suoi inquilini come tipologie di italianità. Germi, sprezzante e sarcastico, si allinea perfettamente alle intenzioni di Gadda. Poi, però,
se ne allontana, trasferendo la vicenda nella contemporaneità (il romanzo si svolge tra la primavera
e l’estate del 1927), focalizzando la sua attenzione sui primi “prodotti” del boom economico: una società in cui tutti sono colpevoli, nessuno è innocente, moralmente corrotti e con qualcosa da nascondere. La realtà è talmente rivoltante e nocivo che Ingravallo ‒ indossando quasi sempre gli occhiali da sole ‒ si rifiuta di guardarla. Il film di Germi pone al centro della scena l’interrogatorio di polizia, le domande, però, qui non riguardano solo ed esclusivamente dei fatti, non costituiscono pura indagine, piuttosto un interrogatorio sull’uomo, un’indagine psicanalitica sui generis che non permette di definire una verità ma solo di destreggiarsi tra sentimenti controversi e contrastanti.
Ingravallo è un poliziotto-filosofo che sperimenta il male e auto indaga sé stesso per capire il Male che si agita fuori: il suo interrogatorio rimette insieme i frammenti di una vita alla ricerca di un indizio di
colpevolezza. La paura è quella di ritrovarsi sul banco degli accusati a propria insaputa. Con Ingravallo la tecnica del poliziesco diventa una variante di metodo: lo strumento necessario a portare a compimento un’indagine dai tratti kafkiani volta alla redenzione del colpevole.
Un capitolo intero è riservato invece al lato oscuro del potere, a pellicole da cui emerge la figura del poliziotto ambiguo o corrotto o del servitore infedele dello Stato. Che rapporto c’è tra questi personaggi di fantasia e una figura reale come quella del criminologo Aldo Semerari?
Difficile definire, incasellare la figura di Aldo Semerari: criminologo, il più importante che l’Italia abbia mai avuto. Un uomo interessato al Male e al tentativo di spiegarlo, che ne indaga origini
e natura, ponendosi dalla parte di chi lo perpetra e dell’oggetto che ne definisce l’evidenza fenomenologica: la violenza. Essa è un acceleratore, uno strumento che accorcia la distanza tra
bisogni e obiettivi, volontà e fini. Lo dimostrano ampiamente tanto la cronologia storica quanto la rappresentazione filmica. La polizia ringrazia (1972) di Stefano Vanzina non è un poliziesco ma un film di impegno civile che usa la tecnica del genere per ragionare sul limite che divide la prescrizione dalla sua infrazione: istantanea di una diffusa paranoia sociale. Vogliamo i colonnelli (1973) di Mario Monicelli centrifuga i “golpe” del 1964 e del 1970. Complementare a Vogliamo i colonnelli è La polizia accusa: il Servizio Segreto uccide (1975) di Sergio Martino, un unicum, sia nel registrare l’eversione nera in “presa diretta”, sia nel veicolare – con la tecnica del genere – in via congetturale rivelazioni più che verosimili. Il commissario Solmi e il capitano Sperlì (Tomas Milian) muoiono entrambi ammazzati perché sanno troppo, e il primo viene ucciso con le stesse modalità di Luigi Calabresi il 17 maggio 1972: mentre sta aprendo la portiera dell’auto gli sparano alle spalle.
Il 28 maggio 1974 esplode una bomba durante una manifestazione antifascista in piazza della Loggia
a Brescia (nove morti e 88 feriti). Il poliziesco italiano, con la sua proverbiale capacità di cogliere
l’attimo, ambienta proprio a Brescia il film La polizia sta a guardare (1973) di Roberto Infascelli.
Sullo sfondo la provincia italiana opulenta e spersonalizzata. Mentre la città “dorme”, l’eversione nera
fa proseliti e rimpingua le proprie casse con i riscatti milionari di rapine e sequestri di persona. Con
Morte sospetta di una minorenne (1975), Sergio Martino porta a compimento tutti i discorsi
iniziati nelle pellicole precedenti progettando un’architettura cinematografica sovradimensionata
e complessa, volta a scrivere ‒ seguendo la lezione dello Sciascia di Il contesto ‒ un’ulteriore pagina
realmente introversa e allarmante sul dilagare torrenziale di azioni eversive sempre più contaminate
e mimetizzate con dinamiche di criminalità organizzata.
Il genere cosiddetto “poliziottesco” ha imperversato negli Anni ‘60-’70. Quali sono secondo lei o i film più importanti e significativi di quella stagione cinematografica?
Senza dubbio Roma violenta (1975) di Franco Martinelli [Marino Girolami]; Roma a mano armata,
Napoli violenta di Umberto Lenzi (del 1976) e Italia a mano armata di Franco Martinelli (1976).
Significativo è che in questi film il vero antagonista del commissario sia rappresentato da luogotenenti
della malavita. I loro superiori si godono la vita impartiscono ordini e ne osservano da lontano gli effetti venendo costantemente aggiornati sull’evolversi dell’azione. Quando scendono nell’agone
lo fanno di notte, di nascosto, nell’omertà di complici e testimoni. Il più significativo di questi esempi è il brutale assassinio a colpi di palla da bowling del poliziotto De Cesare da parte di O’ Generale in
Napoli violenta. L’anonimato del crimine di O’ Generale è tale per tutti, tranne che per il commissario
Betti, il quale prende a pretesto l’omicidio del suo collega per tendere una trappola e uccidere il
capo camorrista al molo di Nisida: in una scena che riecheggia, su un piano popolare e sbrigativo, il
ragionamento di Petri in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il commissario in questi film non può permettersi né di sorridere né di essere simpatico: deve solo tenere sotto controllo la situazione, se si distrae – come avviene nel finale di Italia a mano armata – muore. La maschera
del commissario interpretato da Maurizio Merli è un modello estetico polisemico: angelo dal
completo candido o funzionario acqua e sapone, rassicurante ed energico (metafora della rabbia
di un’intera nazione). Gli umori malsani e viscerali che trasudano dalle città violente sono restituiti
in una sorta di incontrollata e contraddittoria proiezione della realtà: lo specchio incrinato, deforme, in cui si riflette una società imbastardita, tronfia, limacciosa che non presenta distinzioni di sorta tra personaggi sullo schermo e spettatori in platea.
Con la rabbia agli occhi si ferma alla soglia degli Anni ’80. È possibile un confronto tra il cinema poliziesco di quel periodo con la produzione attuale, anche “seriale”, come Gomorra, Romanzo Criminale o Suburra?
No, è un altro mondo: omologato, standardizzato, calato su modelli estetici e stilistici ripetitivi, privi di pathos e imprevedibilità (anche quella dozzinale e “caciarona”). Quella di oggi è una serialità
finalizzata a intrattenere e non colpire, a non turbare lo spettatore a mostrare un Male finto, apparente, “rassicurante”; tutta costruita sulle sensazioni immediate usa e getta e, anche
quando sembra raccontare vicende reali, in realtà parla d’altro attraverso l’effetto, lo spettacolo costruito a tavolino… Nulla a che vedere con le folli corse (seppur successivamente accelerate in
sede di montaggio) per le vie di Genova facendo inseguire le finte Volanti della polizia da vere Volanti,
chiamate da un ignaro cittadino convinto di aver assistito ad una vera rapina.
Roberto Donini e Anacleto Fiori ©POLIZIAMODERNA luglio 2023









































