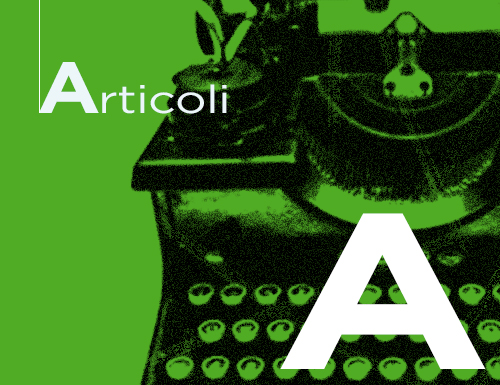
Il cinema horror, per Rob Zombie, non è un artefatto ludico, né ha proprietà catartiche: è un’arte sovversiva, per dirla con Amos Vogel, determinata a cambiare e a scuotere la coscienza (e il subconscio) degli spettatori, che si tratti di rompere tabù, reinventare forme cinematografiche o minare il nostro sistema vigente di valori. Infatti, film come La casa dei 1000 corpi (2003) o Le streghe di Salem (2012), senza dubbio le sue opere più emblematiche, si rivelano come opere dell’orrore “pure” perché violano le categorie ontologiche sulle quali si basano la nostra società e la nostra cultura e, di conseguenza, sgretolano la nostra certezza sulla solidità della realtà. Quindi, ciò che sembra normale o quotidiano cela misteri inquietanti e spaventosi; le frontiere tra la veglia e il sogno (o l’incubo) svaniscono, facendoci scoprire che esiste sempre la possibilità di un’irruzione aggressiva, nella nostra quotidianità, dello straordinario e dell’abominevole. Un’aggressività, occorre sottolineare, che germoglia dallo scontro, impossibile eppure certo, tra l’umano e l’inumano, il naturale e il soprannaturale.
In questo modo, senza sentimentalismi di alcuna specie, il cinema di Rob Zombie svela il carattere assurdo, violento, tragico della vita. Ma non in uno spazio-tempo storico qualsiasi, bensì negli anni successivi agli attentati terroristici dell’11 settembre, i quali hanno creato un clima di isteria e paura collettiva senza precedenti nella storia degli Stati Uniti1. L’autore di La casa del diavolo (2005) si rivolge a una società il cui trauma «si è fatto strada così profondamente nel tessuto della comunità colpita che finisce per fornirgli lo stato d’animo e l’umore predominanti, soggiogandone l’immaginario e il senso d’essere, governando la forma in cui i suoi membri si relazionano gli uni con gli altri […], il che comporta un cambiamento nella loro visione del mondo».2
L’11/9 sembra fornire a Zombie una coscienza dell’essere-nel-mondo radicalmente pessimista, per via delle guerre in Iraq e Afghanistan, delle crudeli operazioni della CIA e della DIA (il trasferimento illegale di detenuti nei “buchi neri”, carceri segrete in terzi paesi per la loro custodia e successivo interrogatorio sotto tortura; esecuzioni sommarie dei sospetti; Black Ops in paesi “amici”, il taglio dei diritti civili su suolo statunitense o la creazione di Guantánamo) e di quella globalizzazione economica dall’aggressivo taglio neoliberista (disoccupazione, precarietà lavorativa) che ha alimentato la crisi dei valori “civilizzati” occidentali. Non a caso la follia, la morte, la paura, la rabbia, diventano altrettante rivelazioni sul mondo che emergono dall’orizzonte esistenziale del regista stesso. Soggetto e mondo sono qui termini che vanno di pari passo, poiché non v’è l’uno senza l’altro, in quanto è il soggetto che (ri)crea il mondo attraverso la propria coscienza e, in questo modo, è in grado di analizzarlo e confrontarvisi.
Rob Zombie non è solo un grande narratore di storie dell’orrore che, sotto quell’apparenza stilizzata di attrazioni da baraccone o di cupo FreakShow, ci offrono un’esperienza sensoriale ed emotiva al limite. Qui non si cerca mai lo spavento facile o il ricorso a cliché stantii. Basti vedere titoli come Halloween. The Beginning (2005) o Halloween II (2009), sinistre illustrazioni di desideri e timori inconfessabili, rappresentazioni narrative e allegoriche di una mente in conflitto che trasforma idee e sentimenti in fantasie spaventose (secondo Otto Rank3), o che proietta la propria aggressività, la propria frustrazione e i propri impulsi di morte in un’effigie mostruosa o doppelgänger (secondo Melanie Klein4) che è il film stesso, universo tenebroso dotato di leggi proprie. L’autorialità forte di Rob Zombie non è un’esperienza solipsistica centrata su un Io senza connessione con gli altri. Il suo essere-nel-mondo passa attraverso la sua narrazione, la sua iconografia e la sua drammaturgia, poiché una persona è, essenzialmente, «un cumulo di storie raccontate da qualcuno e per qualcuno che danno forma e senso a differenti modi di essere e di agire nel mondo».5 Nelle narrazioni si costruiscono i significati di base che danno contenuto, trascendenza, alla vita umana in senso individuale e collettivo.
31 ha un tocco creativo e psicologico tanto esigente e provocatorio quanto La casa dei 1000 corpi o Le streghe di Salem, già evidente nella morbosa sequenza iniziale in cui lo stravagante Doom-Head – uno straordinario assassino che si autodefinisce «un soldato solitario», forse evocando un tenebroso passato –, prima di uccidere a colpi d’ascia un pastore protestante, proferisce un allucinato monologo, in primo piano, guardando in macchina. «Ora, dobbiamo chiarire subito una cosa, io e te. Non sono un dannato clown. Non sono qui per farti felice. Non sono qui per ravvivare la tua triste giornata. E di sicuro, non sono qui in attesa di una tua reazione divertita. Sono qui per porre fine alla tua fottuta e miserabile vita. Ma prima… Prima, ti delizierò con una storia. Vedi, non credo che l’ultimo rumore che i tuoi timpani debbano sentire sia il suono del tuo corpo fatto a pezzi», esclama. È Rob Zombie che si rivolge allo spettatore, avvertendolo della natura lugubre dello spettacolo cui sta per assistere, o lo sta invitando anche a condividere il suo piacere come autore che osserva se stesso, sdoppiato, nel proprio «mondo di dèi e mostri»? Forse la cinefilia si converte qui in necrofilia, e le passioni più recondite dell’autore si identificano con un “mostro”6. O probabilmente si tratta di una dichiarazione di principi, una maniera aggressiva di riaffermarsi come autore, come essere-nel-mondo, che può (e vuole) unicamente esprimersi così, attraverso storie dell’orrore situate un passo più in là dei limiti del genere, delle convenzioni, senza tenere in conto dove portano o cosa dimostrano, se il bene o il male, l’attraente o il repellente, lo stimolante o il deprimente, trasformandosi in un cronista vivo e indipendente del lato oscuro dell’uomo e della società. Non a caso, 31 non solo è stato accolto tiepidamente dal fandom e dai critici, ma la sua stessa gestazione è stata complessa. Parte dei costi di produzione, un milione e mezzo di dollari, sono stati raccolti mediante crowdfunding, poiché «un film che avresti potuto fare [in maniera normale] qualche anno fa ora non puoi più farlo, perché il business è cambiato, le cose sono cambiate […] Ho sempre avuto il controllo, ma ho sempre dovuto lottare per averlo e, a volte, lottare è terribilmente estenuante».7
31 ricolloca l’opera di Rob Zombie nelle sue origini cinematografiche: il Grand Guignol e il cinema exploitation degli anni Settanta. Il suo schematico canovaccio lo dimostra. Gli avviliti carnies (gli artisti di una mistura di circo e freakshow) in viaggio nel Sud degli Stati Uniti, pigiati in un furgoncino su cui campeggia il motto “The Show Must Go On” – tutta una dichiarazione di intenti da parte del cineasta –, vengono attaccati e decimati durante la notte di Halloween da un gruppo di clown armati di grossi coltelli. I cinque sopravvissuti vengono condotti nelle viscere di un palazzo rococó simile a quello che appariva in Le streghe di Salem, dove tre personaggi vestiti come libertini del XVIII secolo spiegano loro le regole del sadico survival che patrocinano: dovranno resistere fino all’alba ai letali agguati di una serie di soggetti tanto strambi quanto temibili, che rispondono a nomi come Sick-Head, Psycho-Head o Sex & Death. A partire da qui, 31 si trasforma in uno spettacolo grottesco, violento ma non gore, dato che Rob Zombie stilizza i momenti più sanguinosi concentrandosi sulla rabbia dell’azione violenta o vendicativa – la scena in cui Charly devasta prima a pugnalate e poi a colpi di mazza il corpo di Sick-Head –, collocando la cinepresa strategicamente per aggirare i cliché visivi dello slasher più crudo – il momento in cui Psycho-Head cade a faccia in giù sulla propria motosega e viene tagliato in due – o impiegando un montaggio molto frammentato per mitigare la brutalità di ogni pugnalata, di ogni colpo.
31 utilizza la violenza grottesca come un artefatto di diagnosi sociale, politica e culturale del proprio paese, come detto in precedenza, in un’epoca storica molto precisa. Ossia, non è interessato alle narrative “controstoriche” che localizzano la violenza nell’Altro o in luoghi lontani, ostili agli Usa – si vedano, per esempio, Turistas di John Stockwell (2006), Borderland di Zev Berman (2007) o il dittico di Eli Roth Hostel (2005) e Hostel: Part II (2007) –, ma alla violenza come qualcosa di genuinamente nordamericano che si sviluppa e si schiude, in tutta la sua furia, all’interno dei confini8. Pertanto, i lavori di Zombie si oppongono, dal punto di vista formale e drammatico, alle definizioni creative e morali del torture porn (David Edelstein, Steve Jones, Aaron Michael Kerner) poiché non sfruttano le pulsioni sadomasochiste del pubblico che, spinto da una certa indolenza etica, si identifica allo stesso tempo con la vittima e con il carnefice. La violenza di 31, come nei film precedenti di Zombie, disturba e perturba non tanto per la sua rappresentazione esplicita, ma per l’(apparente) assurdità della stessa. Una violenza che sottolinea un’autorialità intensamente autoconsapevole – si veda il ridicolo, e inquietante, abbigliamento nazi di Sick-Head, che rimanda al fake trailer Werewolf Women of the SS – e, occorre sottolineare, tremendamente arrabbiata e politicizzata. I “libertini” che organizzano il “31”9 ci ricordano i plutocrati newyorchesi di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick (1999), che celebrano orge di massa a margine della loro rispettabilità sociale e politica. Infatti, il trio di “libertini” di 31 è assistito da belle ragazze nude che nascondono il proprio volto dietro maschere veneziane, come nel film di Kubrick. Ma chi sono in realtà questi personaggi? La scena finale, in cui si spogliano del loro abbigliamento stile Versailles e rivelano la loro autentica personalità, ci fornisce la chiave di lettura. Possono essere politici, banchieri, alti funzionari federali, dirigenti di grandi corporazioni. Qui risiede il significato politico della pellicola, poiché i ricchi si divertono a sfruttare e uccidere i poveri: in una delle scene più angoscianti, uno dei killer vestiti da pagliaccio, Schizo-Head, prima di morire decapitato, confessa che anche loro sono obbligati a fare ciò che fanno… è un altro modo di accentuare le disuguaglianze sociali, la povertà, la precarietà lavorativa e i conflitti razziali acutizzatisi negli Usa dopo l’11 settembre. Poco importa che 31 sembri ambientato negli anni Settanta, il decennio “magico” del cinema horror secondo Rob Zombie: il film ci parla dell’America oggi e delle conseguenze morali, psicologiche e sociali lasciate dalle guerre in Iraq e Afghanistan, dalla Grande Recessione, dalla radicalizzazione ideologica del partito repubblicano… Quando 31 è uscito negli Stati Uniti, il 16 settembre 2016, mancavano due mesi alle elezioni presidenziali vinte, contro ogni pronostico, da Donald Trump, un personaggio mostruoso degno di un film di Rob Zombie.
Note
1 Solo l’attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, è stato paragonato all’11 settembre. Come scrisse l’opinionista Paul Krugman, «Viene naturale pensare all’11 settembre come equivalente morale di Pearl Harbor, e nella lotta iniziata quel giorno come l’equivalente della Seconda Guerra Mondiale per questa generazione». Krugman Paul, The Great Unraveling: Losing Our Way in the New Century, W. W. Norton & Company, New York 2008.
2 Erikson Kay T., Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood, Simon & Schuster, New York 1978, p. 155.
3 Rank Otto, Il doppio. L’uomo e la sua ombra, Editrice Novalis, Milano 2014.
4 Klein Melanie, Invidia e Gratitudine, Giunti Editore, Firenze 2012.
5 Narrative Knowing and the Human Sciences, State University of New York Press, Albany (NY) 1988, p. 16.
6 Badley Linda, The Darker Side of Genius: The (Horror) Auteur Meets Freud’s Theory, in Schneider Steven Jay (a cura di), Horror Film and Psychoanalysis: Freud’s Worst Nightmare, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 2004, p. 229.
7 Alexander Chris, Rob Zombie Discusses Crowdfunding New Film, “31”, in «Fangoria», 31 luglio 2014; Childers Chad, Rob Zombie Explains Why He’s Crowd-Funding “31” Horror Film”, in «Loudwire Magazine», 7 agosto 2014.
8 Goldberg Elizabeth Swanson, Splitting Difference: Global Identity Politics and the Representation of Torture in the Counterhistorical Dramatic Film, in Slocum J. David (a cura di), Violence and American Cinema, Routledge, New York, pp. 245– 270.
9 Un chiaro riferimento non solo alla notte di Halloween intesa come festa, o al coinvolgimento di Rob Zombie nel remake del film di John Carpenter e nel sequel del 2009, ma al gioco di carte omonimo dove la miglior mano, sommando il valore di ciascuna carta (qui le carte sono le vittime) è 31.
CAST & CREDITS
Titolo originale: 31; Regia: Rob Zombie; soggetto: Rob Zombie; sceneggiatura: Rob Zombie; fotografia: David Daniel; scenografia: Rodrigo Cabral; costumi: Carrie Grace; montaggio: Glenn Garland; musiche: John 5, Chris Harris (come Chris “Zeuss” Harris), Bob Marlette, Rob Zombie; interpreti: Sheri Moon Zombie (Charly), Jeff Daniel Phillips (Roscoe Pepper), Lawrence-Hilton Jacobs (Panda Thomas, come Lawrence Hilton-Jacobs), Meg Foster (Venus Virgo), Kevin Jackson (Levon Wally), Malcolm McDowell (Father Murder), Jane Carr (Sister Serpent), Judy Geeson (Sister Dragon), Richard Brake (Doom-Head), Pancho Moler (Sick-Head), David Ury (Schizo-Head), Lew Temple (Psycho-Head); produzione: Bow and Arrow Entertainment, PalmStar Media, Protagonist Pictures, Spectacle Entertainment Group, Spookshow International, Windy Hill Pictures; origine: Usa, Gran Bretagna 2016; durata: 102’; home video: Blu-ray Midnight Factory, dvd Midnight Factory; colonna sonora: Ims-Universal.






































