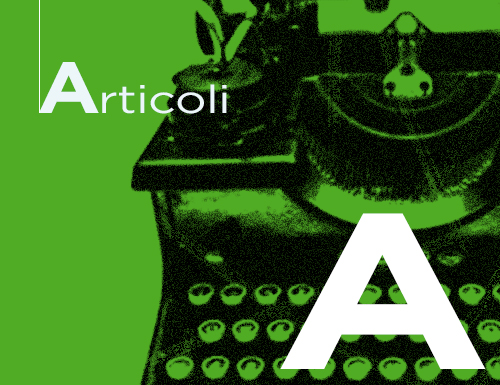
C’è un doppio movimento necessario a Halloween II per chiarire i termini del suo rapporto con tutto il cinema di Rob Zombie e con l’eredità pregressa della mitologia carpenteriana legata al boogeyman mascherato: è una sorta di doppio incipit, utile a consegnare le vicende dell’assassino seriale alla sfera dell’irrazionale e alla triangolazione realtà-sogno-Male cara al regista. Il primo vede Sheri Moon Zombie/Deborah Myers regalare al figlio Michael un cavallo giocattolo, negli anni della detenzione al manicomio criminale di Smith’s Grove: appena tre minuti, in cui la dimensione infantile del dono come consolazione dalla prigionia si stempera nel dialogo che suggella il patto onirico fra i due personaggi. La madre, per il tramite del feticcio, promette infatti al figlio di tornare nei sogni, stabilendo così il leitmotiv dominante delle visioni che affliggono poi il Michael adulto, con la donna accompagnata dal destriero bianco. L’idea del cavallo come tramite per la dimensione onirica e soprannaturale crea un affascinante ponte con le oscillazioni fra realtà e proiezioni fantasmatiche proprie del cinema di David Lynch – si pensi in tal senso alla visione di Grace Zabriskie/Sarah Palmer in Lonely Souls, quindicesima puntata della serie I segreti di Twin Peaks, in cui il cavallo anticipa lo svelamento dell’identità dell’assassino in carne e ossa e ne rivela la natura parimenti soprannaturale. Il movimento immediatamente successivo condensa in poco tempo una sorta di recap delle atmosfere ospedaliere che avevano caratterizzato l’Halloween II diretto da Rick Rosenthal nel 1981 (distribuito in Italia con il titolo Il signore della morte): quasi un pedaggio necessario per ribadire l’organicità del film rispetto alla mitologia che lo precede, ma anche il primo tentativo di forare le maglie troppo strette dello slasher movie e la sua perenne coazione a ripetere. Zombie lavora dall’interno il canovaccio classico mentre ne ossequia i confini: la violenza è dura, carnale, i corpi sono offesi con una brutalità che ritroveremo poche volte nel prosieguo della narrazione e che, nello specifico, sembra quasi ribadire la pressante voglia di esserci dell’icona di Michael Myers. Già nel precedente capitolo, dopotutto, l’assassino era stato ricondotto a livelli di realtà più immanente rispetto alla sua tradizionale natura oscillante di “forma”, maschera fra le tante della vigilia di Ognissanti. Così, mentre Michael ribadisce se stesso e la sua presenza materiale, contestualmente il tempo intorno a lui inizia a rarefarsi, mentre il costante ripetersi del motivo sonoro diffuso dai televisori – con i Moody Blues che cantano incessantemente il brano Nights in White Satin – crea uno straniamento tale da garantire la natura archetipica di una storia che può essere rimessa in scena soltanto in quanto sogno. È il prodromo di un’autentica rinascita. Da lì in poi, infatti, Zombie precipita lo spettatore in una realtà reinventata e fatta finalmente propria: per ammissione esplicita, il regista torna alla saga di Halloween per liberarsi dai timori reverenziali verso l’influenza di John Carpenter, che in parte avevano afflitto il suo precedente lavoro. Dopo avere alterato la percezione del tempo, ora la scansione degli eventi è più netta, ribadita da cartelli che ne datano la progressione. A cambiare è lo spazio: dagli ambienti ospedalieri spogli e vagamente asettici si passa a un quadro saturo di elementi, che ribadiscono l’amore dell’autore per il bric-à-brac, e al mascheramento dei corpi, solitamente collegati anche alla festa di Halloween (sempre viva nella filmografia di Zombie, si ripensi all’esordio di La casa dei 1000 corpi). Ciò che più conta è però il lavoro di oscillazione fra opposti che consegna l’intera vicenda a una dimensione a metà fra il realismo documentaristico e la già anticipata dimensione onirica, in grado perciò di risiedere sia nella mitologia “a metà” di un mondo diviso fra ombre e omicidi reali, sia nel particolare universo dell’autore, dove l’immanenza del gesto fisico o dell’oggettistica rituale scivola comunque nell’amore per il soprannaturale. In quest’ottica è la figura di Michael Myers a subire la riscrittura più audace: non più la tipica “ombra della Strega”, ma un senzatetto che vaga fra gli interstizi del reale evidenziando i comportamenti borderline delle micro-realtà che compongono Haddonfield, fatte di redneck dal grilletto facile e gestori di bordelli che speculano sull’eredità dei Myers. Zombie ricostruisce la fisicità di un Michael già consegnato alla leggenda dalle mitologie popolari e, in tal senso, va evidenziata la continua spoliazione della sua icona classica, con la maschera indossata ritualmente prima di ogni omicidio, ma progressivamente sempre più lacerata a scoprire le parti del viso. Incarnato come un autentico flusso di cattiva coscienza cittadina, il protagonista è al centro di un continuo processo di rivitalizzazione e demistificazione e assurge, infine, a una dimensione nuova grazie alle visioni della madre che guidano il suo comportamento: nel determinare la natura eterodiretta del Male di cui Michael, con le sue azioni di morte, è rappresentante, Zombie riscrive la saga da una prospettiva al femminile che si articola lungo la dialettica fra la madre Deborah (di cui il mostro è ambasciatore) e la sorella Laurie/Angel. L’intero film inscrive quindi le sue contrapposizioni fra la dimensione di sogno, in cui agiscono le forze soprannaturali incarnate dal mito di Michael Myers, e la realtà oggettiva dove l’autorità maschile è messa in perenne discussione, lasciando emergere il particolare ruolo duale delle protagoniste femminili, ugualmente costrette nel ruolo di carnefici e vittime. Così, le figure maschili tradizionali sono sconfessate nei loro intenti e depresse nelle loro pur buone intenzioni: lo sceriffo Brackett non riesce a mantenere la coesione della comunità di cui è guardiano, mentre il dottor Loomis (un tempo figura vicaria di quella paterna dello stesso Michael) è ridimensionato in un ruolo da imbonitore intento a capitalizzare le sorti del massacro dei Myers vendendo il suo bestseller. Una scelta, quest’ultima, utile anche a sottolineare il dualismo fra la dimensione commerciale del Mito (naturalmente sottesa alla festività di Halloween) e il piglio razionale di chi vuole ribadire l’oggettività dell’esistente sancendo una volta per tutte la morte fisica indiscutibile dell’uomo Michael. Perché è fra il piacere dell’orrore come messinscena spettacolare e l’empatia verso le implicazioni più serie del Male mitologicamente inteso che si gioca la principale sfida del cinema di Rob Zombie.
A compiere il più complesso percorso di formazione è dunque Laurie Strode/Boo/Angel Myers, autentica icona cangiante del film, che perde l’aura virginale del precedente capitolo per esibire un corpo su cui è letteralmente scritto il processo di personalizzazione dell’immaginario generato dalla vicenda. A metà fra una rocker e un’artista underground, Laurie è l’anticamera della Heidi nel successivo Le streghe di Salem, che la richiamerà sia nel look con tatuaggi esibiti, sia nel lavoro a contatto con i dischi e la musica. E come accadrà a Heidi, anche Laurie deve passare da un percorso di formazione che, nel sancire il suo passaggio dalla sfera del razionale a quella della follia, segna il particolare rovesciamento di prospettive – con rifondazione del mondo al negativo – caro all’autore. Il che già basterebbe a testimoniare l’importanza di Halloween II in quanto titolo-cerniera fra le prime fasi della filmografia di Zombie e la svolta impressa dal film successivo. L’autore continua così a perseguire un’ideale di purezza del Male che permetta alla dimensione oscura di assurgere, per l’appunto, a un livello mitologico. La saga di Michael Myers si fa interessante terreno di coltura, perché cova in sé il germe cinefilo da sempre caro all’autore, eppure si offre come nuovo spazio di sperimentazioni per una visione in cui il Male sia generato da un ventre materno e non più soltanto dalla mano feroce del maschio. Così, se Michael è il tramite della visione d’autore, la sua progressiva sparizione in una dimensione umana (con tanto di morte finale) apre la porta all’ingresso di Laurie nel soprannaturale e alla sua capacità di dare legittimazione fattuale all’orrore. Zombie prefigura questo viaggio attraverso il tema della confusione percettiva che, pur chiamando in causa anche possibili derive freudiane (inevitabili vista la componente familiare su cui poggia la storia), lavora soprattutto su una dimensione fisica che è anche astratta. Nel primo versante si rimescolano i generi – il personaggio in tal senso più emblematico è Harley (Angela Trimbur), la ragazza “travestita da ragazzo travestito da ragazza”; nell’altro si lavora sulla natura oppiacea dell’immagine, che elabora la trasparenza degli ambienti, altera le prospettive e le distanze fra le figure, permettendo alla dimensione soggettiva di inglobare quella oggettiva e ai tagli di luce di iscrivere spazi nuovi all’interno di realtà altrimenti rese concrete dalla granulosità dell’immagine. Qui la mano di Michael può colpire in un gioco ludico tipicamente slasher, che tuttavia apre la porta anche al lirismo. La visione mitologica dell’autore non potrebbe infatti dirsi completa senza il particolare sentire empatico di un modo di raccontare che è anche percezione diretta del dolore. La scelta di campo al femminile è così ancora più chiara: non solo perché il film si fa letteralmente carico dell’educazione al Male di Laurie, restituendone la centralità allo spettatore, ma anche perché l’unico momento in cui la discesa repentina agli inferi pare prendersi una pausa per aprirsi a una frattura violenta – in grado di far percepire la malinconia di ciò che è stato e non tornerà più – è la morte dell’amata amica Annie: il delitto al femminile è anche un doloroso ma necessario momento di passaggio dalla sicurezza del noto a ignote prospettive, e testimonia la voglia di mettersi in gioco da parte dell’autore. La versione director’s cut, inedita in Italia, spoglia definitivamente Michael Myers della sua maschera nel confronto finale con Loomis e consegna anche Laurie alla morte, trasfigurando il ricongiungersi finale con la madre alla sfera dell’oltre-vita e radicalizzando una volta di più la visione della realtà come concatenazione di mondi in cui far fiorire la particolare mitologia dell’autore.
Cast & Credits
Titolo originale: Halloween II; regia: Rob Zombie; sceneggiatura: Rob Zombie; fotografia: Brandon Trost; scenografia: Garreth Stover; montaggio: Glenn Garland, Joel T. Pashby; musiche: Tyler Bates; interpreti: Sheri Moon Zombie (Deborah Myers), Chase Wright Vanek (giovane Michael Myers), Tyler Mane (Michael Myers), Scout Taylor-Compton (Laurie Strode), Brad Dourif (Lee Brackett), Danielle Harris (Annie Brackett), Caroline Williams (Dr. Maple), Malcolm McDowell (Dr. Samuel Loomis), Margot Kidder (Barbara Collier), Chris Hardwick (David Newman); origine: Usa, 2009; durata: 105’/119’ (unrated director’s cut); home video: dvd e Blu-ray Mediafilm; colonna sonora: Halloween II, Universal.






































