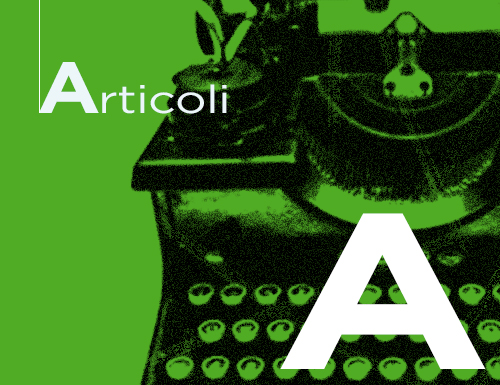
Le epoche della vita trapassano in modo opaco le une nelle altre, nella stessa continuità con cui al giorno segue la notte. Eppure vi è un istante significativo in cui possiamo dire che in quel preciso momento, in quell’incontro irripetibile di spazio e tempo, è arrivata la notte, la giovinezza è per sempre svanita, insieme al suo repertorio di speciali sapori. Il tempo sembra attraversato da tonalità cromatiche diverse, qualità peculiari che ci investono come onde, attraversando le nostre esistenze.
È forse in una di quelle fotografie del passato che di tanto in tanto andiamo a disseppellire, scattata per caso «da uno di quei giovanotti che, la Leica alla guancia, appostano i passanti sui marciapiedi»(1), che riemerge la verità di un tempo segnato dal destino, una verità che sembra non avere un prima e un poi, che Dino Buzzati cercò incessantemente nei mondi del fantastico e nell’amore, sommo ed impenetrabile mistero.
Amore e mistero si uniscono, quasi alludessero ad una speranza la cui fiamma dev’essere tenuta viva. La bellezza ed il mistero della donna amata sembrano d’un tratto potersi rivelare in «un’ora lontana di Napoli che mai si ripeterà»(2). Lei sola può vedere oltre la consueta coltre del visibile, come avesse diretto accesso all’empireo, alle idee eterne, a lei si schiudono visioni che appartengono già al mondo del fantastico o dell’ultramondano, apparentemente precluse all’uomo che la contempla estatico.
La donna, che di diritto appartiene già al mondo fascinoso dell’occulto, cammina con una venerabilità anfibia, di dea o automa, il fascino indiscernibile di chi miracolosamente concilia gli opposti: «Si direbbe che dinnanzi a lei aprasi una via sterminata e in fondo a questa un miraggio che non so e che la chiama»(3).
Eppure l’unico possibile trionfo, l’unica meta alla fine del tracciato del destino, non può essere per la donna-automa (che torna con una frequenza considerevole in Un amore) altro che la malora. Cosa vede lo sguardo di una donna, a quali verità ha accesso? Certamente è improbabile vada a posarsi sull’uomo perduto. La donna-automa pensa alle scarpe che le dolgono, la sua vista si perde nel mistero dell’esposizione della merce, intrattenendosi col frivolo piacere di un vestito nuovo – nulla di più, solo una serie di consuete miserie. Ogni attesa per un possibile mondo collocato oltre l’apparenza è destinata alla catastrofe.
Questo stesso sentimento – o presentimento – attraversa certamente la vicenda biografica del Buzzati scrittore, giornalista, disegnatore, amante e «clinico e vivisezionatore del cuore umano», come volle definirlo Montale nella sua raccolta di prose Il secondo mestiere.
Se il tema dell’incontro con quella che potremmo definire ulteriorità di senso è un topos che attraversa in modo costante l’opera di Buzzati, è certamente mediante le notti insonni di Giovanni Drogo ne Il deserto dei Tartari, i suoi sogni, le sue riflessioni notturne, le sue speranze e le sconfitte in guerre mai combattute che lo scrittore riuscirà ad esprimere, da grande narratore, le profonde inquietudini di un tempo qualitativamente diverso da ogni altro, quello della modernità.
La modernità appare come il luogo di una perdita, potremmo dire, di una profonda e lacerante dimenticanza. La vana curiosità sembra ammaliare l’uomo ed irretirlo entro un’attesa per quel mondo delle idee, o per un piano finalmente significativo, su cui l’apparenza dovrebbe in qualche modo poggiare: eppure, la modernità si presenta come assenza di fondamento.
In secondo luogo, se anche esistesse una verità oltre l’apparire dei fenomeni, sia nel mondo della città, sia nel contesto apparentemente santo e separato della Fortezza Bastiani, non ci sarebbe possibilità alcuna di raggiungerlo, proprio in ragione di quella fondamentale dimenticanza: la perdita della tradizione. Per questo, i mezzi ed i metodi che l’uomo ha a disposizione risultano inservibili: il linguaggio è lo stesso della città, non esiste alcuna lingua sacra che possa nominare l’essenza delle cose, gli atti che si compiono nella logica disciplinante del mondo militaresco sono ridotti a mero cerimonialismo. Perdita della Parola, scomparsa del gesto rituale.
Nel Deserto dei Tartari troviamo esattamente l’esperienza dell’uomo che vive in un’epoca che diffida di ogni valore e fondamento, pur essendone fortemente attratto. Qui agisce la rimozione: più un sentimento viene rimosso e più continua a operare sotto nuove forme; più Drogo tenta di sbarazzarsi della speranza dell’incontro decisivo, che dia senso al suo esistere, più l’esigenza di tale incontro risulta indomabile, fino a divenire la ragione stessa del suo vivere.
Drogo è avido di sapere, per certi aspetti sembra guidato dalla stessa passione filosofica per la conoscenza. Pessoa scrive che il principio fondamentale consiste nel comprendere come «nell’assoluto non ci sono né bene né male»(4), forse lo stesso principio che Buzzati immagina di cogliere nello sguardo della donna nella fotografia: «Come eri tu in quell’istante! Inconscia di bene e male»(5).
La filosofia è sempre anche gnoseologia: è in quanto teoria della conoscenza che la filosofia occidentale ha cercato di spiegare quelle leggi che regolano il rapporto fra soggetto ed oggetto, io e mondo, microcosmo e macrocosmo. E il momento tanto atteso da Drogo è quello in cui l’alterità nemica, l’altro da sé, può finalmente incontrarsi con l’io: solo allora l’eterna solitudine può essere spazzata via, solo nel momento sublime di quest’incontro la distanza fra microcosmo e macrocosmo viene colmata.
La ricerca di un segno, di un presagio, è ciò che permette la creazione di nessi significativi nel reale: lo vediamo anche nel breve racconto Lo scarafaggio; il nero animaletto mezzo morto non è che un simbolo di tutta una serie di legami che Jung chiamerebbe acausali: «C’è qualcosa, pensai: lei sogna, il cane urla, il canarino si è svegliato, la gente è alzata e parla, lei sogna la morte, come se tutti avessero sentito una cosa, una presenza»(6). Ed ecco quella presenza, moribonda sul pavimento. Al colpo di grazia della pantofola la normalità sarà magicamente ripristinata: «Allora finalmente il cane tacque, lei nel sonno si quietò e quasi sembrava sorridesse, le voci si spensero, tacque la madre, nessun sintomo più di irrequietezza del canarino, la notte ricominciava a passare sulla casa stanca»(7).
Se il mondo immaginato nel Deserto dei Tartari appare chiuso ed impenetrabile, un mondo senza scambi, senza transizioni, senza livelli differenti di coscienza, possiamo pensare che in questa sorta di solipsismo sia lo stesso Drogo a creare inconsciamente il proprio destino, che inevitabilmente gli si oppone in quanto irriconoscibile.
La scena dell’avvistamento del cavallo nel capitolo XII sembra una chiara allusione alla crisi del classico atteggiamento platonico. Drogo è «avido di sapere», e finalmente si accorge della presenza di un cavallo, «inverosimile cosa, fermo ai piedi della rupe. […] Era una cosa straordinaria, di significato inquietante […]. Questo cavallo spezzava la regola, riportava le antiche leggende del nord, coi Tartari e le battaglie, riempiva della sua illogica presenza l’intero deserto. Da solo non significava un gran che, ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose»(8).
Drogo si aspetta con assoluta certezza che al cavallo seguirà una serie infinita di cose – esso nasconde sicuramente dietro di sé un esercito intero, con tutte le avventure connesse. L’animale riluce di ciò che è veramente rilevante: la verità dell’idea. Sennonché, l’attesa e il dato di realtà mettono davanti agli occhi del giovane soldato il solito cavallo: dietro l’apparenza non esiste nient’altro.
Con l’idealismo l’oggetto verrà inteso come negativo prodotto del soggetto, non ancora ricompreso da quest’ultimo. Fu senz’altro Julius Evola ad esprimere con somma chiarezza, attraverso la teorizzazione del suo idealismo magico, non soltanto il senso teorico e pratico dell’idealismo, ma soprattutto il tema filosofico sotteso a gran parte della speculazione occidentale: il rapporto soggetto-oggetto, e quindi la possibilità di raggiungere un livello di libertà nella creazione soggettiva del reale. Questa via rappresenta forse l’unica possibilità iniziatica nella dimensione storica del moderno. Il fondamento, qui, non risiede nell’idea oltre il fenomeno, ma riguarda l’io che crea secondo volontà libera.
Così «tutto quel che è esiste in quanto posto dall’io»; se l’uomo è destinato ad incontrare l’alterità, «in quell’alterità non è compreso altro che quello che solo lui può aver inconsciamente posto come altro da sé»(9). E così Evola supera il limite meramente conoscitivo dell’atto puro gentiliano, di modo che l’io assoluto possa «intraprendere un vero e proprio percorso d’iniziazione»(10): ciò che deve essere trasformato è l’io medesimo.
Varrebbe la pena soffermarsi su questa radicalizzazione dell’idealismo, non solo per la sua potenza, la sua rigorosità ed il suo fascino, ma anche perché ci permetterebbe di guardare in modo nuovo all’opera ed al pensiero di uno scrittore che, come Buzzati, parla attraverso un mondo metaforico e simbolico di ricerca di senso, di crisi della metafisica, della possibilità per l’uomo moderno di avere accesso ad una dimensione intellettuale e spirituale capace di conferire dignità ad una vita.
La vita di Drogo è divenuta un’esistenza liminare, con i piedi nel noto e lo sguardo costantemente rivolto all’altrove. Non a caso al mondo della Fortezza appartiene la visione, è così poco separato da un punto di vista qualitativo che cerca il proprio superamento nell’esercizio disperato della vista, puntata su di un orizzonte utopico. Il mondo della speranza è fatto di feritoie, finestre e binocoli, è l’orizzonte tutto visivo in uno spazio desacralizzato.
Ma qual è il meccanismo che trattiene Drogo in questa zona di confine? Nel settimo capitolo, quasi fossero trascorsi i giorni interminabili di una creazione, Drogo riceve un mantello. È finita la giovinezza, un cancello si chiude alle nostre spalle e «si sente dire che il meglio è più avanti»: fra un po’, il tenente «sentirà il battito del tempo scandire avidamente la vita»(11). Drogo osserva l’eleganza del proprio incedere, scruta la sagoma della propria ombra. Un momento di autoesaltazione estetica destinato a durare pochi passi.
Il sarto Prosdocimo, il cui nome è legato in modo essenziale alla dimensione dell’attesa (prosdokein), lo aspetta nel buio di una cantina della fortezza. È da quell’incontro, forse il primo vero incontro con l’attesa, che Drogo inizia a cadere in una trama che lo irretisce in modo magico e totale, come si trattasse di una stregoneria. Il sarto è lì quasi per un equivoco, si capisce, un sarto come lui… In ogni caso, se è nella Fortezza lo è in modo non definitivo, la sua condizione è provvisoria, ambigua; Prosdocimo è allo stesso tempo altrove, fa parte della Fortezza ma appartiene ad altri luoghi, si trova fra le stesse mura da quindici anni eppure è convinto di essere in procinto di andarsene. Ad ogni modo, è evidente che nel suo mistero si nasconde una certezza, quella di un incontro che senz’altro avverrà, un incontro destinato ad essere decisivo. «Salvati finché sei in tempo» è il monito dell’aiutante zoppo. Ma ormai la malìa è tessuta, il cuore di Drogo è conquistato dall’utopia di un avvenire che sarà decisivo e che finalmente gli mostrerà il senso ultimo della sua vita.
Elémire Zolla ricordava che una magia fra le più arcaiche fu quella del telaio, e che Circe fu senz’altro iniziata all’arte del tramare destini sul suo magico strumento: «Ella si pone al confine fra tempo ed eternità […]. Il suo nome ribadisce questo insegnamento. Kirkos significa anello, è l’anello, s’è visto, che traccia lo sparviero nei cieli ed è il crocidìo del falco (kerkax) e del corvo (korax) e anche il gracchio del subbio, il bastone del telaio cui si intrecciano i fili dell’ordito (kerkìs)»(12). Signora del tempo, tesse gli eventi e lega gli esseri ad una forma determinata. Così Prosdocimo legherà Drogo alla forma dell’attesa.
I padri del deserto, un deserto che è, secondo l’etimo ebraico, assenza di parola – e quindi assenza di quella Parola Sacra che ha il potere di dirigersi in modo diretto sulla cosa, essendo essa stessa logos, la ragione, radice divina dei fenomeni –, paragonavano la prima veste di Adamo all’acquisizione della dimensione corporea successiva al peccato. Ma nel Deserto dei Tartari, perfetta metafora del mondo moderno, non esiste più, come abbiamo visto, linguaggio sacro.
La fortezza ha rituali vuoti, parole che non conducono ad un grado superiore di consapevolezza, ad uno sguardo più ampio sulle cose, ma servono solo ad accedere alla perenne consuetudine del già noto. Che differenza c’è fra il microcosmo della Fortezza e la città? Sembra che in entrambe non ci sia via di fuga dall’ordinario.
Buzzati è uno scrittore che narra la fine della metafisica, mettendoci in guardia nei confronti dei pericoli della contraffazione parodistica in atto nelle “iniziazioni” moderne, le quali riguardano la dimensione quotidiana della vita dell’uomo medio, dal lavoro alle vacanze, fino a spiritualità improvvisate.
In effetti, cosa insegna un rituale? Certamente la ritualità soddisfa un’esigenza di ordine, rappresenta, in termini spaziali e temporali, la possibilità di creare in qualunque luogo uno spazio sacro e di dare un nuovo inizio al tempo. Allo stesso modo, il rito diventa una sorta di stratagemma per la mente, grazie al quale si genera uno spaesamento per cui il pensiero è costretto a adottare soluzioni impensate per raggiungere un fine.
Eppure, il rito non riguarda soltanto l’instaurazione di un tempo originario e di uno spazio separato, ma rappresenta uno strumento per la generazione del Nuovo e quindi un valido mezzo per sottrarsi alla costrizione ripetitiva della necessità. La celebrazione di solstizi ed equinozi, tanto per fare un esempio, è una ciclica ripetizione attraverso cui è possibile uscire dalla ripetizione stessa, grazie all’apertura delle porte solstiziali(13).
Anche il mondo moderno ha le sue iniziazioni, come lo stesso Max Weber ci ricorda, ma si tratta di iniziazioni incapaci di dar vita ad un senso nuovo e sottrarci al peso della necessità. In questo smarrimento ci si affida, come Drogo, al sentito dire della chiacchiera o alla semplice curiosità.
A diciott’anni dalla pubblicazione del Deserto dei Tartari, in uno stile aperto alla sperimentazione creativa, al monologo interiore di matrice joyceiana, scrivendo Un amore Buzzati riprodurrà in una narrazione più autobiografica e quotidiana la fascinazione per un sentimento senza speranza nei confronti di una ballerina della Scala, conosciuta in una casa di appuntamenti.
Anche qui, l’amore per la giovane prostituta è metafora di un’attrazione viscerale nei confronti dell’inconoscibile, attrazione che sembra costantemente e tragicamente destinata al fallimento, come dicevamo a proposito dello sguardo della donna-automa; si tratta di un amore impossibile alla cui origine ritroviamo la volontà da parte del protagonista, un rispettabile borghese di Milano, di conoscere ciò che si nasconde dietro il fascino seducente del femminile, dietro le eterne bugie, oltre l’incompressibile atteggiamento di una ragazzina che incarna un costante mistero. Ma era solo l’interesse per il denaro a muovere il meraviglioso corpo di quella giovane donna, niente di più, nessun senso nascosto dietro le continue bugie, tutto è esattamente così come sembrava a prima vista, come l’evidenza lascia supporre.
Senza un apparato mitico, simbolico e rituale, senza adeguate chiavi di lettura, l’uomo moderno è incapace di condurre una vita pienamente umana; ed ecco che il mantello indossato da un soldato di nome Giovanni, che questa volta ritorna dalla madre, nei Sessanta racconti, rappresenta forse, in senso fatale, l’abito dell’attesa, tessuto con vane speranze, che nasconde un corpo sanguinante, ferito: un tragico destino di morte.
Note
- Dino Buzzati, Una fotografia di ragazza, in In quel preciso momento, Mondadori, Milano 1950, p. 97.
- Ivi, p. 98.
- Ibidem.
- Fernando Pessoa, Pagine esoteriche, Adelphi, Milano 1997, p. 47.
- Dino Buzzati, Una fotografia di ragazza, cit., p. 98.
- Dino Buzzati, Lo scarafaggio, in In quel preciso momento, cit., p. 133.
- Ivi, p. 135.
- Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, in Opere scelte, Mondadori, Milano 1998, pp. 88-89.
- Massimo Donà, Evola e la filosofia, in Aa. Vv., Julius Evola e la sua eredità culturale, a cura di Gianfranco de Turris, Edizioni Mediterranee, Roma 2014. A tal proposito si veda il concetto junghiano di libido (cfr. Carl Gustav Jung, Simboli della trasformazione, in Opere, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino 1992), molto vicino alla prassi dell’io assoluto evoliano in quanto Jung vede nella libido un’energia inconscia capace di creare incessantemente la realtà.
- Massimo Donà, op. cit., p. 84.
- Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, cit., p. 49.
- Elémire Zolla, Verità segrete esposte in evidenza. Sincretismo e fantasia. Contemplazione ed esotericità, Marsilio, Venezia 2003, pp. 137-38.
- Cfr. René Guénon, Simboli della Scienza sacra, tr. di Francesco Zambon, Adelphi, Milano, 2006.






































