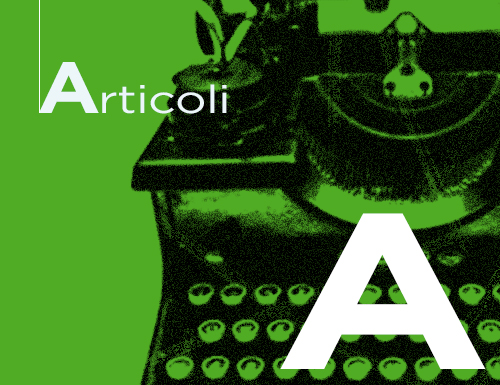
Buzzati può essere considerato uno dei massimi narratori del Novecento italiano. Le sue opere, nonostante siano passati quasi ottant’anni dalle loro prime edizioni, non hanno perso forza evocativa e favore del pubblico. È interessante notare quali siano i temi da lui amati, i più presenti nella sua produzione. Domenico Porzio ne fornisce un elenco: «L’inquietudine delle attese, il precipite rotolare del tempo, la muta bellezza delle montagne, gli incubi notturni, la atterrente indifferenza del destino, l’illusione della spavalda giovinezza, lo spavento che scaturisce da una minima ed ammonitrice smagliatura nella norma, la vanità delle glorie e delle ambizioni mondane, la precarietà dell’amore, i mostri improvvisi, la solitudine irrimediabile, l’inganno della medicina, la magia racchiusa nell’ovvio, la straziata pietà per gli indifesi, i vecchi, gli animali, la condanna della stupidità massificata ed il ricorrente, sconsolato appello alla fantasia liberatrice»(1). Nel suo inventario, Porzio non cita un tema che a parere di chi scrive è sempre presente nella sua narrativa, per lo meno dagli anni Cinquanta in poi: l’antimodernismo.
Buzzati pubblica il suo primo romanzo, Bàrnabo delle montagne, nel 1933, appena otto anni dopo che Pirandello ha dato alle stampe la versione corretta dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore e dieci esatti dopo La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Buzzati appartiene alla generazione immediatamente successiva a quella che scrive dell’affermarsi della modernità, interpretandola col tema dell’inadeguatezza. Come ben nota il critico Giorgio Luti(2), le opere coeve a Svevo e Pirandello descrivono l’inquietudine dell’uomo moderno, la nuova coscienza storica della borghesia che sente esaurirsi il proprio compito sociale e la propria funzione direttiva. Un senso che accumuna a livello europeo tutti gli intellettuali del tempo, da Joyce a Proust, fino a Kafka.
Giungendo negli anni immediatamente successivi, Buzzati ha modo di assistere alla tragedia della Seconda guerra mondiale, alla ricostruzione, al boom economico. Ecco dunque che sorge in lui un forte disagio di fronte alla necessità di tagliare le radici culturali con la tradizione e annegarsi in una massificazione incolore. Secondo lui, l’individuo assoggettato a questa esigenza si trova in uno stato d’ignoranza ansiosa, di perenne disposizione alla fuga di fronte a tutto ciò che risulti diverso da quanto, come gli viene detto, non rientra nella costruzione del migliore dei mondi possibili. Si tratta di un tema forte, presente sia nelle opere a sfondo fantastico sia in quelle mimetiche.
Si prenda ad esempio il romanzo Un amore, del 1963(3). Basata su un’esperienza autobiografica, quest’opera racconta di un architetto di mezz’età, Antonio Dorigo, che s’innamora della giovane prostituta Laide. La storia è ambientata in una Milano in preda alla frenesia del boom economico. Il sentimento con cui si confronta il protagonista, cercando disperatamente di sfuggirvi, diviene qui metafora della caduta dell’uomo moderno nel meccanismo massificatore.
Giova ricordare che il romanzo vede la luce nel periodo storico in cui escono altri titoli che in maniera analoga riflettono sullo stesso argomento. Pochi mesi prima del romanzo di Buzzati, per esempio, le librerie registrano il successo de La vita agra di Luciano Bianciardi(4), e contemporaneamente vince il premio Strega Il maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi(5).
Tutti e tre gli autori si trovano accumunati nel contemplare la ferocia con la quale l’Italia si spoglia delle proprie tradizioni, correndo verso piatti modelli consumistici.
Bianciardi è il più esplicito. Nel suo romanzo si legge: «Tutti questi sono i sintomi, visti al negativo, di un fenomeno che i più chiamano miracoloso, scordando, pare, che i miracoli veri sono quando si moltiplicano pani e pesci e pile di vino, e la gente mangia gratis tutta insieme, e beve. […]
«I miracoli veri sono sempre stati questi. E invece ora sembra che tutti ci credano, a quest’altro miracolo balordo: quelli che lo dicono già compiuto e anche gli altri, quelli che affermano non è vero, ma lasciate fare a noi e il miracolo ve lo montiamo sul serio, noi.
«È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l’occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, l’età media, la statura media, la valetudinarietà media, la produttività media e la media oraria al giro d’Italia.
«Tutto quello che c’è di medio è aumentato, dicono contenti. E quelli che lo negano propongono però anche loro di fare aumentare, e non a chiacchiere, le medie; il prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l’automobile l’avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno, l’asciugacapelli, il bidet e l’acqua calda.
«A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi l’un con l’altro dalla mattina alla sera»(6).
Mastronardi palesa il medesimo malessere di fronte a questo nuovo modello di società. Ed è interessante che, come Bianciardi, individui nell’automobile uno dei principali oggetti del desiderio consumistico. Ad esempio, scrive: «Mi fermo dinanzi a una vetrina di automobili. Non l’ho mai vista: è nuovissima. Cerco di ricordarmi che cosa c’era prima di quella vetrina. Non ricordo. Qualcosa è avvenuto, qualcosa è cambiato. Vigevano ha un negozio di automobili. Sono contento. Non per il negozio di automobili, ma perché qualcosa è cambiato. E un poco anche per il negozio di automobili.
«Proseguo nel mio camminare pensando: qualcosa è cambiato. E mi sembra strano di essere contento, eppure quel negozio mi ha dato una sensazione di gioia. Così pensando sono arrivato alla fine del corso. Più avanti si perde nel buio lo stradale che porta a Novara. Io proseguo nel mio camminare. Mi immergo nel buio e sento di essere solo completamente.
«[…] “Ma perché sono contento che abbiano messo un negozio di automobili?”, mi domando. Sento la mia voce suonarmi strana a me, ma gradevole: con un’intensità misteriosa.
«Su un cancello intravedo un’ombra di donna. È scesa dalla macchina. Se ne sta ferma, come in attesa. […]
«– Che tempo! – dico.
«– Duemila anticipate, – risponde.
«– Si chiama Eva?
«– Sì perché?
«[…] Ella mi precede lungo un sentiero che finisce in una corte. Entra in una porta, dove una vecchia sta facendo il gioco delle carte. Mi porta dietro, in una specie di cantina.
«Si spoglia con quella meccanicità di puttana; quindi si stende nuda sulla branda.
«Il suo corpo non emana nessuna luce: è il corpo di una donna nuda comune. Nessuna armonia c’è in quelle forme. Mi sembra di guardare una fotografia pornografica.
«[…] Torno a casa con passo stanco. Per tutto il corso penso a Eva. Anche lei è cambiata, penso. Un senso di tristezza mi avvolge. Sono proprio stato con Eva, penso, con Eva.
«Mi fermo alla luce della vetrina di automobili e mi dico: “Consolati! Hanno messo un negozio di automobili!”»(7).
A una narrazione tradizionale, ancorché fortemente psicologica, in Un amore Buzzati affianca lunghi brani in cui propone una rivisitazione in chiave popolare del flusso di coscienza.
Per questa ragione non si possono rintracciare nel testo passi eclatanti di denuncia, come avviene con Bianciardi. E neppure brani illuminanti, come quello riportato di Mastronardi. Il disagio antimodernista viene piuttosto tenuto sullo sfondo della narrazione, proposto continuamente al lettore in frammenti disseminati nel testo.
Ecco, a titolo d’esempio, alcuni brani, uno dei quali – è interessante notarlo – si sofferma come gli altri due narratori sull’oggetto automobile quale simbolo della modernità imperante: «Tremila per sera più la vendita dei fiori più gli incerti mi capisci, non farai qui da me la schizzinosa, tutto sta ad agganciarli certi vecchietti che se li scuoti fanno din din da tanto sono pieni di marenghi la Milka ne ha pelato uno quest’autunno ch’era uno spettacolo da tanto ributtante ma ci ha rimediato la mezza pelliccia di visone l’hai vista no?
«[…] In lei, Laide, viveva meravigliosamente la città, dura, decisa, presuntuosa, sfacciata, orgogliosa, insolente. Nella degradazione degli animi e delle cose, fra suoni e luci equivoci, all’ombra tetra dei condominii, fra le muraglie di cemento e di gesso, nella frenetica desolazione, una specie di fiore.
«[…] Quel senso delle case intorno una attaccata all’altra, verticalmente rigide, grigie, sature di vite umane, sipari tremendi uno sull’altro asserragliati stipati intorno alla piccola chiesa ottocentesca dai muri neri scolanti. […]
«Al ritorno dal ristorante di Corsico, lungo il Naviglio, nella sera di maggio profumato, al volante della bella macchina, col vento che gli dava uno strano fastidio nella nuca, con una bella donna al fianco di cui non conosceva neanche il nome e di cui se ne fregava totalmente, coi lumi dei lampioni che scorrevano via, gli sguardi incuriositi o invidiosi dei passanti, col pensiero che all’indomani la avrebbe rivista, con la meravigliosa consapevolezza che la Laide, per la prima volta lo aveva chiamato, con la levità che gli dava l’immersione nell’aria blu della notte, con quel senso inebriante di nudità che dà la macchina aperta […]. Con quella macchina arriverà un uomo in gamba, ricco, sportivo, disinvolto, moderno, giovane, come i fusti dei film di moda. Le farà una magnifica impressione. Vedendolo arrivare con una spyder sport Laide non potrà più considerarlo un intellettuale, uno sparuto, un povero borghese. Quella macchina gli permetterà di entrare finalmente nel suo mondo, con pieno diritto di cittadinanza, il mondo degli uomini ricchi e impavidi che manovrano le ragazzette povere come fossero automobili, anzi con maggiore indifferenza, e loro li stanno a guardare intimidite e si lasciano passivamente pastrugnare»(8).
Buzzati riserva alla produzione breve – del resto, una sua peculiarità – l’esplicazione del suo j’accuse. Non è possibile, dato lo spazio a disposizione, mostrare tutti gli esempi che si vorrebbe. Ci si limiterà a citare la raccolta Il colombre e altri cinquanta racconti, apparsa nel 1966, e in particolare il racconto che dà il titolo e introduce l’antologia. Vi si narra di Stefano, il quale per tutta l’esistenza fugge la bestia mostruosa che lo insegue per tutti i mari. Finché, ormai vecchio e stanco, si lascia raggiungere. La bestia allora gli parla: «“Non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l’incarico di consegnarti questo”.
«E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente.
«Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell’animo. Ma era ormai troppo tardi»(9).
La metafora è quella dell’uomo contemporaneo, abbagliato dal possesso di beni materiali. La cupidigia tiene l’uomo moderno in uno stato di continua e inutile insoddisfazione. Il meccanismo è stato spiegato da Umberto Eco: «Un consumismo che non mira al possesso di oggetti di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia senza scopo»(10).
Come scrive Milan Kundera ne La lentezza, «il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio»(11). Il romanzo di Kundera è del 1995. Dunque, trent’anni prima Buzzati ha percorso la stessa strada, intuendo che la lentezza (tipico valore tradizionale) viene interpretata come la morte sociale dell’individuo. Col termine lentezza non s’intende il valore perduto di cui si dolgono Pirandello e Svevo, ma la necessità di adeguarsi ai consumi per non restare separati dagli altri. Perché, come nota Zygmunt Bauman, «la sindrome consumistica abbrevia radicalmente l’aspettativa di vita del desiderio e la distanza temporale tra il desiderio e la sua gratificazione, e tra quest’ultima e il cestino dei rifiuti. La “sindrome consumistica” è fatta tutta di velocità, eccesso e scarto»(12).
Per questo, dunque, Stefano fugge e solo dopo aver sprecato la propria esistenza si ferma, rendendosi conto di essere sfuggito alla mitica Perla del Mare, che dona la pace dell’animo.
* * *
Buzzati scrive le sue opere di maggior successo nel periodo in cui si esplica con maggior entusiasmo l’attività dell’avanguardia conosciuta come Gruppo 63. Ispirandosi alle avanguardie di inizio secolo, il Gruppo 63 si richiamava alle idee del marxismo e allo strutturalismo. Fu dunque inevitabile che Buzzati finisse sotto gli strali dei suoi esponenti.
Lo scrittore risultava essere stato iscritto al Partito Fascista, come molti intellettuali della sua generazione, ma a differenza di altri non aveva mai fatto pubblica abiura di quella sua appartenenza. Inoltre, era indubbio il fascino che provava per il mito, declinato in diverse forme: la guerra (specialmente quella navale), la montagna, il soprannaturale, le grandi personalità del suo tempo.
Inoltre, la sua produzione letteraria è illuminata da una sorta di italiano medio, netto e grammaticalmente perfetto, del tutto scevro da intellettualismi, frutto della volontà di mediare tra la necessità di narrare e l’uso di un linguaggio asciutto e concreto, assai simile allo stile giornalistico. Eugenio Montale, cui questo stile piaceva, precisò – riferendosi alla sua attività giornalistica – che in Buzzati la narrativa era «lo stesso guanto, ma rovesciato»(13).
Queste sono le ragioni per cui l’opera del nostro, in particolare Un amore, venne criticata ferocemente. Si giunse perfino a organizzare un grottesco processo al romanzo in una libreria milanese.
E questa è la ragione per cui i romanzi antimodernisti scritti da autori classificati di sinistra (come Bianciardi e Mastronardi) sono stati osannati, mentre intorno a Buzzati si è creata una vera e propria coltre. Ancora oggi, si può leggere online l’intervento redatto da Marcello Carlino nel 1988, in cui afferma: «Un amore esprime appieno i cedimenti dello scrittore ai miti e alle mode e insomma al mercato della letteratura: correva l’anno 1963, quando, mentre pullulavano i primi best sellers, veniva allo scoperto la feroce contestazione della neoavanguardia. […] L’intreccio è ancora di quelli ben oliati e a forte tenuta ed esibisce, con uno strisciante e remunerativo moralismo, tutti gli ingredienti di una narrativa di consumo: una storia d’amore spesso pruriginosa e piccante, un personaggio femminile – Laide – che è l’erotica Lolita di turno, gelosie sempre gradite al lettore e una montante febbre di vita che brucia e ringiovanisce l’architetto Dorigo»(14). All’autore viene successivamente rimproverato: «La caduta del fascismo, la sconfitta militare e la Resistenza provocarono un acuto senso di disagio nel Buzzati. L’Italia toccava il fondo della crisi; venivano spazzati di colpo e cadevano come un castello di carte le idealità e i miti, quello militare soprattutto, che tanto avevano fatto breccia nel narratore»(15).
Il valore antimodernista, ancorché sottotraccia, viene passato sotto silenzio. Interessante invece che le opere del nostro continuino ad essere proposte e acquistate in libreria, segno che il suo messaggio viene perfettamente recepito dal lettore. L’autore ci dice che la conseguenza della nostra adesione alla società liquida è la perdita della capacità di sognare e immaginare.
Buzzati morì di un tumore al pancreas nel gennaio 1972. Curando la sua ultima antologia, Le notti difficili(16), ebbe a raccogliere una summa del suo pensiero, e pose in testa al volume il racconto breve Il Babau. Vi si narra la storia di un paese moderno nel quale, essendo divenuto ingombrante e inutile, si decide di uccidere il Babau, la bestia mitica che infesta le notti per far paura ai bambini che non vogliono dormire. Perché «consentire, in una metropoli che si vantava di essere all’avanguardia, il perpetuarsi di un simile sconcio, degno del medioevo?»(17).
Ci piace terminare questo articolo con la morale contenuta nell’ultimo paragrafo del racconto: «Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia. Avido di sterminarti, il mondo civile ti incalza alle calcagna, mai più ti darà pace»(18).
Note
- Domenico Porzio, Introduzione, in Dino Buzzati, Le notti difficili, Mondadori, Milano 1979, p. 6.
- Cfr. Giorgio Luti, Svevo, La Nuova Italia, Firenze 1967.
- Cfr. Dino Buzzati, Un amore, Mondadori, Milano 1965.
- Cfr. Luciano Bianciardi, La vita agra, Rizzoli, Milano 1962.
- Cfr. Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Einaudi, Torino 1962.
- Luciano Bianciardi, op. cit., pp. 175-176.
- Lucio Mastronardi, op. cit., pp. 183-185.
- Dino Buzzati, Un amore, cit., pp. 44, 160, 46, 121-122.
- Dino Buzzati, Il colombre e altri cinquanta racconti, Mondadori, Milano 1966, edizione del 1973, p. 14.
- Umberto Eco, La società liquida, in Pape Satàn Aleppe, La nave di Teseo, Milano (prima edizione digitale: 2016).
- Milan Kundera, La lentezza, Adelphi, Milano 1995, p. 45.
- Zygmunt Bauman, La cultura consumistica, in Consumo dunque sono, Laterza, Roma-Bari 2009 (prima edizione digitale: 2011).
- Eugenio Montale, L’artista dal cuore buono, «Il Corriere della Sera», 29 gennaio 1972.
- Marcello Carlino, Buzzati Traverso, Dino, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, vol. 34, Istituto Treccani, Roma 1988 (articolo disponibile online).
- Ibidem.
- Cfr. Dino Buzzati, Le notti difficili, Mondadori, Milano, 1971.
- Dino Buzzati, Il Babau, in ivi, p. 9.
- Ivi, p. 12.






































