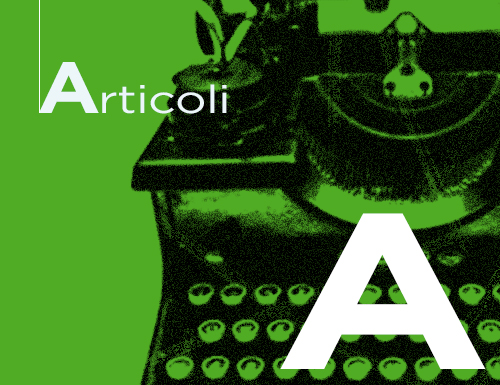
«Non voglio diventare come voi».
Con questa battuta la giovane Cristina si commiata da Piero “Er Patata” Ruffolo, interpretato da Carlo Verdone, suo professore nonché amante. Ed è in questa battuta che si condensa il significato di Compagni di scuola (1988), riflessione dolceamara su uno scontro generazionale, fotografia triste di una generazione ubriacata dalle illusioni e poi abbandonata a se stessa, sola con i suoi incubi.
Tutto in una notte. Nell’unità temporale e parzialmente spaziale, di aristotelica memoria, in cui si dipanano le vicende di Compagni di scuola, le vite, le storie, le circostanze private e pubbliche dei protagonisti subiscono una scossa, una frattura, una fine. Momento di transizione, talvolta violento, talvolta armonioso, la notte messa in scena in una tra le punte di diamante del cinema verdoniano è la fine attraverso cui passare per ricominciare. E non è un caso che passi attraverso il filo della memoria. Compagni di scuola è, innanzitutto, un nostalgico tributo ai tempi che furono, al passato come croce esistenziale, come àncora che impedisce uno slancio verso il futuro. La gioventù, l’innocenza, l’intraprendenza, l’idealismo: la giovinezza come istante utopico in cui il futuro deve ancora concretizzarsi, in cui tutto è possibile, in cui il presente offre qualsiasi possibilità. La gioventù è quel momento irripetibile in cui ragazzi e ragazze si sentono invincibili, dèi scesi in terra, creature indistruttibili. E il tempo viene percepito come un elemento irrisorio, il futuro solo qualcosa di distante, annebbiato.
Parimenti a Il grande freddo di Lawrence Kasdan (1983) a cui è dichiaratamente ispirato, Compagni di scuola è un’istantanea sulla morte dei sogni. Sebbene Tullio Kezich, in una delle prime analisi del film, abbia scritto che l’opera non contenga una vera e propria critica generazionale, nel sottotesto del film emergono riflessioni interessanti. Il gruppo di amici che si ritrova a quindici anni dal diploma appartiene alla generazione nata negli anni Cinquanta e che si saluta l’ultima volta nei Settanta. Il ’68 si è ormai esaurito e l’Italia, su forte spinta del boom economico, è una realtà che si appresta a fare i conti con tensioni politiche mai sopite: il decennio degli Anni di piombo, culminante con il sequestro e la morte di Aldo Moro. Quei ragazzi crescono così, in un contesto di frizione ideologica che sfocia in veri e propri atti di violenza. Poi gli anni passano, arrivano gli Ottanta con le loro opulenze, le loro superfici, la dimensione di ampolla artificiosa. Cosa è rimasto, nel 1988, dei sogni degli anni Settanta? Un desiderio di successo nonostante il fallimento sia contesto esistenziale difficile da accettare (Bruno Ciardulli, interpretato da De Sica); sogni di famiglia e affetto frantumati contro il muro della realtà (Gioia Savastano, cui presta il volto Carmela Vincenti, ma anche Gloria Montanari, incarnata da Luisa Maneri); amori creduti perduti e improvvisamente rinati; amori in ritardo che muoiono definitivamente quella notte. Ogni personaggio è un microcosmo che è anche icona di una dimensione esistenziale ben precisa, figlia della disillusione. C’è Santolamazza (Alessandro Benvenuti) che si finge menomato e che, con preciso contrappasso, rimane ferito alla gamba su vendetta di Ciardulli. Poi ci sono alcuni personaggi-chiave, fondamentali per analizzare lo spessore di Compagni di scuola. C’è il fugace Fabris (Fabio Traversa) per il quale il tempo è stato inclemente, oggetto di scherno da parte di tutti, il primo ad abbandonare la festa prima del suo inizio. Fabris è il realista che si rende conto di come ciò che si sta concretizzando in quella villa sia la celebrazione del vuoto esistenziale di una generazione. E così abbandona, tornando alla sua quotidianità, al suo presente, dicendo addio risolutivamente al passato e rinunciando alla speranza che quel momento e quel luogo possano rappresentare una sterzata. C’è il personaggio dell’onorevole Valenzani (Massimo Ghini), emblema della politica corrotta e drogata di potere. Quel potere lo fa pesare sempre e lo assolutizza attraverso l’atto di impossessarsi della povera Cristina. È un gesto, quello, in cui Valenzani palesa il suo successo in contrasto con i (molti) falliti che popolano la festa, in particolare con il personaggio di Verdone. Valenzani e Ruffolo polarizzano il dibattito sociale e politico che si nasconde nelle pieghe di Compagni di scuola. C’è Federica (Nancy Brilli) che organizza la festa e, alla fine, si scopre non avere più nulla. Lei vive quel momento con amarezza ma anche come liberazione, e quella notte è l’ultimo fuoco d’artificio di un’apparenza che è la fotografia del nulla. Infine c’è il personaggio di Piero Ruffolo, Er Patata, interpretato da Verdone. Molto simile a tanti altri caratteri cui ha dato vita nella sua carriera, è l’emblema della borghesia e della mediocrità. La sua crisi familiare è il sintomo di un disagio esistenziale, collocato in un contesto sociale ben preciso. È il più onesto nella sua sofferenza, quello che in effetti sembra azzerare la propria vita per poter rinascere come uomo nuovo. Ed è per questo che la rinascita, che parte dalle ceneri di un fuoco impietoso scandito da eventi ben precisi, passa attraverso il confronto con Cristina, la giovane studentessa che decreta la fine della loro storia (e il passaggio alla maturità) affermando: «Non voglio diventare come voi».
Ciascun personaggio è un mondo a sé, un pianeta che orbita attorno a quella follia imprevedibile che è la vita. Ciascun personaggio è teatrante di se stesso.
Compagni di scuola è tra i film meno divertenti di Carlo Verdone e tra quelli più difficili da decifrare. Gode di suggestioni che richiamano il cinema di Marco Ferreri – in particolare La grande abbuffata (1973), pur rinunciando alla radicalità di quel capolavoro – ma anche alcuni momenti fracassoni e ingenui di Amici miei (1975) e di parte del cinema di Mario Monicelli. Certo, offre momenti di bassa comicità, talvolta stanca e stantia, ma in generale non si pone come commedia pura, semmai come summa del cinema di Carlo Verdone. Attraverso le sfumature della commedia, Compagni di scuola vibra di una nostalgia che è il vero fulcro del cinema verdoniano e che diventa lo strumento con cui l’autore romano interpreta la variegata e schizofrenica società italiana.
CAST & CREDITS
Regia: Carlo Verdone; soggetto: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Rossella Contessi, Carlo Verdone; sceneggiatura: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Carlo Verdone; fotografia: Danilo Desideri; scenografia: Giovanni Natalucci; costumi: Luca Sabatelli; montaggio: Antonio Siciliano; musiche: Fabio Liberatori; interpreti: Carlo Verdone (Piero Ruffolo), Nancy Brilli (Federica Polidori), Christian De Sica (Bruno Ciardulli), Angelo Bernabucci (Walter Finocchiaro), Massimo Ghini (Mauro Valenzani), Eleonora Giorgi (Valeria Donati), Athina Cenci (Maria Rita Amoroso), Natasha Hovey (Cristina); produzione: Mario e Vittorio Cecchi Gori per Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica; origine: Italia, 1988; durata: 118’; home video: dvd CG Entertainment, Blu-ray inedito; colonna sonora: inedita.






































