Zenit e nadir della gloriosa FC Steaua Bucuresti
Claudio Bartolini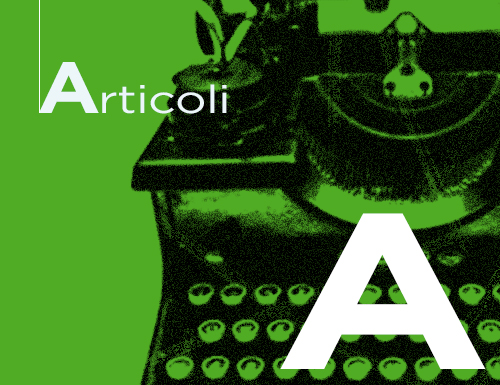
20 aprile 2013, quartiere Ghencea, Bucarest, Romania. Giornata grigia, nuvolosa, plumbea. Strade semideserte, automobili distrutte a bordo carreggiata, cani randagi in giro, un negozio (o meglio, una tenda) di pompe funebri a ribadire l’ovvio. Un tempo questa zona era il fiore all’occhiello del regime, il quartier generale della polisportiva Steaua, il luogo dove si coltivavano sogni di gloria europea e mondiale per dare lustro al governo. Un tempo c’era Nicolae Ceaușescu, Conducător di una dittatura che era immagine, culto della personalità, imitazione in scala ridotta della grandeur parigina tra rues, avenues e archi di trionfo. Un tempo passato, un ricordo sbiadito, un rimpianto che serpeggia nell’animo di chi, come Catalin Fainisi – addetto stampa della FC Steaua București –, è protagonista in prima linea di un ridimensionamento epocale.
Il quartiere Ghencea pare un paesaggio post-atomico, un accumulo di rovine, un museo a cielo aperto senza manutenzione. Lo stemma della polisportiva emerge da dietro un muro, fieramente malmesso, a ricordare a tutti che quel luogo è ancora la roccaforte dello sport della capitale e della nazione. Io e mia moglie attraversiamo la strada, quando Catalin ci raggiunge per aprirci le porte dello Stadio Ghencea, Templul fotbalului Românesc (letteralmente, “Tempio del calcio romeno”). Due giovani dell’esercito, la Forțele Armate Române, ci danno il benvenuto. Contraccambiamo il saluto e ci avviamo verso l’ingresso del Tempio, ma i soldati continuano a seguirci, mitra in mano. Catalin ci spiega che lo stadio è presidio militare e, sebbene la nostra visita sia stata approvata dal club, è necessario – per ragioni di sicurezza e regolamento – che la loro presenza sia costante. Ci viene concesso il privilegio di scattare fotografie, a patto però che non vengano diffuse al di là del loro utilizzo privato.
Capiamo immediatamente che il Ghencea non è solo uno stadio di calcio. Non lo è mai stato, del resto. È piuttosto un luogo di culto laico, un simbolo politico e militare, una roccaforte-caserma in cui l’esercito – fino al 1998 proprietario della polisportiva denominata, appunto, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, in seguito costituitasi a club privato – ha governato e tuttora governa. Se la società di calcio si è privatizzata, infatti, lo stadio è rimasto sotto la rigida egida militare.
Catalin ci spiega che ormai la FC Steaua București disputa la maggior parte delle gare nell’Arena Națională, struttura moderna e impersonale da cinquantacinquemila posti inaugurata il 5 settembre 2011. Al Ghencea si giocano soltanto match di secondo piano della Liga I romena: nonostante i rinnovamenti del 1991, 1996, 2006 e 2007 – con aumento a ventottomila dei posti a sedere, nuovo tabellone, riscaldamento del campo sotterraneo e restyling di poltroncine e spogliatoi – il Tempio è troppo piccolo, arretrato e insicuro per poter competere con il Moloch da globalizzazione del fotbal.
Entriamo nel ventre dello stadio, consapevoli del (fortunoso e fortunato) privilegio e ignari del fatto che, a partire dal 2014, la Steaua sarà definitivamente sfrattata dalla sua casa storica, stabilendosi all’Arena e abbandonando il Ghencea al suo destino di presidio fantasma.
Ci inoltriamo negli spogliatoi, quindi nella sala stampa e in quella riservata alle riunioni tecniche della squadra. Alle pareti le rose storiche degli anni Ottanta, quando Steaua era sinonimo di vittoria. Catalin ci accompagna nell’ufficio del presidente Valeriu Argăseală, quindi nelle stanze dove all’epoca dormivano giocatori e allenatore. La Steaua come seconda famiglia, ma anche caserma in versione sportiva, dunque. Le stanze sono scarne, disadorne, piccole e fredde come celle di una prigione. Mi sembra di vedere Gheorghe Hagi, Marius Lăcătuș e Iosif Rotariu seduti, a riposare tra un allenamento e l’altro, in attesa di rendere lustro al regime in un big match. Magari proprio in quel Dinamo București-Steaua del 3 dicembre 1988, trasformato nel film documentario Al doilea joc (The Second Game, 2014) dal celebre regista romeno Corneliu Porumboiu e arbitrato – sotto una tormenta di neve – dal di lui padre Adrian(1).
Una riflessione si insinua insistente e malinconica nel mio abitare per pochi attimi quei loculi: mi pare di intuire perché, una volta emigrata dalla natìa Romania dopo la rivoluzione del 1989, la maggior parte di quei giocatori fallì il passaggio dal calcio dilettantistico (obbligatorio nella dittatura comunista) a quello professionistico. In patria erano star di talento, ma anche soldati costretti a un’esistenza di privazioni e costrizioni, inquadrati tanto in schemi tattici di campo quanto in direttive partitiche di vita. Una volta approdati nell’Europa libera – quella che già a fine anni Ottanta ricopriva i campioni di miliardi e li consegnava al glamour delle feste e dei locali notturni –, molti persero la testa o si smarrirono. Da letale funambolo della fascia destra, Lăcătuș, fresco di allori al Mondiale di Italia ’90, divenne modesto comprimario nella Fiorentina(2); da fuoriclasse assoluto capace di essere sempre decisivo – finale di Supercoppa Europea ’86 compresa –, Gheorghe Hagi si trasformò in uno dei tanti “10” talentuosi ma incostanti del calcio, faticando a trovare spazio nel Real Madrid e finendo a giocare nel Brescia(3); da implacabile killer dell’area di rigore, il guizzante Ilie Dumitrescu recitò da comparsa tra Tottenham e Siviglia, consegnando alla memoria calciofila soltanto gli acuti in nazionale al Mondiale di Usa ’94.
Entriamo nel tunnel che conduce al campo. I militari, alle nostre spalle, iniziano a distrarsi, capendo di non essere al cospetto di spie ma di semplici appassionati dei “loro” colori. Sono metri di puro climax sentimentale, prima che l’emozione esploda all’apparire del prato. Percorro i passi fino al centro del rettangolo verde e poi giro su me stesso, a trecentosessanta gradi. Sono al centro della Storia, della Steaua e della Romania intera. Mi sembra di udire i cori festanti, mi par di vedere le bandiere in festa agitate dal popolo di Ceaușescu il 18 maggio 1986, alla prima apparizione casalinga in Cupa României (quarti di finale, avversario il Progresul București) dopo la vittoria della Coppa dei Campioni, il cerchio di centrocampo occupato dal logo del club con al centro la Coppa e sul perimetro la scritta: «Campioana a Europei 1985-1986». Abbandono il presente, i militari, Catalin e quelle meste tribune vuote e, per un attimo, scivolo in un passato di cui non ho esperienza diretta, ma solo ricordi filmati da altri…
7 maggio 1986, Spagna, Siviglia, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo stadio è una bolgia, il caldo insopportabile, i nervi a fior di pelle. Il fortino eretto dal leggendario libero Ștefan Iovan, dall’arcigno marcatore Adrian Bumbescu, dall’impavido difensore-goleador Miodrag Belodedici e dal quasi trentenne Ilie Bărbulescu a protezione della porta difesa da Helmuth Duckadam ha resistito per novanta minuti di tempi regolamentari e trenta di supplementari agli assalti del Barcellona. La finale di Coppa dei Campioni è da decidersi ai calci di rigore per la seconda volta nella storia(4). Sul dischetto si presenta lo spagnolo Marcos Alonso Peña, chiamato a tenere a galla i catalani dopo che i tiri di Lăcătuș e Gavril Balint – nonché le tre parate di Duckadam – hanno portato i romeni sul 2-0.
Peña contro Duckadam, occhi negli occhi. Lo spagnolo calcia alla sinistra del portiere, che si distende ed entra nella leggenda: quattro rigori su quattro parati, un record inarrivabile in una finale di Coppa dei Campioni. La Steaua è in cielo, capitan Iovan alza il trofeo, il calcio romeno tocca un vertice mai più raggiunto. Gioca in velocità, segna a ripetizione, si difende come una roccia. È calcio-spettacolo quello praticato dalla Steaua: moderno e agonistico, oggi lo potremmo paragonare a quello del Barcellona (il cerchio si chiude) allenato da Josep Guardiola sul finire degli anni Dieci del Terzo millennio. È il momento di massima gloria del club, della nazione, del regime di Ceaușescu, che invita a palazzo la squadra di ritorno da Siviglia per consegnare a ogni calciatore il riconoscimento ufficiale del regime. Gli atleti vestono tutti uguale – giacca grigio chiaro su pantalone nero, camicia bianca, cravatta nera – e come un piccolo esercito si schierano su due file, mani intrecciate dietro la schiena. Il Conducător li convoca uno dopo l’altro e stringe loro la mano, fiero della propria unità da combattimento sportiva. Poi chiama l’allenatore Emerich Jenei, il presidente-colonnello Nicolae Gavrilă e altri dirigenti-ufficiali. La Coppa dei Campioni è lì, a centro sala, a ricordare al mondo del calcio che football, nel 1986, si pronuncia fotbal.
La festa continua il 24 febbraio 1987, quando allo stade Louis-II di Montecarlo, Principato di Monaco, la Steaua – cui si è aggiunto Hagi, a ulteriore innalzamento del livello di squadra – si impone per 1-0 sulla Dinamo Kiev nella finale di Supercoppa Europea.
La festa finisce il 14 dicembre 1986, quando allo Kokuritsu Kasumigaoka Rikujō Kyogijō (Stadio Nazionale Olimpico di Tokyo) il River Plate supera i romeni con una rete di Antonio Alzamendi e si aggiudica la Coppa Intercontinentale.
Inizia l’incubo. La notte del 24 maggio 1989, il Milan di Arrigo Sacchi travolge e cancella per sempre dal calcio d’alto livello la Steaua Bucarest. Camp Nou di Barcellona, Milan-Steaua 4-0, due gol di Ruud Gullit e altrettanti di Marco Van Basten.
Il regime è finito, le sirene del calcio occidentale risuonano alle orecchie di Hagi e compagni, le gambe degli ormai logori Iovan, Bumbescu, Rotariu e Pițurcă non girano più come tre anni prima, le mani di Duckadam non parano più da un pezzo, forse vittime di una malattia, forse rotte dagli sgherri di Valentin Ceaușescu dopo che, di ritorno da Siviglia, il portiere si era rifiutato di donargli l’auto nuova di zecca regalatagli dal Real Madrid come “ringraziamento” per avere annientato gli eterni rivali di Barcellona(5). Il nuovo sport degli anni Novanta che avanzano si chiama calcio, non più fotbal. Si chiama zona, pressing, stranieri, miliardi. Il sogno sfuma e inizia un calvario senza più fine, che sprofonda la Steaua e il calcio romeno tutto nell’attuale preistoria calcistica.
Resta lo stadio Ghencea, memento mori di un’epoca che, ancora oggi, da quelle parti rimpiangono. Com’era verde quell’erba, come splendeva quella Coppa…
- Il film mostra, per tutta la sua durata, lo schermo con il match registrato, sulle cui immagini padre e figlio dialogano di calcio e politica.
- A Italia ’90 Lăcătuș si distinse soprattutto per la doppietta rifilata all’Urss del super-portiere Rinat Dasaev nel match inaugurale della Romania, vinto 2-0 allo stadio San Nicola di Bari il 9 giugno 1990.
- In seguito all’esperienza bresciana e all’incolore apparizione nel Barcellona tra il 1994 e il 1996, la stella di Hagi tornò a brillare nel Galatasaray di Istanbul sul finire della sua carriera.
- La prima era stata quella della stagione 1983-1984: Liverpool-Roma 4-2 allo stadio Olimpico di Roma, il 30 maggio 1984.
- Nessuno saprà mai la verità al riguardo. Mi limito a riportare le dichiarazioni fornite dallo stesso Duckadam, da me intervistato nel 2014: «È solo una leggenda [la rottura delle mani, N.d.A.]. Ho visto che è stato riportato anche di recente. Dicono che il Re di Spagna mi regalò un’auto che fu confiscata dai servizi segreti romeni e donata a Nicusor Ceaușescu (l’altro figlio di Ceaușescu, non Valentin). Tutto ciò non è vero, comunque. Sono passati ventotto anni e nessuno mi ha ancora regalato un’auto. Nel caso il Re di Spagna volesse omaggiarmi con questo presente, sarei molto onorato di riceverlo [ride, N.d.A.]».






































