Paura nella città delle streghe. L’influsso di Lucio Fulci e dei surrealisti in Le streghe di Salem
Davide Pulici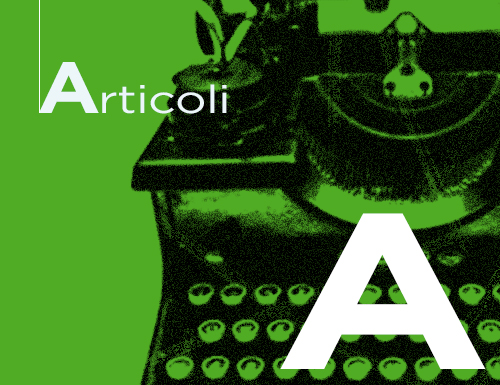
In altre circostanze mi è capitato di scrivere dell’“artaudianità” di Le streghe di Salem e di fare ricorso a tutti gli artifici più capziosi od oziosi per tentare di dimostrare – forse riuscendoci – che Rob Zombie aveva in un angolo non proprio remoto del suo cervello, quando prima scriveva e poi componeva il suo film, gli horror di Lucio Fulci dell’inizio degli anni Ottanta. Che poi sono gli horror, punto e basta. Un titolo che di sicuro gli ronzava nella testa, con tutte le sollecitazioni e influenze possibili e immaginabili, era Paura nella città dei morti viventi (1980). Non bisogna per forza pensare che lo conoscesse a memoria come noi fanatici e malati di mente, ma se si fa due più due è facile vederlo quasi per trance medianica, Rob Zombie, che mentre si documenta guardando film dove una maledizione ancestrale grava come una cappa di piombo sopra una cittadina che ha fama di collegamenti e ascendenze stregonesche, incappa in Paura – giusto citarlo con il titolo che aveva in sceneggiatura. Paura era qualcosa che faceva paura. Lo era di nome e la provocava di fatto. E anche Le streghe di Salem è un film che fa paura, perché trabocca di una energia aliena che non ha niente a che vedere con la merce horror che oggi si vende un tanto al chilo. Qui si viene spinti verso una inspiegabile condizione di disagio, che è inspiegabile solo finché ci si limita a constatare che Rob Zombie armeggia con materiali tradizionali: le streghe, il sabba, i roghi, l’anatema scagliato dalle femmine di Salem mentre le fiamme fanno gocciolare il grasso dalle mani e devastano loro il sembiante. C’è persino l’imposizione, ad abundantiam, di una maschera del demonio, qui piuttosto un’armatura del demonio, che fascia la capo-strega nella sua morsa di ferro comburente. L’abbiamo vista mille volte, da quando il boia ribattè l’ordigno, con le punte all’interno, sulla faccia di Asa/Barbara Steele in La maschera del demonio (1960) di Mario Bava. Ma non è questo, il film. Questa è solo un po’ di coreografia che andava giocoforza inserita per giustificare l’hashtag #streghe. Un atto dovuto. Non è certo lì che Le streghe di Salem spreme fuori dai nostri visceri l’orgasmo, la paura di attendere qualcosa che si sa che arriva, ma non si sa quando: il sentore della catastrofe prossima. Il senso forte e malato del disagio è, appunto, ciò che Zombie vuole e riesce a esprimere nel suo film. Il disagio della presenza del Diavolo o, per essere meno precisi al fine di essere più precisi, del Male. La quiddità del Male è ciò per cui primieramente ci ricordiamo di Paura di Fulci. Il Male come una marea che si alza, come un vento che comincia a soffiare e trascina nel suo flusso le carcasse non solo delle foglie, ma di tutte le cose umane. Non è un paragone improvvisato, attenzione: il vento soffia dove lo spirito del Male vuole. Esiste sia nel film di Zombie sia in quello di Fulci una congiunzione astrale, un trigono o meglio una quadratura su qualcosa che, in mancanza di termini più specifici, si potrebbe chiamare l’ambientalità malefica. L’ambientalità è il luogo, il tempo, l’atmosfera, il clima, il vento, l’aria, l’acqua, la terra ed è terrificante in un modo genuino, semplice ma molto sofisticato nello stesso tempo, sia qui sia là. Questo è il vero duende, l’energia aliena che sprizza da ciò che sembra insignificante, marginale, di scarso rilievo. Sheri Moon che passeggia con il cane nel mattino plumbeo, freddo e deserto di Salem; sempre lei che rientra a casa la sera dopo avere chiuso la sua trasmissione in radio, camminando per quelle vie dove non c’è nessuno, nel silenzio punteggiato solo dalle luci lampeggianti dei semafori fuori servizio. La quiete prima e durante la tempesta. Rob Zombie non sta girando sequenze tanto per riempire o perdere tempo: sono momenti altrettanto forti del film quanto il superamento della soglia della stanza invasa dal rosso, quanto il sogno chirurgico con le budella di guttaperca tirate fuori come elastici dalla pancia della signora Zombie. L’ambientalità, le cose intorno, di contorno ma che contorno non sono e sono la portata dissimulata. Anche Fulci attribuiva centralità a questi aspetti e lo fece capire magistralmente soprattutto in Paura, dove gli scorci dei notturni di Dunwich, con quelle strade troppo vuote, quegli spazi dechirichiani che formulano domande senza risposta, si insinuavano e turbavano ben più dei trapani che scavavano gallerie nella faccia dei disperati. Il Demonio, nelle sue trattazioni cinematografiche più efficaci, fa esattamente quello che secondo i mistici irlandesi come Scoto Eriugena fa Dio nel Creato: non si palesa mai direttamente, non ha manifestazioni faniche eclatanti, preferisce rendersi noto «morbidamente velato di ombre e colori». In Le streghe di Salem l’Avversario non è che non si mostri, ma viene avanti senza calare mai del tutto la maschera: è capro, bestia, ratto, pigmeo squartato, è l’uomo dalla faccia grigia e disfatta che porta a passeggio il cane nel parco in una mattina livida, è una specie di orco sciancato e peloso che sta lì, in pizzo sulla linea di confine tra la luce e la tenebra. È soprattutto sensazione di confine. È tutto ed è niente. La materia dei precedenti film di Rob Zombie è sempre stata pletorica, sovrabbondante: le cose marce e macabre erompevano e invadevano il mondo, la prassi, la routine. La casa dei 1000 corpi, per esempio. Lì c’era una grande fuoriuscita di materiale purulento dalla Terra e questo era il film ctonio e demonico per eccellenza. Certo, si ispirava a Non aprite quella porta (1974) che, negli anni Settanta, era stato il grande trionfo della carne marcia mostrata in pieno sole nell’horror, e che, nell’horror, aveva spalancato le porte all’avvento del Male insano. Però, anche in questo bailamme di materia, si avvertiva la necessità in Zombie di ravvisare un ordine più sottile nel caos, di reperire qualcosa all’interno del disordine e dell’entropia che rendesse ragione di essa. La casa dei 1000 corpi è molto fumo negli occhi come fenomenologia, ma conserva qualcosa di segreto e di prezioso che non si lascia troppo indagare e sfruculiare lì per lì. Lo si capisce poi, sulla media e lunga distanza, che il regista cerca e predilige, forse, la dissimulazione: il suo cinema gode nell’aspettare che la polvere e il sangue posino, per distinguere le silhouette che man mano emergono dietro la caligine arrossata. Il suo è un cinema di sagome, di indefinitezza, anche quando mette davanti agli occhi di chi guarda i peggiori abomini, gli spettacoli meno sostenibili. Sheri Moon, in una tra le sequenze più entusiasmanti e stupefacenti di Le streghe di Salem, è in cucina, appena dopo essere rientrata a casa – supponiamo che sia tarda sera, tra le undici e mezzanotte – e dà da mangiare al suo cane. Accanto al ripiano dell’acquaio, una delle streghe che erano state abbrustolite secoli addietro, nuda, completamente immobile, la osserva. Né Sheri Moon né il suo cane ne hanno il minimo sentore. C’è persino il rischio, tanto è, appunto, dissimulata, la situazione – l’inquadratura è in campo lungo, non dettaglia, non zooma su quello strano busto color ardesia che potrebbe persino sembrare una statua – che l’occhio di qualche spettatore bypassi il particolare. Zombie ripete la stessa pratica in un’altra sequenza – vuol dire che ci tiene – mentre la protagonista transita davanti a una stanza illuminata della propria casa, all’interno della quale c’è sempre la megera, nuda e grigia, immobile. Questo tipo di suggestione – la presenza impercepita, aurale, minacciosa ma silenziosa intorno alla protagonista – è ribadita una terza volta, in modo ancora più terrificante, quando di notte, sopra il letto della donna, penzola l’armatura di ferro nella quale era stata suppliziata la strega nei secoli che furono. Nel film la demonofania sta tutta su questi registri: è ambigua e angosciante perché è muta, non proferisce verbo, non elargisce spiegazioni. E non bisogna chiederne, perché ci troviamo in una zona onirica. E quando si vive un incubo o ci si riscuote da un sogno malvagio, spiegazioni non se ne possono avere. In questo senso, l’artaudianità di Zombie – che è la stessa di cui Fulci si vantava come di una specie di marchio doc dei suoi film – è una qualità raggiunta, è il puro elenco dei fatti per asindeto, senza l’uso di congiunzioni, senza ricorrere a nessi sintattici complessi, alla subordinazione, quando, mentre, poiché, perché. In Le streghe di Salem questo tipo di procedimento tocca lo zenit allorché l’Inferno ha spalancato le proprie cataratte nel teatro della città e mette in scena la sacra (cioè l’empia) rappresentazione della nascita dell’Anticristo dai lombi sanguinanti di Sheri Moon. A quel punto, la tecnica di Rob Zombie diventa simile a quella degli antichi decoratori di vasi greci a figure rosse, che delineavano il margine delle sagome che volevano far emergere dal colore ocra del fondo. Si chiamava tecnica a risparmio. Zombie è conscio che il contenuto dell’Inferno, il Male, il Diavolo e tutto quanto concettualmente gli si avvinghia, non è descrivibile in maniera diretta. Così ne definisce i contorni e lascia che il resto sgorghi fuori nella caoticità, sua natura centrale. Ha l’intuizione dello scenario teatrale – però tutto il film ha come sfondi e sottofondi le messe in scena, del cinema soprattutto: nella casa di Heidi la tv trasmette solo vecchi film e la testata del letto è una gigantografia femminile, mercuriale, della Luna di Méliès accecata dal razzo – sul proscenio del quale le tre streghe, come quelle del Macbeth, avanzano e recitano il loro delirante monologo. Dopodiché, il flusso erompe e la paratassi selvaggia delle immagini ha un sopravvento feroce su tutto. Zombie cavalca verso la fine neanche più a briglie sciolte, ma buttando proprio via i finimenti. A quel punto, siccome non ha scherzato con i fanti in tutto quello che precedeva, nemmeno si esime dal lasciare stare i santi in quei dieci minuti di centrifuga di tutto l’immaginario (rock) satanico possibile. Butta dentro anche i vescovi, tre, con le facce cancellate da un ammasso di tela grigia – un effetto che ci riproietta direttamente nel cuore delle sconce magie degli anni Ottanta italiani, nelle opere d’arte macabra di Giannetto De Rossi, quindi di nuovo nel gorgo di Fulci – che si masturbano membri eretti e dipinti di rosso, con scandalo tutto italiano a condannare il film come blasfemo: Rob Zombie ringrazia. Dove c’è un vescovo, meglio se avvelenato, sconcio, stuprato o deturpato, c’è un surrealista. E la conclusione di tutto, con Sheri Moon-Madonna satanica che, sgravatasi di un vermone sbattente, guarda il cielo con occhi da martire in cima a un Gòlgota di cadaveri femminili, potrebbero averla immaginata e girata Jodorowsky, Arrabal o Cavallone. Invece lo ha fatto Rob Zombie. Fine. Applausi.






































