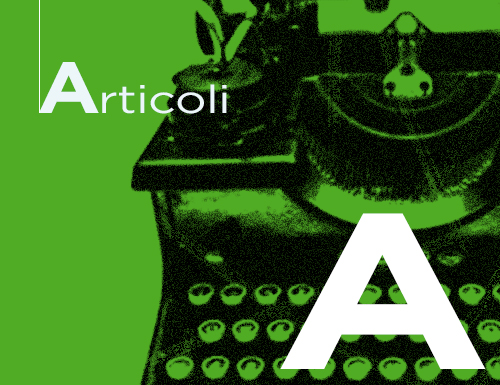
Apparso nel 1926 a Buenos Aires presso l’Editorial Proa, El tamaño de mi esperanza è una di quelle opere in prosa della stagione giovanile di Jorge Luis Borges – le altre sono Inquisiciones, del 1925, ed El idioma de los argentinos, del 1929 – che sono state ripudiate dall’autore. E di un ripudio netto si trattava, come si evince da quanto scrive María Kodama, cioè la giovane donna che stette accanto a Borges nei suoi ultimi anni di vita (a proposito, era india o giapponese? Quando, trent’anni fa, lo scrittore venne a Pesaro, in occasione della consegna del Labirinto d’Argento al Centro Studi Heliopolis, ce lo chiedevamo tutti: e forse qualcuno ci ha anche dato la risposta, ma noi preferiamo collocare l’inquieta e sollecita occhimandorlata María sopra una nuvola di intatto mistero) e che ora riferisce a futura memoria. Una sera del 1971, dopo che Borges era stato insignito del dottorato honoris causa a Oxford, ecco che, durante una chiacchierata con un gruppo di ammiratori, qualcuno accennò a quella dimenticata raccolta di saggi. Borges reagì con stupore (possiamo aggiungere con una lieve irritazione?), assicurando che quel libro non esisteva e dunque non valeva la pena cercarlo. Poi cambiò discorso.
Ma il giorno dopo uno studente gli telefonò, comunicandogli la ferale notizia: una copia di quel libro inesistente si trovava alla Biblioteca Bodleiana. Dunque, doveva essere qualcosa di cartaceo, di tangibile, non un fantasma, non una finzione né, tanto meno, una maldicenza! Con l’aria di chi si arrende al destino e deve fare i conti con la sorpresa di un’opera rimossa che grida vendetta, imponendo una concretezza che lo smaschera (come somiglia a un suo racconto questo pezzetto di biografia borgesiana!), lo scrittore disse alla sua compagna, con un sorriso (resa all’inevitabile? Altro e altro ancora poteva essere il destino del libro rinnegato, ma il solito intreccio di caso e cause, coincidenza e appuntamento, volontà e fatalità, volle questo esito per la finzione): «Cosa possiamo farci, María, sono perduto!» (si veda l’introduzione a La misura della mia speranza, con una nota al testo di Antonio Melis, Adelphi, Milano 2007).
Addirittura perduto: ma perché? Forse qualcosa, nel ’71 e partendo dai lidi dei vent’anni, era prepotentemente tornato per rivendicare un volto e un senso, mettendo in crisi un approdo a cui Borges si teneva saldo? Guardiamo: nel Cammino della mia speranza, il nostro Jorge, tanto per cominciare, strepita di ebbrezze e furie giovanilistiche, è impetuosamente guerrigliero, come l’età comanda. Insomma, va all’assalto del cielo e delle terre emerse o sommerse, talvolta costeggia l’enfasi, regola fieramente i conti con la coeva cultura argentina tranciando giudizi sommari, ha toni beffardi, provocatori, insolenti. E poi è tutt’altro che occidentale ed europeo: men che meno ha i tratti dello scrittore cosmopolita, curioso e sapiente esploratore di ogni sorta di cultura.
È argentino fino al midollo, celebra la pampa sconfinata, i poeti dei sobborghi come Evaristo Carriego, il quartiere di Palermo dove visse da bambino, con i cortili invasi da immense notti di luna, la baldanza dei compadritos, lo spirito creolo, i vecchi tanghi che erano uno sfacciato alfabeto erotico e identitario, alla faccia dell’Europa senescente e querula. Il giovane Borges lancia veri e propri appelli patriottici: «È ai criollos che voglio parlare: agli uomini che in questa terra si sentono vivere e morire, non a quelli che credono che il sole e la luna si trovano in Europa. È una terra di esiliati nati, questa, di nostalgici di quanto è lontano e straniero: sono quelli i veri gringos, che il loro sangue lo avvalori o meno, e con loro la mia penna non parla. Voglio conversare con gli altri, con i ragazzi attaccati a questa terra e nostri, che non sminuiscono la realtà di questo Paese. Il mio argomento di oggi è la patria: ciò che vi è di presente, di passato e di futuro». E ancora: «Ormai Buenos Aires, più che una città, è una nazione, e bisogna trovare la poesia e la musica e la pittura e la religione e la metafisica adatte alla sua grandezza. Questa è la misura della mia speranza, che ci invita tutti a essere dèi e a lavorare alla sua incarnazione. Non mi piacciono il progressismo e il criollismo, nell’accezione corrente di queste parole. Il primo è un ridursi a essere quasi nordamericani o quasi europei, un intestardirsi a essere quasi altri; il secondo, che un tempo fu parola d’azione […], oggi è parola di nostalgia».
Un Borges, insomma, chiuso nella sua argentinità? Un momento: è vero che il Nostro, trasformandosi in una sorta di inquisitore, condannò al rogo questa e altre sue opere, ma è altrettanto vero che il criollismo, e cioè l’identità creola, le rivendicate radici latino-americane, debbono essere capaci di «conversare sul mondo e sull’io, sulla vita e sulla morte». Insomma, già da allora il “nazionalista” Borges ha ben chiara una cosa: si è universali non sciogliendosi in un magma di indifferenziate suggestioni o sterili mode, ma solo se e quando ci si riconosce in un radicamento, in una storia, in una appartenenza, in un paesaggio con figure, in miti e riti di fondazione. Si è universali, e dunque si può conversare con gli altri, solamente se possediamo una lingua, una cultura, una tradizione. Un volto speciale, particolare. E una geografia, con tutti i suoi atlanti, con i tanti paesaggi in cui ti avventuri, affascinato ma senza guida (o con troppe guide).
Nell’intricata mappa argentina compaiono «due realtà di un’efficacia reverenziale», che nulla hanno a che fare con il progresso e la modernità, ma che vanno riscoperte proprio nella loro genuina forza primitiva. La pampa, «parola infinita» e «sacrario», il luogo dei gauchos irriverenti e coraggiosi, delle leggende e dei coltelli che brillano alla luce lunare. I sobborghi, labirinti di strade addolciti dalle penombre e dai crepuscoli: il luogo dei compadritos, «con i capelli schiacciati e il fazzoletto di seta e le scarpe rialzate e l’andatura curva e lo sguardo travolgente». Qui è nato il tango, non quello «fatto a forza di tratti pittoreschi», ma l’altro, meravigliosamente nudo e crudo, che è un’esplosione «di pura sfacciataggine, di pura spudoratezza, di pura felicità».
Un giovane Borges “avventuroso” è quello che, nella Misura della mia speranza, scrive di pampa e periferie, aprendo alla loro “contaminazione” nazionalpopolare l’educazione elitaria che lo ha nutrito. Ma non c’è da stupirsi, se si tiene conto che per lui «ogni avventura è una norma a venire». Quanto alle amate e celebrate metafore, si tenga conto che esse investigano il reale, assimilandone e rappresentandone l’espressiva quintessenza. Nessun contrasto, poi, con l’ordine, cui non teme di richiamarsi: «L’Avventura e l’Ordine… A me piacciono entrambe le discipline se c’è eroismo in chi le segue».
Come è bello questo aprirsi, questo dilatarsi del cuore in puro candore, in calda schiettezza, abbracciando l’et et che sgomenta i conformisti! E poi ancora vien da pensare al gentiluomo alto-borghese, all’uomo colto, “civile”, allo splendido conversatore, che, in sodalizio col doppio dell’Omero bonaerense, sfida a ogni possibile, smoderato paradosso… E “vediamo” così il bibliotecario vagante col bacolo incerto e magari tremolante, mentre sparge qualche lacrima – salata e dolcissima perché la nostalgia del non vissuto alleggerisce comunque il peso del rimpianto – per il destino del guerriero, che «non fu suo».
Solo complicità letterarie con l’uomo della notturna lama scintillante, con la tigre dagli occhi e dagli artigli che ardono, con la notte trapunta dai segni plurali delle stelle dove, soldato e/o bandito, corri braccato dal nemico e poi ansante cedi alla fatica, seminando nel buio mozziconi di parole, bagliori d’intenso affanno. Quanto ti/ci sono mancati, bianco e gentile Maestro cieco, gli occhi di quel destino! Eppure, vogliamo bene – un bene struggente, e grato, e memore – al gentiluomo vestito di lino bianco, appoggiato al suo bastone, che affabile e cortese saziò il nostro intelletto (e cuore) investigante. Aiutandoci a capire. Possiamo dirlo: sappiamo e saggiamo i suoi orizzonti.
“Conosciamo” Borges. E capiamo, in eletta sintonia di emozioni se non di affetti, l’Argentino che scrive: «Ormai le strade di Buenos Aires / sono le viscere dell’anima mia», «la città vive in me come un poema / che non m’è riuscito di fissare in parole», «Buenos Aires è lì. Il tempo che agli umani / reca l’amore e l’oro, m’offre appena in retaggio / questa rosa smorzata, questo intrico selvaggio di strade che ripetono i nomi ormai lontani / del mio sangue». Il sangue, i nomi che sono numi e insegne, le eredità molteplici del multiforme ingegno. Ripensiamo a Borges, l’Argentino, che ci parla dei suoi maiores e li evoca, attingendo al “profondo”. Il suo, il nostro. Il profondo e l’alto, dunque.
Li racconta la confessione carnale e complice che non esita a addentrarsi nel “sublime”, anche se sa che il “ridicolo” è lì, prossimo, e strizza gli occhietti dissacranti, perché tutto va ridotto ai minimi termini nel mondo che ha schifo degli eroi. Non Borges, l’estraneo che tanti vezzi modaioli hanno provato ad accarezzare, solleticati/sollecitati dal profilo “suggestivo”. Borges, amaro e ironico testimone. Fino alla fine devoto agli auctores e ai libri che sono l’universo e lo raccontano per sempre: l’Edda e l’Eneide, la Divina Commedia e il Don Chisciotte, le tragedie di Shakespeare, le poesie di Shelley, la filosofia di Schopenhauer.
Lo ricordo, il Maestro Molteplice, mentre mi spiega sorridendo cos’è veramente il tango (incontro d’amore e sfida alla morte, rito e mito terragno, esplosione di sensi che le figure plasmano) e subito dopo mi ripete con commozione: «Civis romanus sum», «le mie notti sono piene di Virgilio», «il latino è l’idioma del marmo. Una lingua che può essere incisa nel marmo è una lingua eterna». Amici, proviamo a parlarla.






































